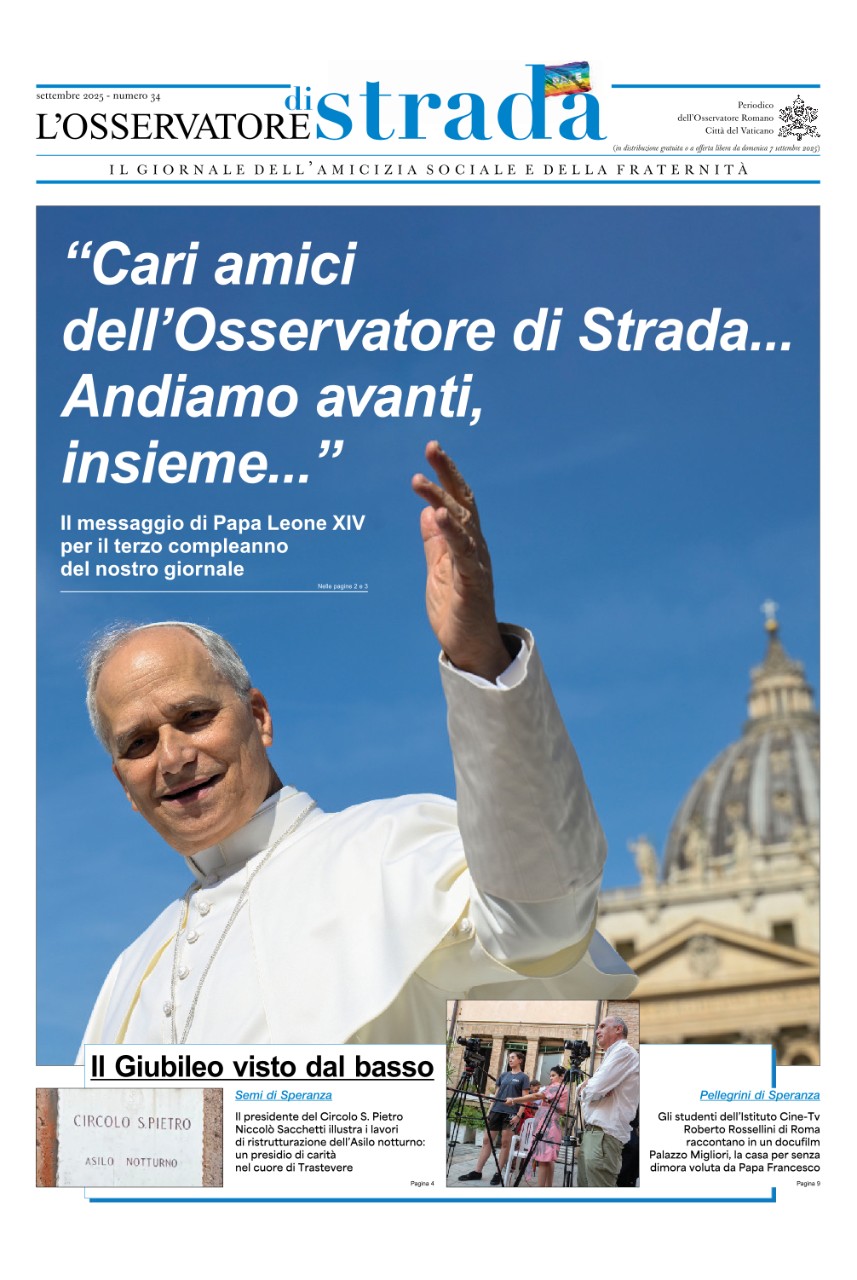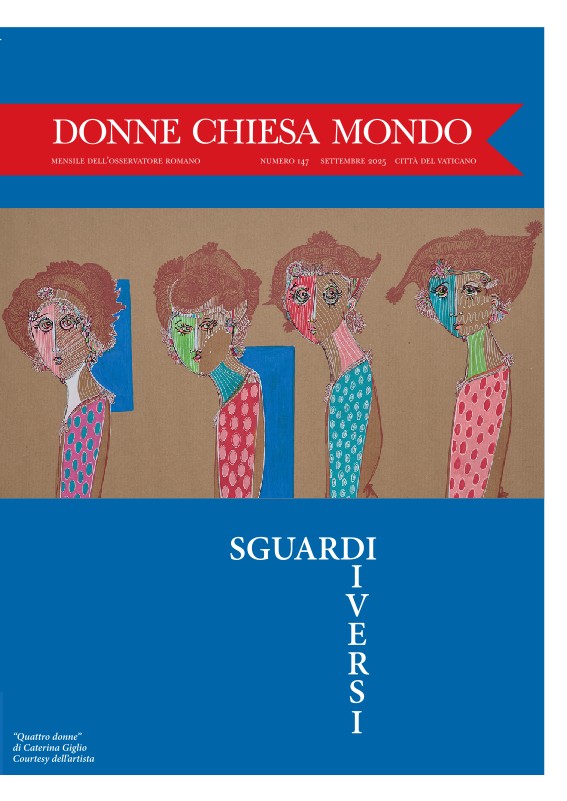I semi teologici di Papa Francesco/2 - Il discernimento
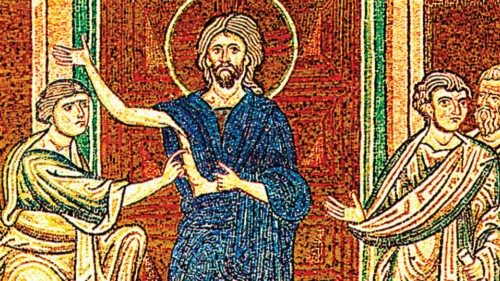
«Per diventare uomini del discernimento, bisogna essere coraggiosi, dire la verità a se stessi. Il discernimento è una scelta di coraggio, al contrario delle vie più comode e riduttive del rigorismo e del lassismo». Con queste parole Papa Francesco descrive uno dei concetti chiave della sua visione teologica: il discernimento. «Oggi la Chiesa ha bisogno di crescere nel discernimento» afferma Bergoglio. Abbiamo chiesto al gesuita Giacomo Costa, direttore della celebre rivista «Aggiornamenti Sociali» fino al 2021, di spiegarci meglio questo concetto e la sua dimensione ecclesiale. Costa è stato nominato da Papa Francesco segretario speciale del Sinodo dei vescovi sul tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”.
Discernimento: potremmo quasi dire che è una parola “di moda”. Eppure il suo significato non è sempre chiaro. In sintesi come possiamo spiegare che cos’è il discernimento?
È vero: Papa Francesco ne parla da dieci anni, fin dall’esortazione apostolica Evangelii gaudium, ma il discernimento resta un oggetto “misterioso”, che suscita anche dubbi e paure. Anche per questo il Santo Padre ha voluto dedicarvi le catechesi del mercoledì del passato autunno e inverno. In sintesi, discernimento vuol dire vagliare le alternative per individuare la migliore e decidere di metterla in atto. Ma più in profondità, discernimento indica quell’atteggiamento interiore di ogni credente, che si chiede che cosa fare per compiere la volontà di Dio. È la domanda fondamentale dei discepoli del Signore, che riempie la vita di tanti santi e li spinge a compiere imprese impensate ed eroiche. In questo senso, possiamo dire che il discernimento è un atto di fede. Per discernere bisogna credere in un Dio la cui volontà per i suoi figli è la pienezza della gioia, come insegna il Vangelo di Giovanni. Poi bisogna credere che nella vita è possibile essere felici: quanti sono quelli che non ci credono e rinunciano a cercare la felicità! Infine, bisogna credere che ogni persona ha la capacità di scoprire la volontà di Dio, accoglierla e metterla in atto: magari le costerà fatica, o avrà bisogno di accompagnamento, ma ce la può fare. Così, nel discernimento è in gioco il senso profondo della nostra vita. Per questo è riduttivo pensare che si tratti di una tecnica per risolvere problemi o gestire processi decisionali, di un percorso di accettazione di sé o di pacificazione interiore: obbliga infatti la persona a confrontarsi con se stessa, con la realtà e con Dio, e poi — ma soprattutto! — a mettersi in movimento per dare attuazione pratica alle decisioni prese.
Quindi discernimento non è neanche il nome di un percorso di autoconsapevolezza?
L’autocoscienza ha una grande importanza: quanto più una persona ha consapevolezza della proprie qualità dei propri doni, ma anche dei propri limiti, tanto più il suo discernimento risulterà efficace. Lo stesso vale per la consapevolezza delle dinamiche della realtà in cui si tradurranno in atto le decisioni prese. Ma non possiamo dimenticare che il discernimento è un atto della coscienza, nel senso profondo e bellissimo che a questo termine dà la Gaudium et spes: quel luogo intimo in cui la persona è sola con Dio e sente risuonare la Sua voce. Il discernimento non lo si fa mai da soli, ma sempre in dialogo con Dio, in ascolto della sua Parola e della voce dello Spirito Santo, all’interno di una comunità e di una tradizione che sostengono e accompagnano la persona in questo cammino. Ma forse è proprio questa la forma più radicale di autocoscienza, che conduce la persona a scoprire che l’identità si gioca sempre nelle relazioni, in particolare in quelle più fondamentali, a partire da quella con Dio.
La posta in gioco è davvero alta: quali sono i rischi o gli equivoci che minacciano la pratica del discernimento?
Minaccia il discernimento tutto ciò che allontana la persona dalla propria coscienza, nel senso sopra ricordato: quindi l’autoreferenzialità, una ricerca superficiale di emozioni che ostacola il movimento verso l’interiorità, la dipendenza da altri (un guru, una moda, un’ideologia…) o una osservanza estrinseca delle norme senza un reale ascolto della vita. Ugualmente minaccia il discernimento l’immagine di un Dio padronale o invidioso, che non vuole la felicità dei suoi figli: è l’idea che il serpente ha insinuato a Eva nel giardino, e che prova a insinuare a noi oggi. Poi non possiamo dimenticare la mancanza di libertà interiore, che trasforma il discernimento da ricerca della volontà di Dio a tentativo di giustificare scelte prese a prescindere da Lui. E poi c’è un rischio molto diffuso: quello del discernimento “monco”, che identifica la direzione in cui andare, ma non muove mai il primo passo, rimanendo così una teoria.
Ha parlato di libertà interiore. Ma la psicanalisi nel secolo scorso, come oggi le neuroscienze, sembrano restringere lo spazio del libero arbitrio. Che senso ha il discernimento se i nostri comportamenti sono l’esito di condizionamenti di ogni genere?
Parlare di libertà non significa misconoscere i condizionamenti. Anzi, scoprirli è parte del lavoro fondamentale dell’autoconsapevolezza e la migliore conoscenza del funzionamento del cervello che il progresso delle scienze produce è un contributo insostituibile. Tuttavia le evidenze empiriche non esauriscono il discorso. Occorre piuttosto mettere in dialogo diversi saperi: nessuno può imporre agli altri il proprio punto di vista. Possiamo tranquillamente riconoscere di essere sottoposti a molti condizionamenti, ma questo non elimina lo spazio del discernimento, anzi lo rende ancora più necessario, proprio perché gli impulsi interiori sono tanti, e ci spingono in direzioni diverse. Il discernimento consiste nel diventare consapevoli di queste voci, che spesso ci “agiscono” senza che neanche ce ne accorgiamo. Per questo il Papa dice che si tratta di «togliere il pilota automatico». Il primo passo verso la libertà è divenire consapevoli delle immagini e delle spinte interiori che troviamo in noi, per assecondare quelle costruttive, indirizzate verso la pienezza della gioia promessa da Dio, e respingere quelle distruttive.
Gli apparati digitali, entrati prepotentemente nella vita di tutti, si configurano come “protesi” esterne alle nostre facoltà intellettive. Senza arrivare all’ intelligenza artificiale, di cui trattiamo nella pagina accanto, è opportuna una riflessione sulla relazione tra trasformazioni antropologiche e capacità di discernimento. Per esempio, la nostra memoria oggi risiede in buona parte nei nostri telefonini e non più nel cervello. Come si può discernere senza memoria?
Evidentemente non si può, come in fondo non si può nemmeno vivere. Ma dobbiamo fare attenzione a non alimentare giudizi affrettati e allarmistici sull’innovazione tecnologica a cui oggi assistiamo, che è davvero impressionante. Innanzi tutto, non mi sembra che le capacità umane vengano sostituite dalle macchine, piuttosto cambiano le condizioni in vengono esercitate. E poi dobbiamo fare attenzione all’uso delle parole: un disco rigido o una cloud sono “magazzini di dati”, ma non soppiantano la memoria in senso antropologico. Il lavoro della memoria, infatti, è rielaborare continuamente l’esperienza, scoprendo le connessioni tra i dati e svelandone il senso. Il ricordo di una bella giornata non si riduce ai dati meteo salvati in un computer o al cielo azzurro nelle foto sul telefonino. Senza connessioni, anche affettive, queste informazioni hanno poco significato. Ma l’innovazione tecnologica ha anche un altro impatto: aumenta, spesso a dismisura il numero delle opzioni tra cui scegliere. Possiamo dire che oggi scegliamo molto più che in passato. E la velocità del cambiamento è tale che non possiamo semplicemente attenerci all’esempio delle generazioni precedenti, perché viviamo in un mondo troppo diverso, di cui non abbiamo una mappa. Per muoverci ci serve una bussola, che è proprio il discernimento.
Se il discernimento è così importante per procedere in un modo sempre più complesso non stupisce che su di esso insista Papa Francesco, che ci invita a pensare il mondo come poliedro anziché come sfera. Che cosa comporta questo passaggio per la Chiesa e il suo rapporto con il mondo?
Il passaggio è per certi versi semplice, ma non per questo facile. Pensare il mondo come un poliedro significa accettare che ciò che di esso vediamo dipende dal punto da cui lo osserviamo: da una prospettiva apparirà concavo, da un’altra convesso. Questo significa che ogni punto di vista, compreso quello della Chiesa, deve rinunciare alla pretesa di essere totale e accettare la propria parzialità. Significa anche che ricostruire una immagine completa della realtà richiede il dialogo fra le diverse prospettive, ciascuna delle quali, a partire da quella dei poveri, è portatrice di un contributo insostituibile. Per certi versi, possiamo dire che dialogo è il nome del discernimento quando entra nello spazio pubblico e affronta le dinamiche sociali: comprenderle e quindi capire come intervenire su di esse oggi non è possibile senza convocare la pluralità delle diverse prospettive. In fondo è questa anche la “scommessa” del Sinodo, che ripropone la domanda sulla volontà di Dio: quali passi lo Spirito ci chiede di compiere per poter camminare insieme agli uomini e alle donne del nostro tempo e annunciare loro il Vangelo nel mondo di oggi? Trovare la risposta non può che essere un’azione sinodale, che si mette in ascolto di tutti i punti di vista e articola le differenze, senza arrendersi alla frammentazione né all’omogeneizzazione.
Ma per discernere bisogna essere credenti? In un mondo in cui non tutti lo sono, ma bisogna imparare a camminare insieme, la domanda appare cruciale.
Non possiamo in alcun modo sminuire le peculiarità del discernimento in senso pienamente cristiano, non fosse altro perché può alimentarsi attraverso meditazione della Parola di Dio e la vita sacramentale. Tuttavia non possiamo nemmeno dimenticare che la coscienza non è un monopolio dei credenti, e men che meno dei cristiani. Dio parla nell’intimo a tutti e a tutti formula una promessa di vita a cui affidarsi, a prescindere da una esplicita professione di fede religiosa. Come questa fiducia di base possa costituire il terreno per un discernimento condiviso è quello che oggi siamo chiamati a scoprire camminando insieme.
di Roberto Cetera
Il discernimento in gruppi organizzazioni e comunità
Pubblichiamo alcuni stralci dal volume di Giacomo Costa, Il discernimento (Milano, San Paolo 2018, pp. 141). Il libro fa parte della collana edita dalla San Paolo edizioni dedicata proprio ai semi teologici di Papa Francesco.
Il discernimento interpella la coscienza e l’interiorità, ma non riguarda soltanto ciascuno preso singolarmente. Anche i gruppi e le comunità si chiedono quale sia la volontà di Dio e hanno bisogno di prendere decisioni in una prospettiva di fede. Si apre qui lo spazio del discernimento comunitario o in comune. Il punto di riferimento biblico è senza dubbio il concilio di Gerusalemme, narrato in At 15. L’esigenza di discernimento in comune non riguarda solo determinate categorie (pastori, ministri ordinati, consacrati, ecc.), ma attraversa tutte le realtà ecclesiali o collegate alla Chiesa: dalle strutture come i Consigli (pastorali, presbiterali, degli affari economici, ecc.) a vari livelli, agli ordini e congregazioni religiose (nel loro insieme o nelle articolazioni locali, o negli organi di governo, come capitoli, consulte e consigli, ecc.), alle associazioni e ai movimenti con le loro strutture collegiali di governo, fino alle istituzioni più operative (ospedali, scuole, università, fondazioni, centri di accoglienza, ecc.).
Introdurre in questi contesti la dinamica del discernimento aiuta a mettere a tema il rapporto tra ispirazione e operatività e i criteri con cui si determinano le priorità: come entra in gioco la ricerca della volontà di Dio? Rappresenta un preambolo retorico o un reale pungolo a mantenersi attenti alle novità? Quale attenzione si riserva alla lettura della realtà e dei territori in cui si è inseriti? Lo sguardo è rivolto prevalentemente all’interno o si lascia interpellare dalle prospettive della Chiesa in uscita?
Il discernimento in comune ha però una sua specificità. Non è discernimento ogni processo decisionale, né un confronto più o meno formale su una questione, un brainstorming di gruppo, una semplice consultazione delle opinioni dei membri o un processo di deliberazione mediante il voto a maggioranza. In sostanza, il discernimento in comune non è una tecnica o una procedura formalizzata la cui applicazione garantisce l’esito di un processo decisionale entro tempi prestabiliti: per questo spesso si preferisce prendere altre strade, rinunciando magari all’ascolto profondo della voce dello Spirito. Non è discernimento in comune nemmeno la sommatoria o giustapposizione dell’esito di processi di discernimento personale. Richiede invece che il gruppo o la comunità si riconoscano come un soggetto collettivo dotato di una propria identità, al cui interno tutti i membri trovano posto. Con i termini dell’Evangelii Gaudium, il discernimento in comune si fonda sull'esperienza di «diventare un popolo» (n. 220) e del «piacere spirituale» di esserlo (cfr. nn. 268-274), con tutta la difficoltà che questo comporta in contesti culturali profondamente segnati dall'individualismo.
Se i presupposti di maturità e di libertà interiore sono analoghi a quelli del discernimento personale, il concreto svolgersi di un processo di discernimento in comune presenta ovviamente delle specificità. La più evidente è l’esigenza di integrare, anche nei tempi, l’elaborazione del punto di vista di ciascun partecipante e la capacità di esprimerlo di fronte al gruppo, garantendo un clima di ascolto rispettoso ma anche un autentico confronto tra le coscienze, e l’ascolto del “clima” collettivo oltre che delle mozioni personali dei partecipanti.
Con il rischio di un eccessivo schematismo, possiamo dire che la prima fase è in comune e comprende sia la custodia di una dimensione relazionale (mettersi alla presenza del Signore, fare memoria dei doni ricevuti come gruppo, chiedere la grazia di saper ascoltare la sua voce), sia l’esplicitazione della concretezza dell'obiettivo, a partire dalle informazioni sui dati di realtà. Questo può voler dire ricostruire il profilo delle alternative in tutte le loro dimensioni, anche organizzative, logistiche ed economiche, e acquisire informazioni attendibili sul contesto in cui ci si inserisce.
Questa preparazione, che può richiedere anche una fase di studio o il confronto con esperti, è fondamentale per evitare un processo unicamente istintivo. È indispensabile poi un congruo tempo di ascolto della coscienza, attraverso la riflessione, la meditazione e la preghiera personale. È un errore frequente, dettato dalla precipitazione, passare immediatamente dall’esame dei dati alla discussione. Solo dopo questo tempo di lavoro interiore si riapre una fase per quello collettivo, che deve prevedere e garantire: la messa in comune dell’orientamento di ciascuno, in clima di ascolto e senza dibattito; l’esame in comune di tutto ciò che è emerso, a partire dall’esercizio ascetico di abbandonare l’attaccamento di ciascuno al proprio parere e cercando di riconoscere le posizioni più costruttive attraverso il gioco di consolazioni e desolazioni — ci sono anche quelle di gruppo! —; la formulazione condivisa di indicazioni per la decisione, in modalità consone alle modalità organizzative del gruppo (una associazione di volontariato funziona diversamente da una congregazione religiosa, ad esempio rispetto all’esercizio dell’autorità).
di Giacomo Costa
Leggi anche:
«Il gran catino vuoto» e il potere immaginifico del lettore
di Daniele Mencarelli