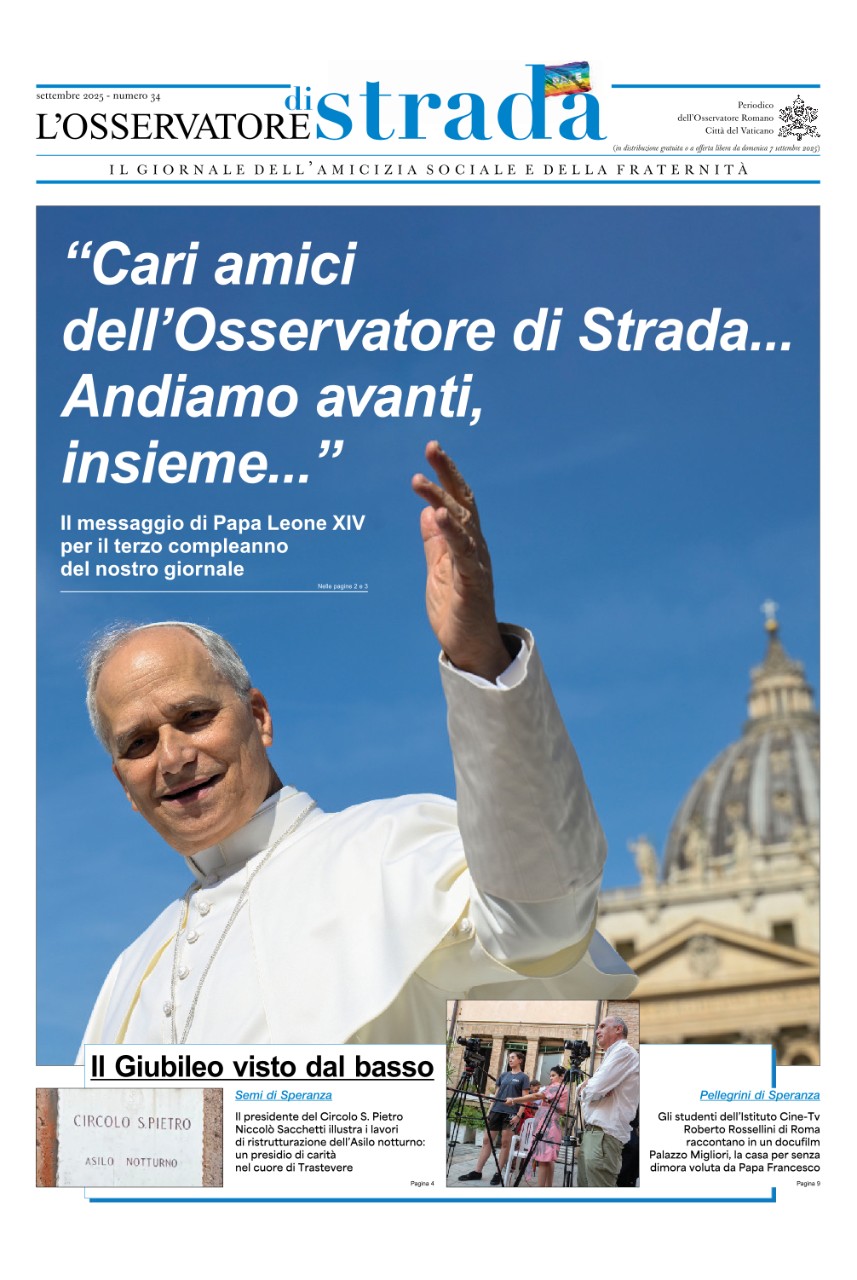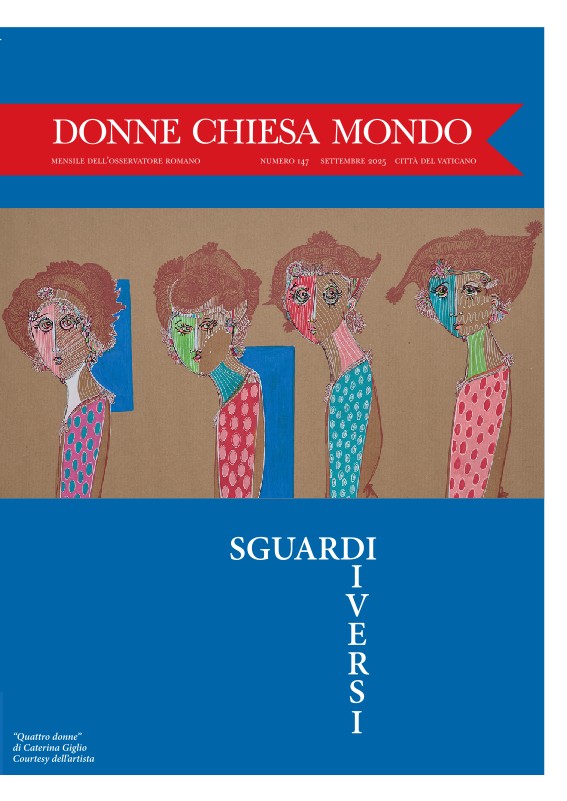«La guerra delle narrazioni

di Guglielmo Gallone
Questa settimana la Cina ha catalizzato l’attenzione internazionale con due eventi: il vertice della Shanghai Cooperation Organization a Tientsin e la parata a Pechino per l’ottantesimo anniversario della fine della seconda guerra mondiale. Hanno partecipato, fra i tanti, il presidente russo, Vladimir Putin, il presidente nordcoreano, Kim Jong-un, e il primo ministro indiano, Narendra Modi. Immagini e parole di intesa hanno alimentato il dibattito su un possibile ordine mondiale alternativo a quello occidentale. Ma qual è il giusto equilibrio tra realtà e narrazione? E come gli scenari geopolitici vengono plasmati dall’economia e viceversa? Ne abbiamo parlato con Giorgio Arfaras, direttore della Lettera Economica del Centro Einaudi dal 2009 al 2020, attivo nel mondo dell’industria e della finanza dal 1982 al 2007, autore di libri fra cui Breve storia dell’economia, in uscita il 23 settembre per Salani Editore.
Le immagini provenienti dalla Cina hanno fatto il giro del mondo e alimentato varie interpretazioni. Lei che idea si è fatto?
Ci sono almeno tre aspetti interessanti. Il primo riguarda la narrazione storica: le potenze emergenti di oggi, che un tempo sono uscite vincitrici contro le forze dell’asse, hanno messo in chiaro di voler affrontare gli altri vincitori delle potenze dell’asse, cioè l’Occidente e in primis gli Stati Uniti. A Pechino è dunque emersa una rilettura della storia da parte delle potenze emergenti. Il secondo aspetto riguarda però il ribaltamento dei ruoli delle potenze emergenti: un tempo era l’Unione Sovietica che proteggeva la Cina e, in qualche misura, l’India. Oggi è la Cina che protegge la Russia. Infine, c’è l’aspetto più importante: la percezione che una potenza ha di sé e dunque il modo in cui un Paese si racconta. Ancor più dopo la parata di piazza Tienanmen, la narrazione che va per la maggiore oggi è che la Cina si sta sviluppando in particolare nel mondo dell’alta tecnologia, basti pensare alle auto elettriche, e che questa ascesa è, citando il presidente Xi Jinping, “inarrestabile”. Un altro racconto è che la Russia non solo resiste alle sanzioni ma, anziché indebolirsi, cresce. Di riflesso, e questo è l’ultimo racconto che oggi tendiamo a fare, l’Europa arranca, non investe nell’alta tecnologia e resta immobile. La realtà, però, è ben diversa.
Quindi la narrazione dominante di oggi sta nascondendo le fragilità di Cina e Russia?
Sì. Dimentichiamo ad esempio che l’economia russa è trainata dalle materie prime non rinnovabili e dall’industria pesante, specialmente quella militare. Tuttavia, Mosca rischia di esaurire presto i fondi che ha accumulato nel corso del tempo e che le consentono di continuare la guerra anche sotto sanzioni dall’estero. Ciò non significa che smetterà di combattere. Piuttosto, bisogna capire come agirà, di fronte a questo rischio, pur di ottenere il massimo dei risultati. Inoltre, le materie prime non rinnovabili hanno sempre meno mercato. Certo, da un lato petrolio e gas vantano ancora larghe fette di mercato, ma dall’altro per vendere gas bisogna fare grandi investimenti — basti pensare ai tubi necessari a realizzare il Power of Siberia 2 — che però richiedono molto tempo e molti soldi. In Cina, invece, c’è un problema di crisi del settore immobiliare che, a sua volta, trascina una crisi finanziaria: la crescita del settore immobiliare è stata infatti portata avanti a debito, non solo tra banche e costruttori ma pure tra banche e famiglie che hanno investito negli immobili. Secondo aspetto: in Cina c’è un investimento colossale da parte di organismi pubblici sui fondi di investimento che aiutano imprese dinamiche a crescere. Il problema è che questi fondi stanno generando una concorrenza a tratti eccessiva tra le imprese. Il risultato finale è o una crescita minore di quella che si avrebbe normalmente, oppure la crescita isolata ad alcune aziende. Terza sfida per la Cina: passare in così pochi anni da un’economia agricola a un’economia industriale a un’economia dei servizi. Economia industriale significava portare milioni di persone nelle città, investire nei macchinari e sostenere l’occupazione, quindi avere economie di scala. L’economia dei servizi è tutt’altra storia. Nel caso dei servizi non si può avere un’esplosione della crescita simile.
Lei ha menzionato un ruolo crescente dello Stato nell’economia in Cina. Ma questo lo stiamo vedendo, di recente, anche negli Usa e in Europa. Pensiamo ai dazi o ai piani industriali. Quali sono i risultati in questa parte di mondo?
Anzitutto, per rispondere dobbiamo ricordare che in Occidente c’è un sistema liberale, ossia un mercato libero dall’intervento dello Stato e un sistema di democrazia rappresentativa. Questa libertà di mercato era stata portata all’estremo dal mondo neoliberista, avviato da Margareth Thatcher e Ronald Reagan, e si basava sulla convinzione che il mercato fosse capace di autoregolarsi. Di conseguenza, l’intervento dello Stato doveva e poteva essere ridotto al minimo per favorire i comportamenti privatistici e per avere una crescita significativa. Questa ideologia non ha funzionato. Anzitutto, perché il taglio della spesa pubblica oltre certi limiti è impossibile: il consenso politico si basa proprio sulla spesa pubblica. Poi, perché il ritiro dello Stato come proprietario di imprese c’è stato, basti pensare alle privatizzazioni, ma da un certo momento in poi ha iniziato a frenare. In una serie di settori si è pensato che le aziende potessero riprendersi solo con una spinta da parte del pubblico, diretta o indiretta. Tutto ciò si sta palesando oggi negli Stati Uniti più che in ogni altro Paese. Qui c’è un triplice intervento da parte dello Stato: la fiscalità ridotta, introdotta dall’ex presidente, Joe Biden, con gli sgravi fiscali per chi investe negli Usa; l’intervento dello Stato nelle imprese in difficoltà momentanea, basti pensare agli sforzi di Donald Trump verso il gigante tecnologico Intel; infine, i dazi. In sostanza, negli Usa il ritorno dello statalismo è evidente: è finito il periodo in cui si credeva che lo Stato potesse definitivamente ritirarsi.
Soffermiamoci allora sull'Europa, che sembra schiacciata tra il modello americano e quello cinese. Come mai?
Qui c’è una spiegazione di natura più politica che economica. Qualche anno fa, un brillante economista francese, Thomas Philippon, nel libro “The Great reversal” si domandò perché i prezzi dei beni e i profitti delle aziende sono più alti negli Usa rispetto all’Europa. Egli dimostra come il livello dei prezzi maggiori, così come dei profitti maggiori, dipende dal livello di concentrazione delle imprese, che negli Usa è molto elevato. Cioè, le imprese, se lasciate concentrare, creano uno sviluppo economico più alto di quello che si avrebbe con una minore concentrazione industriale. In Europa questo non avviene per tre motivi: l’antitrust funziona, non crediamo che le grandi imprese siano grandi trascinatori di crescita e, infine, il motivo più credibile, nessun Paese vuole che esista il campione nazionale di un altro. Cioè, i francesi non vogliono la grande azienda tedesca e viceversa. Di conseguenza, l’Ue non fa nascere grandi concentrazioni di imprese. Quello che ha detto Mario Draghi a Rimini, cioè dotarsi di grandi imprese europee capaci di trascinare la modernizzazione nell’alta tecnologia, presume un cambiamento di natura politica secondo cui diversi Paesi europei debbono rinunciare a essere nazioni e riunirsi in un’idea europea. Comprensibile, ma piuttosto complesso.
Tuttavia, l’Unione europea negli ultimi anni sta cercando di farsi sentire di più a livello centrale. Pensiamo al Recovery Plan o agli sforzi per ridurre l’inquinamento. Il problema è che, per quanto siano nobili gli obiettivi, i risultati sono spesso deludenti. Come mai?
Perché esiste e dobbiamo accettare il principio di fallibilità: se non partiamo da questo, osserviamo il mondo in modo completamente sbagliato. Poi, c’è la ricerca del consenso che, di nuovo, si basa sul concetto della narrazione. Dieci anni fa, quando è esplosa l’idea dell’ecologia, tanto la politica quanto le imprese e l’elettorato si sono iniziate a impegnare per il rispetto dell’ambiente, avviando in pochissimo tempo la riconversione totale di certi settori economici. Io non dico che le narrazioni siano sbagliate. Dico però che dovremmo mettere in conto i modi in cui si gestiscono eventuali contraccolpi delle narrazioni. Ciò non mi pare stia avvenendo. Basti pensare al settore automobilistico, cui è stata imposta una totale riconversione in pochi anni nonostante sia il motore trainante dell’Europa.
Lei ha dedicato il suo ultimo libro alla storia dell'economia. Di fronte al cambiamento d’epoca che stiamo vivendo, come sta cambiando l'economia?
Direi che ci sono tre grandi cambiamenti. Il primo: negli anni la costruzione del consenso politico ha creato un debito pubblico enorme che, per essere ripagato sotto forma di interessi, richiede somme altrettanto enormi. Il risultato è che oggi non si riesce a tagliare la spesa pubblica e ad alzare le entrate: il debito pubblico è fuori controllo e l’onere è sempre crescente. Questa non è una cosa da poco. Il secondo cambiamento è quello cui facevamo cenno: un maggiore intervento diretto dello Stato nell’economia. Infine, l’ultimo cambiamento riguarda il modo in cui viene percepito lo Stato sociale: nei Paesi dove non c’è Stato sociale, c’è un grande risparmio che si riversa in grandi investimenti, persino eccessivi, capaci però di mutare l’immagine che uno Stato ha e dà di sé; nei Paesi dove lo Stato sociale c’è, invece, spesso non lo si riesce a controllare e questo può diventare un problema.