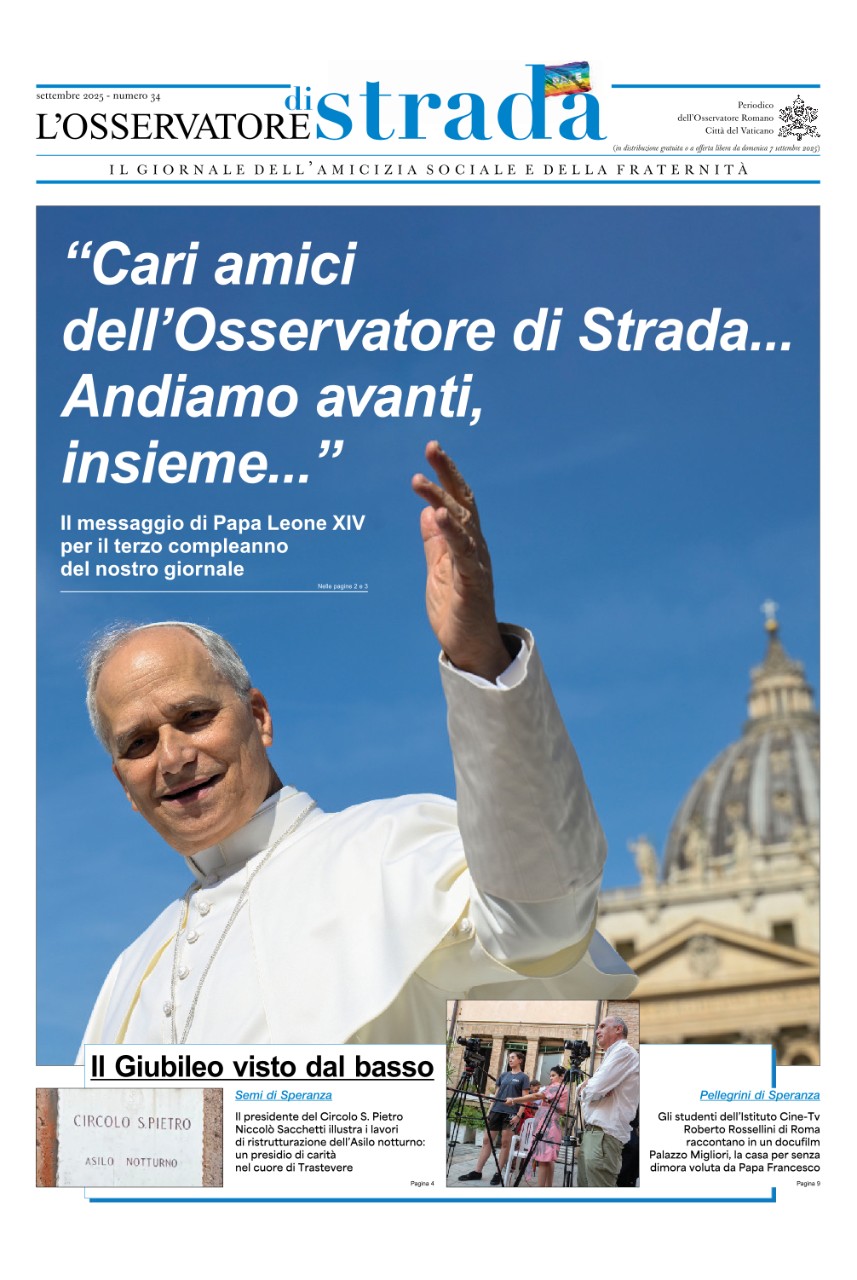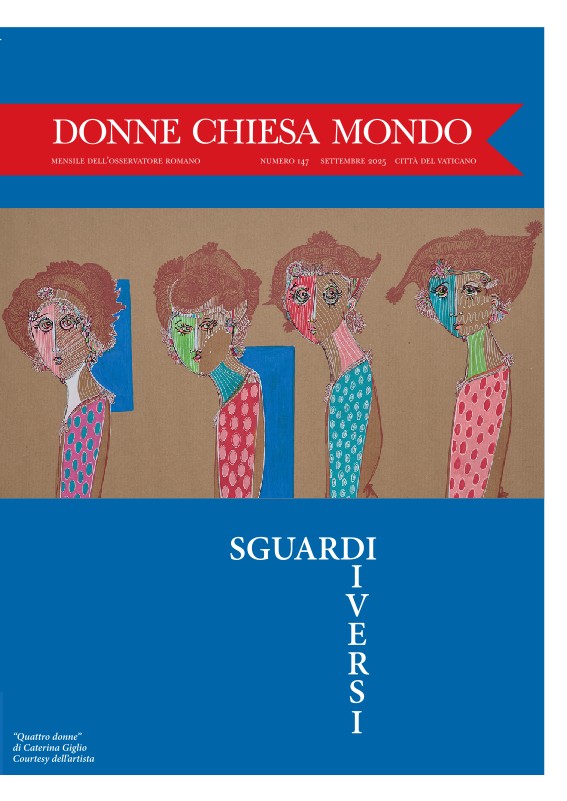di Riccardo Saccenti
Il 9 maggio 1948 l’Assemblea plenaria del Congresso del movimento federalista europeo, riunito all’Aja, discute e adotta il progetto di risoluzione steso dalla Commissione culturale. Si tratta di una delle tre risoluzioni, assieme a quella politica e a quella economica, che tracciano le linee di un progetto di un’unità fra i Paesi europei che ancora hanno a che fare con le macerie morali, sociali e materiali e del secondo conflitto mondiale. A prendere la parola per dare voce alla delegazione francese è Étienne Gilson, che si sofferma sulla questione di fondo di cosa sia, dal punto di vista della sua identità culturale, l’Europa.
«Si è parlato molto — notava il filosofo francese — dell’uomo europeo, della cultura europea. Ci siamo chiesti che cosa sia e che cosa non sia. Siamo tutti d’accordo nel dire che non è facilmente definibile, ma che siamo certi che essa esista». Sono considerazioni che non si limitano a fare sintesi delle molteplici sensibilità culturali che animano la delegazione francese al congresso dell’Aja. In esse si ritrova un elemento caratteristico del contributo intellettuale di Gilson, che attraversa tutta la sua opera di filosofo, di storico della filosofia, di uomo di cultura e di politica.
L’esistenza di una cultura europea e il riconoscimento dei suoi tratti distintivi possono essere assunti come i punti di riferimenti che, col tempo, guidano e orientano la ricerca gilsoniana, che si muove sul terreno della filosofia e del suo sviluppo storico, ma colto e inteso dentro il più ampio perimetro del pensiero.
Se gli inizi di questa biografia intellettuale si trovano nello studio di Cartesio e della sua filosofia, dentro un filone di studi che ancora riflette una divisione per nazioni della vicenda storica del pensiero europeo, gli sviluppi portano alla scoperta di una realtà storica che ha invece un imprescindibile connotato europeo. Proprio l’indagine sulle fonti del filosofo del Discours de la méthode apre le porte ad una comprensione della ricchezza di pensiero di secoli, quelli medievali, nei quali la vita intellettuale mette assieme figure e biografie di estrazione geografica e linguistica diversa, per le quali però l’atto del pensare e le forme con cui questo viene praticato dicono l’appartenenza ad una medesima comunità umana.
È questa la prospettiva storiografica che è alla radice delle grandi opere che Gilson dedica al pensiero medievale e della sua lettura della storia della filosofia come un itinerario unitario che, dal tardoantico arriva alle soglie del Rinascimento, prima cioè della divisione in stati nazionali. Eppure il medievalismo di Gilson non è solo un richiamo nostalgico ad una civilizzazione europea segnata da un fruttuoso dialogo fra l’eredità filosofica antica e la sensibilità religiosa cristiana. Piuttosto, per lo studioso francese, nella contemporaneità del Novecento delle guerre mondiali e dei totalitarismi si fa sempre più urgente il contributo delle donne e degli uomini di pensiero, soprattutto in Europa. Essi sono chiamati a rendere riconoscibile quella cultura europea che, per sua natura, non può essere ben definita perché muta, evolve, si arricchisce di valori e di scoperte col procedere della propria storia. È quanto emerge in modo chiaro dai lavori che Gilson dedica, lungo tutto l’arco della propria esistenza, alla letteratura e che ora sono raccolti nel terzo tomo dell’edizione delle opere complete del filosofo, dal titolo Littérature et philosophie. Travaux sur les lettres et l’histoire de la pensée (Parigi, Vrin, 2025, 1430 pagine, euro 49.50 euro) a cura di Iñigo Atucha e Ruedi Imbach.
A partire dai primi anni Venti del Novecento, accanto ai grandi testi dedicati ai pensatori del Medioevo, Gilson interviene su una pluralità di tematiche culturali, soprattutto connesse alla frequentazione di opere letterarie. Ne danno conto i numerosi contributi pubblicati su riviste culturali e su quotidiani e soprattutto cinque volumi nei quali ci si misura con l’intreccio fra letteratura e pensiero, con il carteggio fra Eloisa e Abelardo, con le opere di Dante e con il topos letterario e culturale delle muse ispiratrici di artisti come Petrarca, Baudelaire, Wagner. Sono testi che restituiscono la qualità dell’inserimento di Gilson nella vita culturale del proprio tempo, mostrandone la capacità di seguire le elaborazioni intellettuali anche al di là dei confini della filosofia.
Soprattutto, si tratta di scritti nei quali si coglie quella che è forse la cifra profonda dell’approccio di Gilson al suo lavoro di storico: la convinzione che fra il pensiero e la realtà a cui questo si applica sia la seconda a mantenere un primato. Rispetto ad un modo di praticare gli studi che circoscrive un frammento della realtà e lo assolutizza, congelandolo, per così dire, in una nozione statica e disincarnata dalla storia, Gilson insiste sul fatto che uno sguardo attento alle tante forme di espressione dello spirito umano che emergono nella letteratura come nella filosofia, relativizza ogni categoria. Così, una riflessione sulle nozioni di “umanesimo medievale” e “Rinascimento” sviluppata nelle pagine di Les idées et les lettres, volume del 1932, è l’occasione per precisare la storicità e dunque la relatività di queste nozioni, le quali devono essere sempre discusse a partire da ciò che emerge dalla realtà alle quali si vogliono collegare. Questo, che appare come un esercizio critico relativo al lavoro dello storico e alla strumentazione concettuale di cui egli si serve, è in realtà un criterio di valutazione più generale, di carattere squisitamente filosofico, trasversale a ogni esperienza culturale. Perché, come osserva Gilson: «la continuità del reale non si lascia facilmente frammentare in pezzi distinti come i nostri concetti».
Questa convinzione, che guida tutta la produzione intellettuale di Gilson, è al centro anche del suo impegno politico e delle parole con cui, all’Aja, offre un contributo a riflettere sull’orizzonte politico comune per l’Europa. È il punto di vista del realista sulla storia che rende evidente, agli occhi del filosofo, l’inconsistenza di concezioni che avevano assolutizzato la nazione come fatto disincarnato, che si voleva assoluto, quasi fosse il culmine dell’esperienza umana. Nella comune vicenda di tedeschi, francesi, italiani, spagnoli, inglesi si trovano i tratti di una cultura comune, di quell’Europa che vive dell’apertura all’altro, di un universalismo che è quello di chi non impone il proprio punto di vista ma resta aperto a dare e ricevere da tutti.