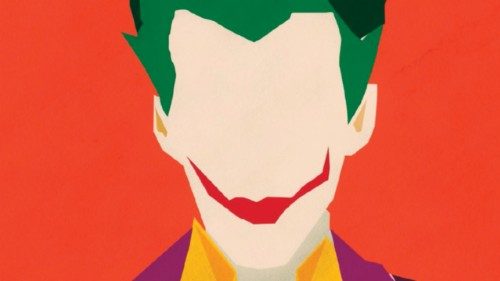
di Fabio Colagrande
Nella sua narrazione della Passione, l’evangelista Luca racconta che i capi del Sinedrio e lo stesso Erode deridono più volte Gesù. Nel Salmo 22, il 21 secondo la tradizione greco-latina, tra i più pregati di tutto il Salterio, un innocente perseguitato, che si lamenta con Dio per essere stato abbandonato, specifica: «Si fanno beffe di me quelli che mi vedono». Bisognerebbe forse partire da qui, da questo esplicitarsi diabolico della risata nella Bibbia, per un’interpretazione in chiave cattolica del saggio di Guido Vitiello Joker scatenato. Il lato oscuro della comicità (Milano, Feltrinelli, 2025, pagine 171, euro 17).
Primo Pontefice nella storia a incontrare gli artisti del mondo dell’umorismo in Vaticano, nel giugno 2024 Papa Francesco lodava la loro capacità di non offendere, non umiliare, non inchiodare le persone ai loro difetti. Ma alla sua sacrosanta consacrazione della virtù spirituale e civile dell’umorista che — come ricorda Vitiello — «sa dirigere la lama (del comico) su di sé o la brandisce contro l’assurdità della condizione umana» si contrappone, sul fronte opposto, il «sarcasmo» che etimologicamente «lacera le carni». L’autore, un napoletano che insegna Teorie del cinema e dell’audiovisivo alla Sapienza di Roma, ci tiene insomma a ricordarci qualcosa che abbiamo colpevolmente dimenticato e cioè che «la comicità ha un legame antico e indistricabile con la violenza». Ma soprattutto che il nostro Occidente moderno — liberatosi gradualmente dai «tabù arcaici, dai gioghi ecclesiastici e dalle censure statali», fino a uccidere la Quaresima e a «rovesciare dal piedistallo la maiuscola suprema, Dio» — vive oggi in un sinistro «carnevale perpetuo».
Simbolo di quest’era dove la risata, liberata improvvidamente da ogni freno, mostra ormai anche il suo lato insocievole e distruttivo, è la nemesi di Batman, il supereroe dei fumetti, difensore della legge nell’immaginaria Gotham City, e cioè il pagliaccio malefico e supercriminale Joker, nato alla fine degli anni Trenta, proprio «all’alba della nuova era del divertimento». Per Vitiello è questo «Mefistofele cristiano», che «coltiva un rapporto geloso e maniacale con i mezzi di comunicazione», la figura della cultura popolare che può aiutarci a «fare i conti con il versante distruttivo della comicità e del riso nella società dell’amusement permanente». Ed è stata la sua progressiva liberazione ad aver scatenato il riso disgregatore.
L’autore inizia da qui un viaggio estetico nel tempo inedito, spericolato e coinvolgente, supportato da una straordinaria bibliografia, che parte dalla Rivoluzione francese, passa per L’uomo che ride di Victor Hugo, per i dadaisti del Cabaret Voltaire frequentato a Zurigo da Lenin, le caricature antiebraiche dei nazisti, il Doctor Faustus, la filosofia di Adorno (che inquadra la tendenza di ogni risata collettiva a sfogarsi su un capro espiatorio), il pensiero di Elias Canetti («si ride invece di divorare»), i riti “sciamanici” della stand-up comedian Lenny Bruce, per arrivare al Joker assassino, simbolo della rivolta al sistema, interpretato da Joaquin Phoenix nell’omonimo film di Todd Phillips del 2019. Non manca un accenno alla degenerazione della baldoria del Futurismo nella retorica della guerra «sola igiene del mondo», che mostra l’inquietante nesso fra l’odierno «carnevale perpetuo» e la violenza bellica.
Ma il capitolo del saggio di Vitiello che meglio fotografa le contraddizioni socio-politiche attuali è quello che indaga il percorso dalla «tirannia dei buffoni» alla «buffoneria dei tiranni». A partire dal comico statunitense Will Rogers, che nel ’28 si candida per scherzo alle presidenziali, l’autore cita il caso analogo del clown francese Coluche nel 1980, la discesa in politica del cabarettista Beppe Grillo in Italia, nel 2008, l’elezione alla guida del suo Paese del comico ucraino Zelenskij nel 2019 e altri casi, in tutto il mondo, in cui «la sostituzione farsesca del Buffone al Re è diventata un affare serissimo». Ma «dal canto loro — spiega Vitiello — i sovrani hanno preso a comportarsi come buffoni alla propria stessa corte» per «contrastare il malocchio, minaccia invisibile che nell’era della televisione e della democrazia di massa ha preso il nome di antipatia degli elettori». Citando la parabola del pioniere italiano Silvio Berlusconi, «il primo a cumulare in una sola persona la responsabilità di fatto del leader politico e l’irresponsabilità di diritto del giullare», diventando inattaccabile, il saggio fotografa con impressionante nitidezza la figura dell’attuale presidente Usa Donald Trump che, come scriveva David Brooks sul «New York Times» nel 2017, «esiste su due piani: il piano presidenziale e il piano del fool. Sull’uno prende decisioni personali e di altro tipo. Sull’altro, twitta».
Ma al di là della politica, su tutto il saggio di Vitiello aleggia la risata del Joker: sia nella versione del “tutti contro uno”, che ricorda il sopra citato scherno che ricopre il Cristo pharmakos, sia in quella del “tutti contro tutti” del pollaio dei social dove «ciascuno è libero di proiettare sulle parole dell’altro l’immagine riflessa della propria collera, di attribuire all’interlocutore intenzioni di ostilità o di scherno». Un ghigno pervasivo in fondo demoniaco, sfogo del nostro lato oscuro che dobbiamo imparare a riconoscere e a evitare, sembra ammonirci l’autore, ritrovando, ogni tanto, i tempi catartici del silenzio quaresimale.


















