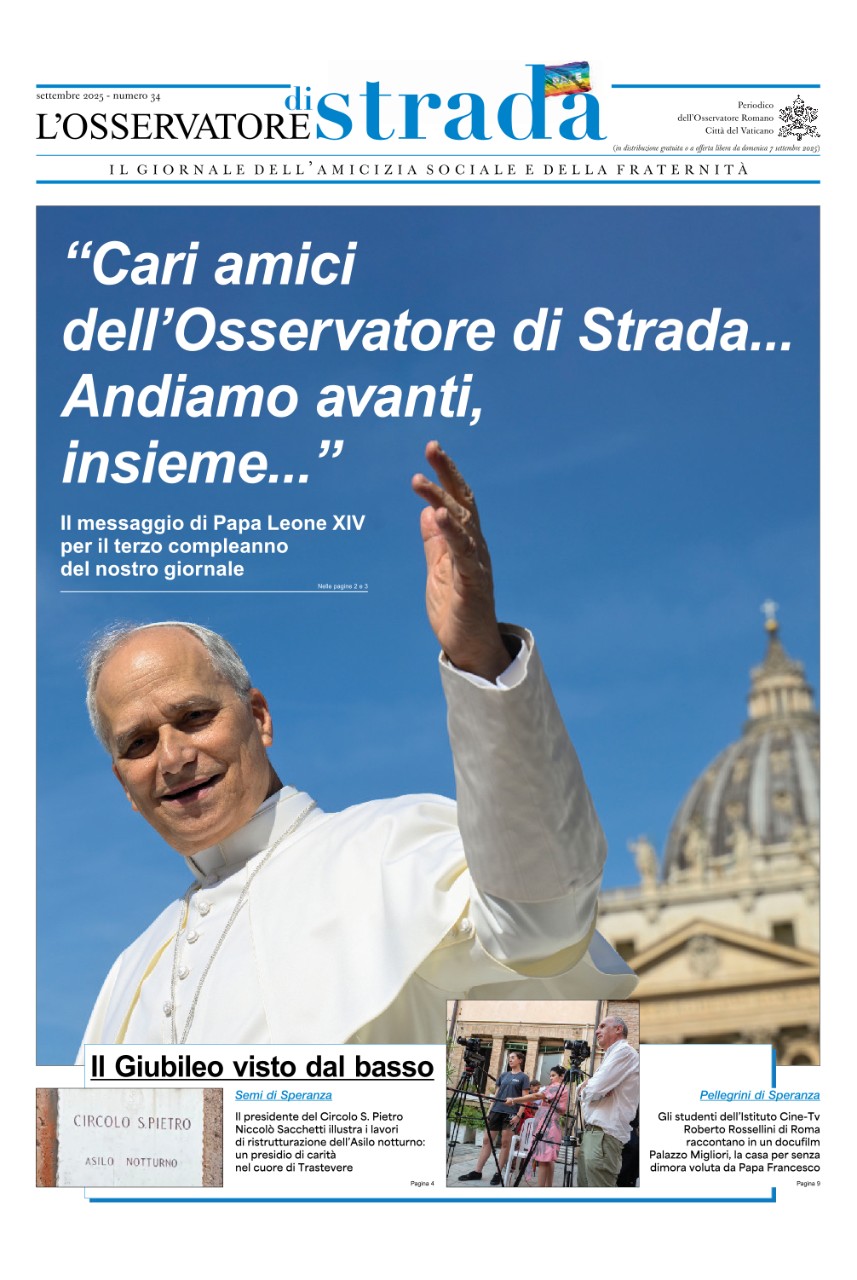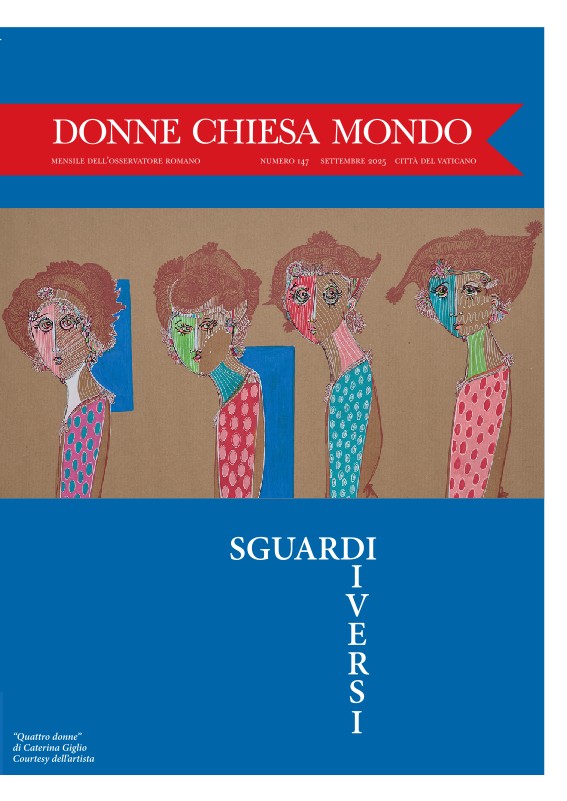Con il Radiomessaggio del 9 maggio 1945 Pio XII salutava

di Andrea Tornielli
L’8 maggio 1945, ottant’anni fa, finiva la Seconda guerra mondiale in Europa. Il Vecchio Continente usciva dal terribile conflitto con intere città ridotte a cumuli di macerie e contava milioni di morti, di feriti, di dispersi, di sfollati. Nel Radiomessaggio del giorno successivo, Pio xii affermava: «Se noi ci restringiamo a considerare l’Europa, ci troviamo già dinanzi a problemi e a difficoltà gigantesche, di cui bisogna trionfare, se si vuole spianare il cammino a una pace vera, la sola che possa essere duratura. Essa non può infatti fiorire e prosperare se non in una atmosfera di sicura giustizia e di lealtà perfetta, congiunte con reciproca fiducia, comprensione e benevolenza. La guerra ha suscitato dappertutto discordia, diffidenza ed odio. Se dunque il mondo vuol ricuperare la pace, occorre che spariscano la menzogna e il rancore e in luogo loro dominino sovrane la verità e la carità».
Queste parole di Papa Pacelli sono quanto mai attuali. In questo nostro tempo, caratterizzato da nubi oscure e dal rimbombo del suono sinistro delle armi più distruttive, non è possibile costruire la pace, la pace vera, la sola che possa essere duratura, senza sicura giustizia, lealtà, reciproca fiducia, comprensione e benevolenza. La pace vera necessita di verità e di carità, non della volontà di dominio e sopraffazione, non della volontà di aggredire e di schiacciare l’avversario. L’anniversario che celebriamo rappresenta un invito a non dimenticare ciò che le generazioni dei nostri padri e dei nostri nonni hanno costruito con sacrifici immensi: ottant’anni di sostanziale pace in un continente che per secoli è stato squassato da ogni tipo di conflitto fratricida. Quel sacrificio assume oggi un significato particolarissimo e di grande attualità. Nazioni che si erano combattute aspramente dando origine a due tremendi conflitti mondiali, riprendevano un cammino insieme, quel cammino che ha portato all’Unione europea. La generazione dei padri fondatori dell’Europa unita aveva negli occhi le scene raccapriccianti della devastazione provocata dalla guerra.
A questa generazione di fondatori possiamo ascrivere idealmente anche Giovanni Paolo ii: anch’egli aveva conosciuto gli orrori della guerra, il martirio della sua Polonia, le persecuzioni patite dagli ebrei, la divisione del mondo in due blocchi che aveva fatto ricadere la nazione polacca sotto il dominio sovietico. Rimangono scolpite nella storia le parole che il santo Pontefice, già malato e tremante, aveva pronunciato a braccio al termine dell’Angelus del 16 marzo 2003, quando stava per avere inizio la seconda guerra del Golfo con la spedizione militare di alcuni paesi occidentali in Iraq: «Io appartengo a quella generazione che ha vissuto la seconda Guerra Mondiale ed è sopravvissuta. Ho il dovere di dire a tutti i giovani, a quelli più giovani di me, che non hanno avuto quest’esperienza: “Mai più la guerra!”, come disse Paolo vi nella sua prima visita alle Nazioni Unite. Dobbiamo fare tutto il possibile!».
È la voce di quella generazione che oggi è importante riascoltare; è la testimonianza di quei sopravvissuti che oggi è utile ricordare; è il sacrificio di quegli uomini e di quelle donne che torna a noi potente anche attraverso le prime pagine di giornali ingialliti eppure così vivi e così carichi di speranza. Risuona forte il grido degli ultimi papi: «Mai più la guerra!». Solo una generazione che dimentica può pensare che la pace si custodisca preparando la guerra, può illudersi di costruire la pace riempendo gli arsenali di armi sofisticate e distruttive, come se quelle già esistenti — basti pensare soltanto agli ordigni nucleari — non fossero già sufficienti a distruggere più volte l’umanità intera. È di disarmo che abbiamo bisogno, non di una nuova corsa agli armamenti. È di negoziato e creatività diplomatica che abbiamo bisogno, come ha ripetuto tante volte Papa Francesco. Anche se questa espressione rischia di ridursi soltanto a uno slogan, rimane profondamente vero che al principio del “diritto alla forza” deve sostituirsi “la forza del diritto”.
C’è da augurarsi che l’anniversario di questi ottant’anni porti a rinnovare l’impegno di tutti per una de-escalation dei conflitti. È importante imparare dalla storia: quarant’anni fa, le due maggiori superpotenze provarono a dialogare per diminuire gli armamenti. I leader di Stati Uniti e Urss si incontrarono e si parlarono. Serve una de-escalation della guerra che devasta l’Ucraina, una de-escalation della guerra che devasta Gaza, come pure dei conflitti in Sud Sudan e nelle altre parti del mondo che in questo momento non sono sotto i riflettori dei media. Serve l’impegno di tutti per contrastare il terrorismo, togliendo qualsiasi giustificazione “religiosa” all’odio e all’uccisione degli innocenti.
Ma in questo 2025 si celebrano anche altri importanti anniversari, come quello della nascita delle Nazioni Unite. E pure i tre anniversari di altrettante visite dei pontefici all’Onu: Paolo vi nel 1965, Giovanni Paolo ii nel 1995, Francesco nel 2015. Sono occasioni per fare memoria e per riscoprire il valore di quei messaggi. Tra le pagine dei giornali dell’epoca c’è anche quella del «San Francisco Chronicle» del 26 aprile 1945 che racconta la riunione iniziata nell’omonima città americana che si protrasse fino al 26 giugno e che vide la partecipazione di delegati provenienti da cinquanta nazioni alleate. La Conferenza delle Nazioni Unite per l’organizzazione internazionale (Uncio) portò alla creazione della Carta delle Nazioni Unite. Colpisce che in una pagina interna di annunci pubblicitari vi sia riprodotta un’immagine del Santo di Assisi, dal quale prende il nome la città californiana di San Francisco. Vi si legge questo semplice quanto efficace messaggio: «May the United Nations Conference held in the city of St. Francis be guided by his words: Blessed be those who keep themselves in peace», e cioè «Che la Conferenza delle Nazioni Unite che si tiene nella città di San Francesco sia guidata dalle sue parole: Beati quelli che si mantengono in pace». È una parafrasi dell’Ammonizione xv del Santo. Ed è significativo che sia stata adottata per lanciare questo messaggio.
In effetti, se guardiamo all’oggi, per costruire la pace e realizzare le promesse e le speranze nate ottant’anni fa — come non si stancano di ripetere i pontefici e come ha fatto fino all’ultimo istante di vita Papa Francesco — abbiamo bisogno di richiamare il valore del multilateralismo e di una politica fondata sulla collaborazione tra gli stati, sul diritto internazionale e sulla diplomazia, non sulla contrapposizione e sulle logiche egemoniche. Ottant’anni fa i leader di paesi che si erano aspramente combattuti seppero scegliere di incontrarsi, di parlarsi, di riconoscersi reciprocamente, nel tentativo di costruire un edificio comune che impedisse il ripetersi dell’immane tragedia del conflitto mondiale. Erano coscienti che le guerre, a motivo anche della potenza degli armamenti disponibili, sono un colossale errore le cui conseguenze vengono pagate da milioni di innocenti. Un errore che mette a rischio l’esistenza dell’intera umanità.
Sessant’anni orsono san Paolo vi disse all’assemblea generale dell’Onu: «Basta ricordare che il sangue di milioni di uomini e innumerevoli e inaudite sofferenze, inutili stragi e formidabili rovine sanciscono il patto che vi unisce, con un giuramento che deve cambiare la storia futura del mondo: mai più la guerra, mai più la guerra! La pace, la pace deve guidare le sorti dei Popoli e dell’intera umanità! […]. Se volete essere fratelli, lasciate cadere le armi dalle vostre mani. Non si può amare con armi offensive in pugno». Trent’anni fa san Giovanni Paolo ii disse all’assemblea generale dell’Onu: «La risposta alla paura che offusca l’esistenza umana al termine del secolo ventesimo è lo sforzo comune per costruire la civiltà dell’amore, fondata sui valori universali della pace, della solidarietà, della giustizia e della libertà». E dieci anni fa il Papa che per primo nella storia della Chiesa ha preso il nome di san Francesco ha detto all’assemblea generale dell’Onu: «La guerra è la negazione di tutti i diritti e una drammatica aggressione all’ambiente. Se si vuole un autentico sviluppo umano integrale per tutti, occorre proseguire senza stancarsi nell’impegno di evitare la guerra tra le nazioni e tra i popoli. A tal fine bisogna assicurare il dominio incontrastato del diritto e l’infaticabile ricorso al negoziato, ai buoni uffici e all’arbitrato, come proposto dalla Carta delle Nazioni Unite, vera norma giuridica fondamentale».
Sono appelli da ricordare e da attualizzare. Per non dimenticare il grido riecheggiato da Pio xii nel Radiomessaggio del Natale 1944: «Se mai una generazione ha dovuto sentire nel fondo della coscienza il grido “Guerra alla guerra!”, essa certamente è la presente». La generazione dei sopravvissuti alla Seconda guerra mondiale aveva dunque ben presente l’urgenza di fare tutto il possibile per bandire definitivamente la guerra di aggressione come soluzione legittima delle controversie internazionali e come strumento delle aspirazioni nazionali. Le Nazioni Unite sono nate per questo. L’Unione europea è nata per questo. È un’eredità preziosa, da proteggere. I papi ci hanno insegnato che chiedere pace, impegnarsi per la pace non è un atteggiamento utopistico, ma una costruzione “artigianale” che richiede l’impegno di tutti. Quante volte Papa Francesco ha chiesto che tacciano le armi, che si torni al tavolo del negoziato, che ci si impegni — come ha detto in Lussemburgo nel settembre 2024 — «con costanza e pazienza in oneste trattative in vista della soluzione dei contrasti, con l’animo disposto a individuare onorevoli compromessi, che nulla pregiudicano e che invece possono costruire per tutti sicurezza e pace».
La testimonianza dei Successori di Pietro ci insegna che educare alla pace e impegnarsi per costruirla non è qualcosa da delegare soltanto ai grandi e ai potenti. Costruire la pace è un compito affidato alle nostre menti, ai nostri cuori, alle nostre mani. Quanto attuali sono, anche in questo senso, le pagine dell’enciclica Fratelli tutti. E se la guerra ha origine nel cuore dell’uomo, anche la pace può partire dal cuore dell’uomo. Senza mai dimenticare una dimensione fondamentale del nostro essere uomini, quella sociale: non siamo soli, siamo una famiglia, una comunità, un popolo. È interessante leggere certi sondaggi dai quali emerge quanto sia diffuso il desiderio di pace. C’è bisogno di recuperare la coscienza di essere un popolo e una famiglia di popoli, diversi per culture e tradizioni, ma tutti appartenenti a un’unica famiglia umana. «Non ci si salva da soli», ci ha ricordato Papa Francesco durante l’indimenticabile Statio Orbis nel pieno della pandemia per il Covid. Allo stesso modo è possibile dire: non si costruisce la pace da soli. Perché ci sono le pagine del libro della storia scritte dai potenti, e ci sono tante altre pagine, meno conosciute o del tutto ignote, che sono state scritte dall’impegno di milioni di persone umili, che con il loro sacrificio, la loro quotidiana preghiera, il loro impegno, hanno contribuito a cambiare il corso degli eventi. Per questo fino all’ultimo respiro Francesco ci ha invitato a credere che la pace è possibile, che la guerra si può evitare, che è possibile riconoscerci fratelli e perdonarci a vicenda.