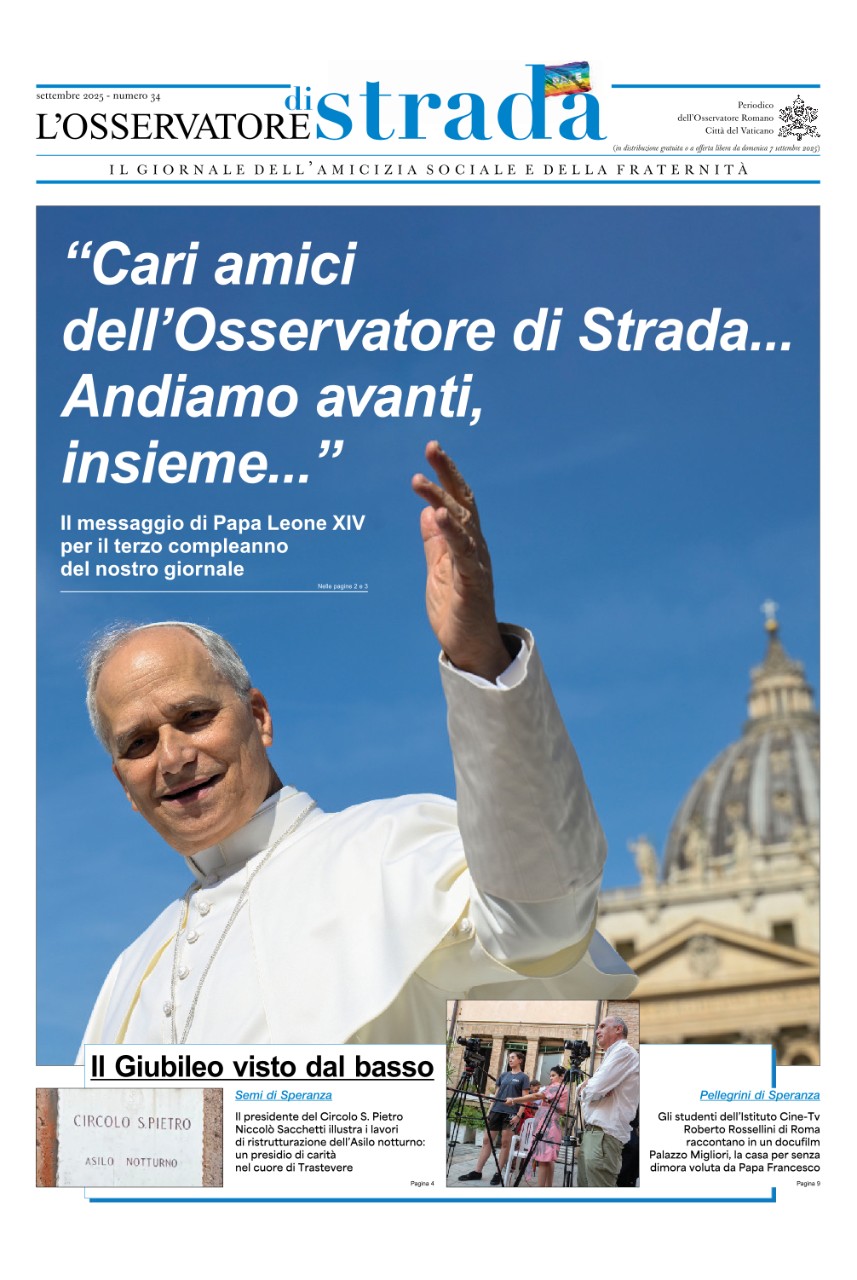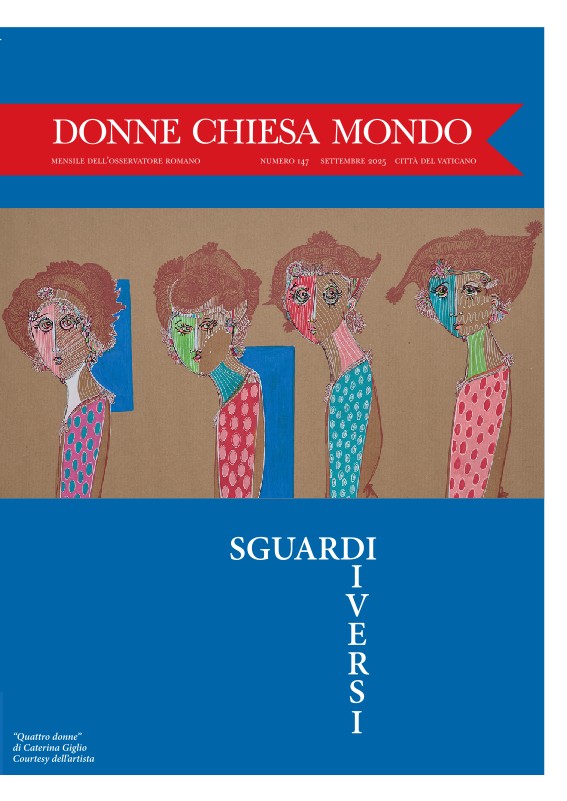Le muffe costituiscono

di Giulio Albanese
Le muffe stanno diventando un problema molto serio in Africa. Alcune di esse costituiscono, infatti, un grave rischio per la salute. Sia chiaro, non è sempre così, altrimenti qualsiasi formaggio erborinato come il nostro gustoso Gorgonzola (che presenta striature di muffa verde) o frutto leggermente avariato potrebbe risultare dannoso. Quelle davvero pericolose sono formate da colonie di funghi del genere Aspergillus: particolarmente l’Aspergillus flavus e l’Aspergillus parasiticus.
Queste muffe producono le aflatossine, tossine naturali (micotossine) che si trovano soprattutto in zone caratterizzate da clima caldo e umido, tra le latitudini 40°Nord e 40°Sud, una fascia che include appunto il continente africano. Ciò lo rende ideale per la sporulazione di questi funghi che stanno aumentando soprattutto a seguito del cosiddetto global warming. Il Kenya è uno dei Paesi africani maggiormente colpiti da questo flagello. Si stima che il 40 per cento delle coltivazioni di mais sia contaminato da aflatossine. Altri alimenti di base della dieta di gran parte degli africani contaminati sono il riso, la manioca e le arachidi.
La prima epidemia da micotossine documentata venne riscontrata nel 1961 e si diffuse a partire proprio da una partita di farina di arachidi contaminata che causò la morte di più di diecimila tacchini e che, ignorandone le cause, venne in un primo momento denominata Malattia x del tacchino (in inglese Turkey x disease). Queste muffe sono altamente tossiche e possono causare gravi problemi di salute negli esseri umani e negli animali, tra cui malattie epatiche, immunosoppressione e, in alcuni casi, cancro al fegato. Occorre inoltre rilevare che l’inadeguatezza delle pratiche di raccolta, stoccaggio e lavorazione degli alimenti contribuisce ad acuire il problema. La minaccia incombe soprattutto sulle popolazioni più vulnerabili, come i bambini e le persone con sistema immunitario compromesso. Le conseguenze della contaminazione da aflatossine possono essere devastanti anche per l’economia, poiché la loro presenza può limitare l’accesso ai mercati internazionali e ridurre i redditi degli agricoltori.
Tra le specie di aspergilli in grado di produrre aflatossine si possono ricordare anche l’Aspergillus nomius, l’Aspergillus pseudotamarii, l’Aspergillus bombycis, l’Aspergillus ochraceoroseus e l’Aspergillus australis. Rimane il fatto che l’Aspergillus flavus e l’Aspergillus parasiticus sono i più pericolosi perché responsabili della produzione della maggior parte delle aflatossine identificate nelle derrate alimentari contaminate di tutto il mondo e dunque non solo in Africa.
Questi funghi si sviluppano soprattutto quando gli alimenti sono conservati a temperature tra i 25 e i 32° C e con tassi di umidità dell’ambiente di oltre l’80 per cento. I ricercatori hanno individuato e classificato circa 20 diverse tipologie di aflatossine. Tra queste figurano i tipi B1, B2, G1, G2 e M1 che risultano essere i più pericolosi per la salute umana. Aspergillus flavus è responsabile dei tipi B1 e B2, mentre Aspergillus parasiticus produce i tipi sia B sia G1 e G2.
Per comprendere la pericolosità di queste tossine basti pensare che la B1 danneggia il Dna. Queste alterazioni dei geni possono generare delle proteine in grado come detto di provocare il cancro del fegato. Circa la gravità della situazione in Africa, emblematico è il caso del Mozambico dove il tasso di tumori epatici è fino a 60 volte superiore a quello riscontrato negli Stati Uniti d’America.
Se assunta in grandi quantità, come avviene nel caso di un’intossicazione acuta, l’aflatossina B1 può provocare anche emorragie del tratto gastrointestinale e a livello renale. Epidemie di intossicazioni da aflatossine si sono verificate frequentemente nel continente africano, particolarmente laddove non esistono sistemi di controllo della coltivazione e dello stoccaggio dei cereali.
Nell’ottobre 2012, il Consiglio esecutivo dell’Unione africana (Ua) ha approvato l’istituzione della “Partnership for Aflatoxin Control in Africa” (Paca) per coordinare gli sforzi di mitigazione dell’aflatossina a livello continentale. Dal 2014, ogni due anni, si svolge il “Partnership Platform Meeting” per coinvolgere le parti interessate nella valutazione dei progressi finalizzati a contrastare la presenza dannosa di aflatossine negli alimenti da cui milioni di persone in Africa dipendono per sopravvivere.
Una cosa è certa: come avviene in campo sanitario, anche per la sicurezza alimentare, l’Africa ha estremo bisogno di infrastrutture e conoscenze, ma anche di laboratori in grado di fornire dati e certificazioni affidabili sui prodotti agricoli e alimentari in generale. Si tratta di una sfida che riguarda non solo i governi locali, ma anche i donatori internazionali, per evitare di trovarsi di fronte al tragico dilemma di dovere scegliere tra la fame immediata e il rischio di malattie e morti future. Non v’è dubbio che la posta in gioco è davvero alta considerando che si tratta di salvaguardare il sacrosanto valore della vita. Ecco che allora una problematica come quella del dilagare delle aflatossine rappresenta una sfida che rientra nel perimetro della “ecologia integrale” su cui Papa Francesco è intervenuto ripetutamente.
Come ha rilevato il reverendo Arturo Bellocq, professore della Pontificia Università della Santa Croce di Roma, «la conversione ecologica che ha proposto il pontefice nella Laudato sii non può essere ridotta ad alcune misure tecniche, dall’abbassamento. delle emissioni inquinanti, alla salvaguarda degli animali in estinzione, a una legislazione più equa, ecc…». Infatti, l’enciclica afferma che «le soluzioni meramente tecniche corrono il rischio di prendere in considerazione sintomi che non corrispondono alle problematiche più profonde» (n. 144). Ne deriva, argomenta Bellocq, che «vanno cambiate le idee di fondo, la logica stessa dei nostri ragionamenti e delle nostre decisioni: va cambiata — laddove esiste — una logica egoistica con una logica che prenda sul serio l’origine comune, la mutua appartenenza, il futuro condiviso da tutti…». Peraltro —è bene rammentarlo — il cambiamento climatico avrà inevitabilmente un impatto sulla presenza di aflatossine negli alimenti, anche qui da noi in Europa. Motivo per cui occorre tenere alta la guardia.