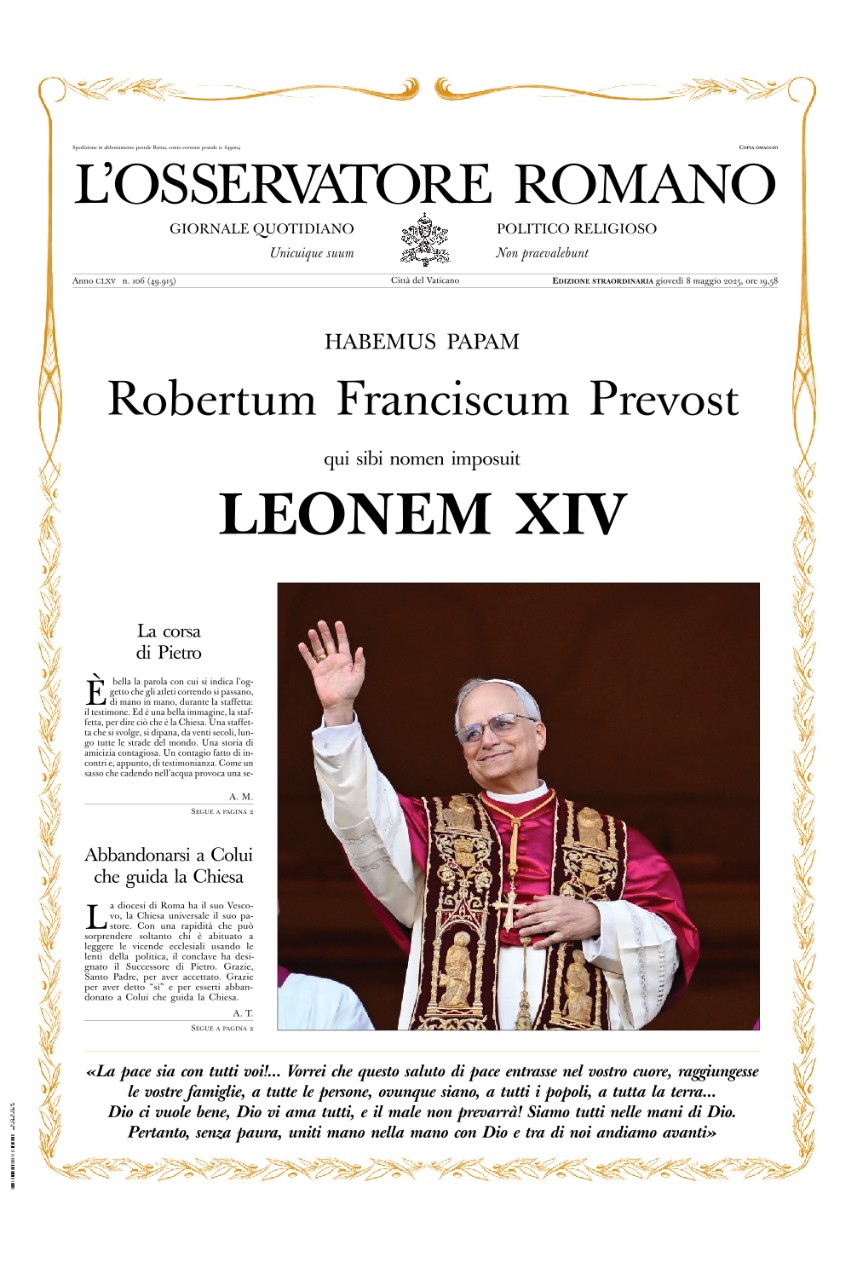Cari amici dell’«Osservatore di Strada», preparando questo numero dedicato alla scuola mi avete parlato di don Lorenzo Milani, manifestandomi il desiderio di approfondire la sua personalità, la ricchezza del suo essere prete, educatore, formatore di giovani poveri che non avevano accesso alla cultura. Mi avete ricordato che Papa Francesco si è recato sulla tomba di don Lorenzo per dimostrare il suo apprezzamento per il lavoro svolto da quel sacerdote forse non capito, non compreso, ma che ha lasciato una traccia indelebile nella Chiesa e nella cultura italiana. In quell'occasione ho avuto modo di ricordare anche l'esperienza che a Roma abbiamo fatto nel Seminario Romano Minore. Negli anni ‘70 abbiamo cercato di rispondere ad una domanda ricorrente: nei tempi passati i seminari, i conventi erano luoghi di formazione spirituale e culturale di tante generazioni. Erano scuole appetite, desiderate dalle famiglie e dai giovani; oggi i nostri seminari, il nostro seminario, possono rispondere a questa domanda? o la scuola che noi portiamo avanti ha le stesse dinamiche, la stessa problematicità che anche don Milani aveva messo in risalto nella famosa Lettera ad una professoressa? Quest’interrogativo ci ha portato a formulare un nuovo modo di approccio alla scuola.
Mi avete chiesto: «Racconta, ricorda quegli sforzi». Cari amici, voi non sapete che io sono rogersiano. Negli anni ‘70 ho avuto la possibilità di frequentare il Pontificio Ateneo Salesiano per un corso di formazione per educatori di comunità. Lì ho incontrato un grande sacerdote, don Giovenale Dho, che mi ha introdotto alla conoscenza di Carl Rogers. Mi ha messo in mano il suo famoso testo Terapia centrata sul cliente. Un incontro decisivo. Mi è stato di un’enorme utilità nel mio servizio come prete, educatore, accompagnatore di giovani nell’amicizia e nella verità.
Rogers diceva che le esperienze, soprattutto quelle intime, spirituali e culturali, che ci prendono profondamente, sono non solo irripetibili, ma anche incomunicabili. Hanno valore solo quelle che l’individuo fa da sé e le scopre personalmente.
Mi avete chiesto di narrarvi quella straordinaria stagione che io ho vissuto. Non posso. Ci vorrebbe tanto tempo, tanta carta per comunicare una piccola, piccolissima sensazione del fermento interiore di allora.
Ho pensato, per evitare emotività frastornanti, di interrogare uno dei ragazzi che ha fruito di quella metodologia, di quei pensieri, e di chiedergli un ricordo. Ecco il suo scritto.
Arrivati alla soglia dei 60, ripensando alla propria infanzia e alla prima giovinezza, è normale ricordarle come un periodo magico, avvolto in un’aura di bellezza. Scriveva Victor Hugo, ne L’uomo che ride, che «il ricordo è una voragine che una sola parola può smuovere fino in fondo». Ebbene, se ripenso agli anni della mia scuola media, precipito in ricordi così vividi che non posso ricondurre alla sola nostalgia; anzi, vi ritrovo degli elementi di singolarità che posso spiegare solo con il carattere autenticamente sperimentale della scuola e con le straordinarie capacità umane di coloro che la concepirono e la realizzarono.
Correva l’anno 1975 ed ero al Pontificio Seminario Minore di Roma, diretto in quegli anni da don Carlo Graziani e dal suo vice don Enrico Feroci. Avevo undici anni e ricordo distintamente che nel fine settimana mi spiaceva non poter andare a scuola. Quella scuola così peculiare destava curiosità. Capitava che le madri dei miei amici mi chiedessero: «Ma davvero a scuola usi la videocamera?»; mi ritrovavo così a spiegare che con i compagni di classe stavamo realizzando un programma televisivo sulla nostra regione, il Lazio, con tanto di riprese in esterna, «in studio» e regia.
Loro mi incalzavano, talvolta mi provocavano, come per raffreddare il mio entusiasmo: «Certo, tutto questo lo fanno perché ti vogliono far diventare prete…». Io non ero d’accordo; già allora avevo viva la sensazione che quella scuola non mirasse tanto e solo a coltivare vocazioni sacerdotali, ma volesse farci scoprire i nostri talenti, per capire quale compito saremmo stati chiamati a svolgere un domani nella società civile e nella Chiesa.
I miei ricordi della scuola cominciano, in realtà, un anno prima delle medie e sono legati ad una squisita macedonia di fragole offerta dal rettore e dal suo vice a me e a Filippo, l’amico che avrebbe poi condiviso con me quei tre anni. Era il giorno in cui andammo in visita con i nostri genitori; con le fragole ci diedero anche un assaggio di quel che ci aspettava. Ci raccontarono quale sarebbe stata la giornata-tipo e del “di più” che ci sarebbe stato richiesto rispetto alla scuola di quartiere alla quale saremmo stati altrimenti destinati. Ebbi subito la sensazione che quello sarebbe stato il luogo giusto per me e che ne avrei tratto qualcosa di significativo, al di là delle ore di lezione.
Le prime impressioni furono poi confermate dai fatti. Il Pontificio Seminario Romano Minore in quegli anni era veramente un luogo delle meraviglie. Ognuno di noi ragazzi era infatti considerato dalla scuola come un unicum e poteva scegliere, terminate le materie curricolari, materie “opzionali” come ceramica, chitarra e filatelia. Altre iniziative, che in fasi diverse accompagnavano l’anno scolastico, erano legate alla lettura collettiva dei quotidiani e alla scrittura di una sceneggiatura per un audiovisivo e alla sua successiva realizzazione.
In questo lavoro collettivo, nessun talento andava sprecato. Chi sapeva scrivere scriveva, chi sapeva disegnare disegnava, chi sapeva far musica suonava e componeva. Così ci fu possibile girare un vero e proprio “film”: dal soggetto alla sceneggiatura, in cui tutto (plot, copione, disegni, musiche e recitazione) era stato ideato e realizzato da bambini di 11 anni, accompagnati da insegnanti capaci e appassionati. Nello sviluppo di questa e di altre attività, la scuola riusciva a coinvolgere alcuni tra i massimi esperti nazionali del settore, che venivano consultati nella stesura dei progetti.
Su noi tutti vigilava, in modo discreto, uno psicologo. Credo proprio che noi ragazzi non sapessimo esattamente a che cosa potesse servirci uno psicologo, ma sapevamo che c’era e, alla bisogna, lui sapeva dove intervenire.
Quanto ai libri di testo, è giusto parlarne al plurale. Ogni studente aveva un manuale diverso cosicché la fase di partenza di ogni studio consisteva nello sbrogliare insieme la matassa delle diverse narrazioni: una vera faticaccia. Così, ad esempio, la caduta dell’Impero romano che su un manuale era raccontata in un modo, veniva confrontata con la narrazione di un altro manuale, che la descriveva in modo diverso.
Una parte davvero speciale, almeno per me, era poi l’educazione alla letteratura attraverso la lettura in classe di storie per ragazzi. I libri ce li leggeva in classe don Enrico: con la voce, la recitazione e gli sguardi che ci lanciava nelle fasi salienti della narrazione ci teneva incollati alla trama. In classe non volava una mosca. Ancora oggi, quando parlo di un libro con mia moglie o con un amico cerco di raccontarne la trama provando ad imitare lo stile e la passione che ci metteva don Enrico.
Con giugno l’anno scolastico si chiudeva, ma le opportunità, in realtà, non finivano. A luglio, chi voleva, poteva andare in vacanza alla casa di Torri in Sabina. Organizzata in camerate da 30 ragazzi, la casa aveva una piscina in cui gli allora studenti del Seminario Romano Maggiore (i nostri fratelli maggiori, appunto) si dilettavano, tra l’altro, a farci da insegnanti di nuoto. Daniele, Vito, Luciano li ricordo con gratitudine ancora oggi ogni volta che entro in acqua per nuotare. A loro va anche il grande merito di averci introdotto alla Liturgia delle Ore, con tanta semplicità, nel silenzio all’ombra dei tigli di Torri.
La domenica ci raggiungevano i genitori da Roma. Prima la messa tutti insieme e, poi, l’intera famiglia di famiglie (nonni inclusi) si riuniva, sempre sotto ai tigli, per pranzare insieme, cementando rapporti di sincera amicizia che, in molti casi, non terminarono con la fine del ciclo scolastico.
L’esperimento della scuola in Seminario, ahinoi, durò troppo poco per riuscire a consolidarsi, per diventare prassi, “scuola di scuole”, ma abbastanza per lasciare tracce ancor oggi evidenti in chi ebbe la fortuna di parteciparvi.
Oggi, a distanza di quasi cinquanta anni Filippo e Lino non ci sono più, come non c’è più don Carlo. Ma quando, di frequente, ci rivediamo tra compagni o quando capita la fortuna di incontrare il sorriso accogliente di don Enrico in una delle tante imprese in cui la Chiesa e la vita lo hanno portato, basta un attimo per ricordare i giorni di quella scuola che, in un modo unico e irripetuto (ma non irripetibile), ci ha aiutato a svelarci a noi stessi.
So di dovere tanto alla Chiesa di Roma per tutto quello che mi ha dato nel corso dell’intera vita, ma se dovessi scegliere — tra i tanti — un motivo speciale di gratitudine è quello di avermi accolto, quel giorno del 1974, con una macedonia di fragole alla scuola media di viale Vaticano 42.
Cardinale Enrico Feroci
di Cristiano Fiorenza