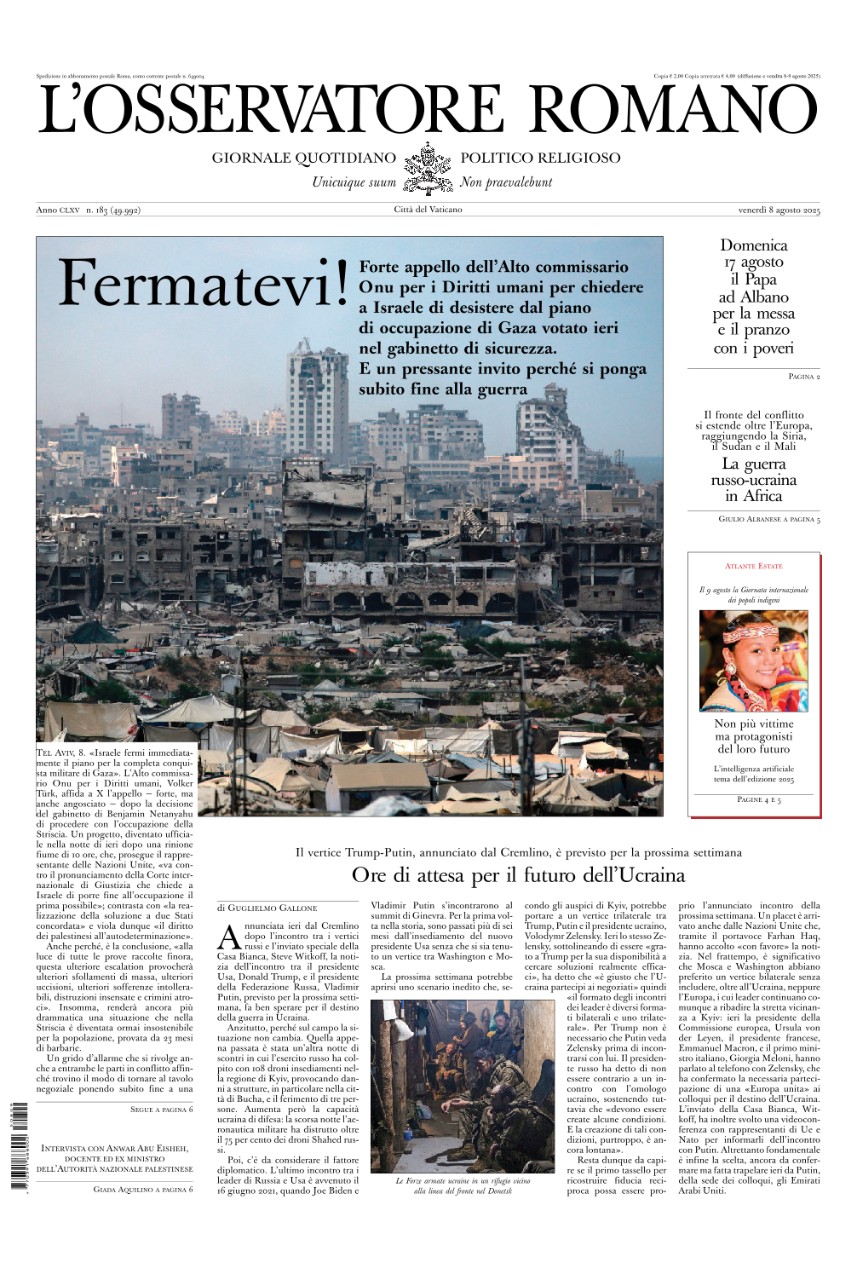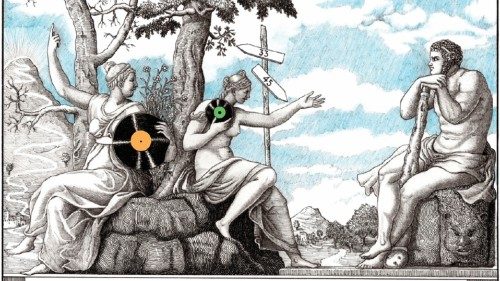
Gli uomini di oltre 50 anni hanno memoria di quando la musica si ascoltava sul vinile. I dischi in vinile erano essenzialmente di due formati: di 33 e di 45 giri. I secondi erano più veloci e più brevi, contenevano solo due canzoni, una per lato, mentre i 33 giri erano più ampi, contenevano tutto l’album del cantante, diviso nei due lati, A e B, che potevano contenere 5-6 canzoni a lato. Questa distinzione, 33 e 45 giri, corrispondeva a due diversi “usi” della musica, due distinte mentalità: chi amava la canzone “di successo” di quel momento acquistava il 45 giri, ovviamente più economico, chi amava quell’artista, comprava l’intero album, che conteneva anche quel brano di successo ma insieme a tutto il resto, l’opera nel suo complesso.
Al fruitore di dischi a 45 giri non interessava possedere altro se non quella canzone lì, che aveva ascoltato alla radio o alla televisione e lo aveva colpito, avvinto. Voleva quella canzone e se la comprava, a colpo sicuro. Il fruitore dei 33 giri invece correva il rischio. Quella canzone lo spingeva ad andare oltre, a saperne di più di quell’autore di cui acquistava tutta l’opera. Anche per capire quella canzone di successo “da dove” veniva, che altro c’era intorno, che “storia” c’era dietro, prima durante e dopo quella canzone.
Sono passati tanti anni e i vinili sono passati di moda, rimasti in vita per lo più come roba per collezionisti (che ancora si emozionano per quel fruscio, così caldo e “umano”, che accompagnava l’ascolto), ma qualcosa è rimasto di quel mondo: è rimasta la mentalità da 45 giri. Si è persa invece quella da 33.
Oggi infatti è tornato di moda il “metodo” dei 45 giri nel senso che in tutti i campi, dall’arte alla religione, dalla politica alla comunicazione, le persone fruiscono del pezzo singolo ma scartano l’intero album, in altre parole: semplificazione anziché approfondimento o, se vogliamo, esperimento e non esperienza. Godimento dell’emozione breve e rapida e rifiuto della complessità, dell’esperienza più lenta e paziente dell’attesa e della scoperta (intesa anche come conquista). Più efficienza meno epica. Si sperimenta, cioè si prova, si “testa”, un prodotto sicuro, di già convalidato successo, ma non si va oltre, si resta fuori dai rischi dell’esperienza, senza lasciarsi troppo coinvolgere se non emotivamente. E questo a tutti i livelli e in tutti gli ambiti.
Pensiamo alla politica: fino alla fine degli anni ’80 il “formato” della politica era il 33 giri, si votava un partito, non un singolo uomo politico. Sui manifesti elettorali c’era il simbolo del partito, non il nomi o la faccia del leader carismatico.
Pensiamo alle relazioni sentimentali che sono diventate, appunto, sempre più sentimentali. Con tutta la fragilità del sentimento, ondivago per natura. Il 45 giri, più economico, si consuma e si cambia più velocemente. Il diametro di un disco a 33 giri indica che i giri sono più lenti e quindi meno numerosi, c’è un respiro più ampio, un’arcata più lunga, un respiro più profondo e tenace. La manutenzione di una relazione “a 45 giri” non conviene, e quindi l’ipotesi si scarta.
Pensiamo alla comunicazione, anche quella politica (ma non solo): ai lunghi discorsi in piazza o nelle sedi dei partiti (congressi nazionali, sezioni..) si è passati al messaggio, breve e incisivo, del leader sui social. La “narrazione” è diventata da una parte fondamentale, dall’altra sinonimo di semplificazione. Eppure la narrazione, come fatto umano, nasce proprio per affrontare la vita nella sua complessità, per restituire la complessità che è presente nella vita cercandone una lettura possibile, una via d’uscita che scaturisca dal caos verso il senso. La narrazione non serviva (e non dovrebbe servire) a spiegare ma a dispiegare tutta la portata dell’esperienza umana.
L’emozione del 45 giri resta comunque essenziale, come colpo, come impatto forte e immediato, ma da lì dovrebbe nascere un sentimento che porta poi alla curiosità e all’approfondimento, al volerne sapere di più, a non cadere nella logica del consumo immediato e compulsivo. Il problema di una vita a 45 giri, fatta dell’accumulo di esperimenti anziché di esperienze, è che instaura un modello basato sulla superficialità e sulla reversibilità. A differenza dell’esperienza, l’esperimento infatti ha questa caratteristica: si può entrare e uscire dall’esperimento, senza rischi di rimanere segnati né feriti, perché è sempre reversibile, sempre sotto il nostro controllo. Un po’ come la differenza tra gioia e piacere secondo la riflessione di C.S.Lewis per il quale: «mentre il piacere lo è spesso, la gioia non è mai in nostro potere».
Ecco, forse passando da 33 a 45 giri abbiamo acquistato qualcosa in termini di piaceri ma perso qualcosa in termini di gioia. Fu vero guadagno?
di Andrea Monda