«Con le valigie
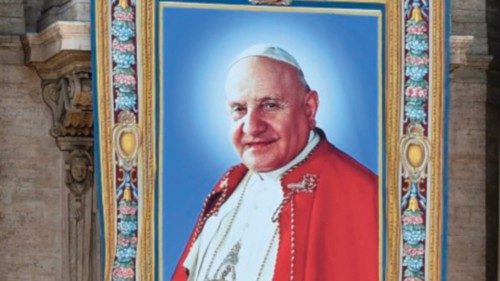
«Stanotte leggendo il capo Cinquanta della Imitazione di Cristo libro iii — Qualiter homo desolatus se debet in manu Dei offerre — ebbi come una rivelazione celeste circa quanto il Signore può disporre della mia povera vita, a mia santificazione finale, ed a mia felicità eterna. Mi tengo preparato a tutto...». Così domenica 6 maggio 1962, Giovanni xxiii , sulla sua agenda, in uno dei primi cenni rivelatori della propria consapevolezza quanto alla gravità della sua malattia.
«Il mio lavoro per l’allocuzione di domenica, 4 corr. mi riesce faticoso e pesante. Allo stomaco soliti disturbi, con un po’ di pazienza abbastanza sopportabili. E li sopporto con amore, nel ricordo dei miei Santi, e anche di tutta la buona compagnia dei miei morti. Così mi vengo piano piano familiarizzando con le anime dei trapassati, e comincio la buona domesticità con loro», così il Pontefice bergamasco l’1 novembre successivo, una «giornata uggiosa e quasi triste e senza sole».
«Umanamente parlando c’è poco da sperare», aveva confidato il fedele segretario monsignor Loris Capovilla — poi cardinale centenario — al confessore del Papa, Alfredo Cavagna, già il 30 ottobre precedente, aggiungendo: «Il Card. Segr. di Stato, mgr. Dell’Acqua e Lei sono a parte di questa situazione in un momento delicatissimo della vita della Chiesa e — possiamo dirlo — dell’Italia. Non c’è che da vivere giorno per giorno».
«Non mi sorprenderei per niente se a settembre non avessimo già più Giovanni xxiii. Sta facendo una fatica enorme a parlare e a fare finta di star bene», scrisse l’8 dicembre 1962 il vescovo Hélder Câmara.
«O caro santo mio Bernardino, diletto fra i miei santi. Colla dolcezza del tuo ricordo mi hai recato parecchi segni della continuazione di un grande dolore fisico che non mi lascia, e mi fa grandemente pensare e soffrire. Stamane per la terza volta mi accontentai della S. Comunione ricevuta in letto, invece che godermi la celebrazione della S. Messa. Pazienza: pazienza. Non potei tuttavia rinunziare al ricevimento alla visita di addio del Cardinale Wyszynski [...]. Il resto della giornata in letto con parecchi episodi di speciale dolore fisico. Mi assistono, sempre con grande carità: miei familiari: card. Cicognani, mgr. Capovilla, fratel Belotti Federico e domestici». Precedute da notazioni circa la sua malattia fra trascrizioni dai Salmi o da schegge del Breviario, spunti di meditazione nella prospettiva del congedo terreno — e seguite da pagine bianche — sono queste, sotto la data 20 maggio 1963, festa del grande predicatore, le ultime righe del diario di Giovanni xxiii . Non pochi sin lì i rimandi a «parecchi episodi di acuto dolore», nella consapevolezza di quanto poteva sopravvenire, e tuttavia, sino alla fine il Papa non avrebbe smesso di fare programmi per il futuro: il progetto di studiare il russo nella consapevolezza di tenere aperto un dialogo diretto con Krushev — «lo czar moderno delle Russie» — dopo la liberazione del metropolita ucraino Josyf Slipyj, il viaggio a Montecassino previsto il 23 maggio, il suo lavoro personale per il Concilio, la prosecuzione dell’impegno per la pace... Non dimenticando che lo stesso giorno — 20 maggio — veniva datata la sua ultima lettera ai Vescovi, nella quale con riferimento alla novena di Pentecoste annunciava la sua intenzione di cominciare un ritiro spirituale presso la torre di S. Giovanni e ricordava ai presuli e al popolo cristiano la necessaria preparazione spirituale da tempo indicata come presupposto indispensabile per la celebrazione del concilio, collocato sotto il segno dello Spirito Santo ed invocato ad affrettare «nella famiglia dei credenti» il suo esito: ovvero l’«auspicato rinnovamento».
Dunque nessuna paura, nessuna rassegnazione. Tutt’altro. E non poche parole a rimarcare l’abbandono in Dio da sempre cifra della sua vita, la fiducia nella preghiera, ma anche lo stupore innanzi a consolazioni riservategli in momenti di debolezza del «fratello corpo» che il 9 ottobre 1960, visitando le Grotte Vaticane aveva chiesto di deporre dopo la morte nel loculo «in faccia alla tomba del S. P. Pio xi », immaginando invece due anni dopo un’altra destinazione: San Giovanni in Laterano, nella «cappella interna» del Vicariato. In ogni caso: «Cum infirmor, tunc potens sum — ii Corinti, 11. 29 — Volesse il cielo che queste parole fossero l’indizio fra l’accoppiamento di qualche mio dolore fisico o morale col miglior successo di frutti spirituali in questo mio ministero, per il buon successo della causa della S. Chiesa in questo momento già così dubbioso», aveva scritto alcune settimane prima. Insomma, per tentare una sintesi: attaccato alla vita, ma «con le valige sempre pronte» per usare le parole ripetute all’archiatra pontificio Antonio Gasbarrini negli ultimi giorni.
«Arrivederci a settembre» gli aveva detto il primate polacco quel 20 maggio. E Papa Giovanni sereno gli aveva risposto: «A settembre troverete o me o un altro papa. In un mese, sapete bene, si fa tutto: funerali dell’uno ed elevazione dell’altro». Sarebbe andata così. Due settimane lungo le quali si percepì un distacco come qualcosa che non riguardava solo i credenti. Il 21, pur avendo rinunciato all’udienza generale, riusciva tra gli spasmi ad affacciarsi alla finestra. Salutati i fedeli in piazza, riferendosi all’imminente Ascensione, esclamava: «Nella esultanza del monte Oliveto donde il Salvatore tornò al Padre, corriamo dietro al Signore che sale». Era quello che si accingeva a fare.
Riappariva il giorno dopo per la recita del Regina Caeli e per la sua ultima benedizione. Una partecipazione corale, straripante, ma composta. L’agonia di un Papa per la prima volta stava per essere vegliata dal mondo intero. Una miriade di occhi puntati sulla camera al terzo piano del Palazzo Apostolico, dove Giovanni xxiii stava per congedarsi, mentre i suoi occhi, lassù, fissavano il Crocifisso: «Questo letto è un altare, l’altare vuole una vittima: eccomi pronto. Offro la mia vita per la Chiesa, la continuazione del Concilio Ecumenico, la pace del mondo, l’unione dei Cristiani. Il segreto del mio sacerdozio sta nel crocifisso che volli porre di fronte al mio letto, egli mi guarda e io gli parlo... Quelle braccia allargate dicono che egli è morto per tutti; nessuno è respinto dal suo amore, dal suo perdono...». Queste le parole dell’uomo che, anche nelle sue ultime ore, mantenne l’abitudine di conversare con Gesù, novissima verba di un sacerdote, vescovo, Pontefice, vissuto sempre nella presenza attraente di Dio, che amava la sua famiglia secundum sanguinem, ma aveva piena consapevolezza di appartenere ad una sola famiglia grande come il mondo. E che il 31 maggio chiese al segretario di aiutarlo a prepararsi «a morire, come si conviene a un vescovo, ad un papa», mentre al segretario di Stato, intento a riferirgli che in tutto il mondo si pregava per lui disse: «Se Iddio vuole il sacrificio della vita del Papa, che esso valga ad impetrare copiosi favori sul Concilio ecumenico, sulla Chiesa santa, sull’umanità che aspira alla pace». Aggiungendo — senza rinuncia alla speranza di chi ama la vita —: «Se invece a Dio piace prolungare questo servizio pontificale, che ciò sia a santificazione dell’anima del Papa e di quanti lavorano e soffrono per la dilatazione del Regno di nostro Signore».
Di fatto era la partecipazione alla costruzione di questo Regno ad interessargli. Nella certezza che «se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto». Ebbe però il tempo di salutare i suoi congiunti, arrivati in aereo viaggiando con il cardinale Giovanni Battista Montini, con lui accorsi al suo capezzale. Ed ebbe il tempo di prefigurare — nelle parole estreme raccolte da Capovilla — una nuova immagine di Chiesa: «Ora più che mai, certo più che nei secoli passati, siamo intesi a servire l’uomo in quanto tale e non solo i cattolici; a difendere anzitutto e dovunque il diritto della persona umana e non solo quelli della Chiesa cattolica». E ancora: «Non è il Vangelo che cambia, siamo noi che cominciamo a comprenderlo meglio».
Sessant’anni ci separano da quell’addio — il 3 giugno 1963 — per certi versi suggello di tutta la sua opera. Giovanni xxiii , ricevuti i sacramenti, si spegneva alle 19 e 47 mentre in piazza San Pietro si concludeva la messa dell’agonia e il celebrante pronunciava le parole «Ite missa est»: d’un tratto, la stanza semibuia s’illuminava nella cornice della finestra dell’Angelus e la gente — in un impressionante silenzio — capiva che il Papa aveva varcato la soglia del Mistero.
Sessant’anni e un ricordo indelebile che viene tramandato da più generazioni. Ma se una riflessione s’impone in quest’occasione, è proprio quella di verificare quanta strada si sia percorsa, pur nel mutato contesto, seguendo le sue indicazioni, quali processi abbiano innescato... Che poi significa scorgere quali testimonianze la Chiesa in tutto questo tempo, abbia reso non a se stessa, ma al Vangelo; di quali nuove parole e gesti si sia avvalsa per dialogare con le donne e gli uomini di oggi; di quanto spirito conciliare sia impregnato il nostro agire in una Chiesa che dovrebbe essere «ricca di Gesù e povera di mezzi; libera e liberante», e in una società dove il nostro dovrebbe essere uno «stare nel mondo con gli altri senza sentirci al di sopra degli altri», contro ogni tentazione di «chiuderci nei recinti delle nostre comodità e convinzioni», prendendo in prestito parole di Papa Francesco.
Appunto: una Chiesa che invece di mostrarsi agli occhi del mondo, dovrebbe servirlo; la Chiesa del grembiule. La Chiesa in uscita. Impegnata non più nel segno della conquista ma del servizio: compreso quello che per Giovanni xxiii era il «servizio pontificale»...
«Non finiremo mai di parlare di lui. Quando avremo bisogno di dire agli increduli che Dio dirige la storia degli uomini, parleremo di lui. Quando avremo bisogno di dare un volto e un nome al rinnovamento cristiano ormai avviato, parleremo di lui. Quando avremo bisogno di giustificare la nostra libera protesta contro le istituzioni oppressive, parleremo di lui. Ma non riusciremo mai a render conto pienamente del mistero gaudioso di questa lunga agonia che spreme dalla sua pena non so quale inesauribile conforto per il mondo intero». Così aveva intuito lo scolopio Ernesto Balducci la sera prima della morte di Giovanni xxiii . E il trappista Thomas Merton l’1 giugno 1963 annotava: «Il mondo ha un grande debito con lui, per la sua semplicità. È doloroso che dovremo privarci di uno come lui. Ha fatto così tanto in quattro anni, o quattro e mezzo, per ricordare alla gente che la carità cristiana non è una storia inventata». I due coglievano già la premessa di una «sopravvivenza» che oggi si può percepire ancora persino nel suo paese natale, Sotto il Monte, santuario a cielo aperto meta di pellegrini, e che si poteva immaginare già aprendo — subito dopo la morte — il suo Giornale dell’anima, lo zibaldone spirituale compagnia di una vita curato dal fedele segretario e contubernale Capovilla.
Lui, tante volte, a ricordarci come il Papa, accettata serenamente prima la vecchiaia — affrontata con i suoi limiti, ma senza pessimismo — dopo averci insegnato a vivere, ci aveva insegnato anche a morire. O, meglio, a vedere nella morte «non l’ora del pianto ma del finale ricongiungimento per la festa eterna».
di Marco Roncalli


















