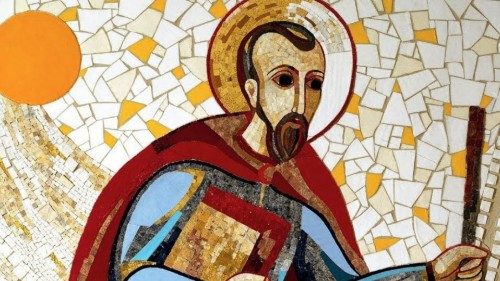
Quando san Paolo parla della giustificazione per la fede, in realtà sta riprendendo profonde convinzioni di alcune tradizioni ebraiche. Perché se si affermasse che la propria giustificazione si ottiene attraverso il compimento della Legge con le proprie forze, senza l’aiuto divino, si starebbe cadendo nella peggiore delle idolatrie, che consiste nell’adorare se stessi, le proprie forze e le proprie opere, invece di adorare l’unico Dio.
È imprescindibile ricordare che alcuni testi dell’Antico Testamento e molti testi ebraici extrabiblici mostravano già una religiosità della fiducia nell’amore di Dio e invitavano a un compimento della Legge attivato nel profondo del cuore dall’azione divina (cfr. Ger 31, 3.33-34; Ez 11, 19-20; 36, 25-27; Os 11, 1-9, etc.) (1). La “emunà”, atteggiamento di profonda fiducia in Yahweh, che attiva l’autentico compimento della Legge, «è al centro stesso dell’esigenza di tutta la Torah» (2).
Un’eco recente di questa antica convinzione ebraica, che rinuncia all’autosufficienza dinanzi a Dio, si può trovare nella seguente frase del Rabbi Israel Baal Shem Tov (inizio del xix secolo): «Temo molto più le mie buone azioni che mi producono piacere di quelle cattive che mi producono orrore» (3).
Le tradizioni ebraiche riconoscono anche che per compiere integralmente la Legge occorre un cambiamento che parte dai cuori. Cristiani ed ebrei non diciamo che a valere è il compimento esteriore di certe usanze senza l’impulso interiore di Dio. La teologia ebraica in realtà coincide con la dottrina cristiana su questo punto, soprattutto se si parte dalla lettura di Geremia e di Ezechiele, dove appare il bisogno di una purificazione e di una trasformazione del cuore. Come non vedere in Rm 2, 28-29 una continuazione e un approfondimento di Ger 4, 4; 9, 24-25)? Ebrei e cristiani riconosciamo che la sola legge esterna non può cambiarci senza l’opera purificatrice e trasformatrice di Dio (Ez 36, 25-27), che per noi ha già cominciato a rendersi presente nel suo Messia (Gal 2, 20-21).
D’altro canto, ricordiamo che secondo la profondissima interpretazione di sant’Agostino e di san Tommaso sulla teologia paolina della legge nuova, la sterilità di una legge esterna senza l’aiuto divino non è solo una caratteristica della Legge ebraica, ma pure dei precetti che lo stesso Gesù ci ha lasciato: «Anche la lettera del Vangelo ucciderebbe se non avesse la grazia interiore della fede, che guarisce» (4).
*Arcivescovo di La Plata
(1) Il testo di Ab 2, 4, che esprime questo atteggiamento fondamentale, è di fatto citato da san Paolo quando parla della giustificazione per la fede in Gal 3, 11 e in Rm 1, 17.
(2) Cfr. C. Kessler, Le plus grand commandement de la Loi (cit) 97. Bisogna dire qui che le affermazioni di Paolo su una “caducità” della Legge si dovrebbero inserire nel contesto della “dottrina rabbinica degli eoni”, secondo la quale alla fine dei tempi l’istinto del male sarà sradicato dai cuori umani e la legge esterna non sarà più necessaria. Paolo in effetti credeva di vivere nei tempi ultimi e attendeva un ritorno imminente del Messia: «Paolo era un fariseo convinto di vivere in un tempo messianico»: H.J. Schoeps, Pau1. The theology of the Apostle in the light of Jewish religious story, Philadelphia, 1961, p. 113. Per questo motivo, in 1 Timoteo, quando l’attesa di una venuta imminente si era molto mitigata, la legge acquisì maggiore importanza (cfr. 8-9).
(3) Citato da E. Wiesel, Celebración jasídica, Salamanca, 2003, p. 58; Celebrazione hassidica, Milano, 1987.
(4) San Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, domanda 106, articolo 2.
di Victor Manuel Fernández *


















