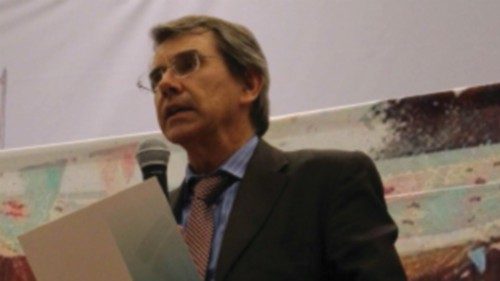
Il debito estero torna a far paura ai Paesi in via di sviluppo. Una valanga che rischia di travolgere fragili economie e con esse i loro sistemi di assistenza sociale (sanità, educazione, e via dicendo). Nel 2018, il debito estero totale dell’Africa era stimato a 417 miliardi di dollari e il 36% era dovuto a organizzazioni multilaterali (Banca mondiale e Fondo monetario internazionale), il 32% a creditori bilaterali e un altro 32% a creditori privati. Rispetto al 2013, il numero degli Stati africani ad alto rischio o in difficoltà di indebitamento era più che raddoppiato, passando da otto a diciotto nel 2018. Nel 2019, secondo la Banca mondiale, più di trenta nazioni del continente nero hanno speso più per il pagamento del debito che per la sanità pubblica e il 40% dei Paesi dell’Africa subsahariana erano in difficoltà o a rischio di indebitamento nello stesso anno. Nel 2020, la crisi pandemica di covid-19 ha aggravato pesantemente la situazione.
Il rallentamento dell’economia mondiale ha infatti portato a un calo dei prezzi delle materie prime e a un aumento dei costi delle importazioni africane, mentre i proventi del turismo, delle rimesse e delle materie prime sono diminuiti. Per ovviare a questo problema, il
Quale posizione ha la società civile di fronte a questa moratoria?
Essa ritiene che non sia sufficiente e che, soprattutto per i Paesi a basso reddito, si debba procedere a una vera e propria cancellazione del debito estero che liberi liquidità per i Paesi in difficoltà.
Basterà la cancellazione?
A fianco di questa soluzione, la società civile propone l’emissione dei cosiddetti “diritti speciali di prelievo”. Che cosa sono? Sono, di fatto, una moneta emessa dal Fondo monetario internazionale in casi speciali e in ragione della quota che ogni singolo Paese detiene nel capitale del Fmi. Il
L’emissione dei diritti speciali di prelievo può essere sufficiente?
Per rispondere ai bisogni dei Paesi più indebitati non bastano. Come Civil 20 proponiamo una emissione di almeno tremila miliardi di dollari. Così si creerebbe una massa di liquidità importante per rilanciare le singole economie.
Rimane anche un discorso complesso sui sistemi fiscali e su come questi possano sostenere i rispettivi sistemi economici.
Certo, aumentare quello che si chiama “spazio fiscale” dei Paesi, cioè la capacità di finanziare le spese necessarie per i cittadini, richiede una più rigorosa gestione del prelievo fiscale. Oggi troppe attività economiche, e proprio negli Stati più vulnerabili, riescono a sottrarsi alla corresponsabilità fiscale. Ma per un intervento più rigoroso in questa direzione oggi nel
Tutto questo significa che la Campagna di remissione del debito varata in occasione del Giubileo del 2000 fallì?
No, nel 2000 ottenemmo un risultato che appariva trasgressivo: la cancellazione del debito che liberò risorse per finanziare le strategie di riduzione della povertà, utili anche dal punto di vista democratico, perché davano spazio alla partecipazione della società civile locale nella definizione dei programmi di sviluppo. Erano stati definiti anche criteri per prestiti sostenibili. Il punto è che quei criteri non sono stati da tutti rispettati. La crisi del 2008, poi, aumentò le esigenze di spesa dei governi mentre ne riduceva le entrate fiscali. Questo spinse a ulteriore indebitamento. La crisi poi provocata dal covid-19 ha amplificato questo trend rendendolo insostenibile.
Che cosa è cambiato oggi rispetto ad allora?
Vent’anni fa i creditori erano soggetti pubblici, relativamente omogenei. Oggi dobbiamo mettere d’accordo attori molto diversi fra loro e un numero rilevante di creditori privati, alcuni dei quali si muovono in modo spregiudicato. Non sono cambiate invece alcune questioni sistemiche come la regolazione inadeguata dei mercati finanziari, delle materie prime e del commercio internazionale in genere. C’è più consapevolezza, come sui temi del clima, ma costruire una volontà politica comune è più difficile. Però è ciò che occorre fare: portare la politica a intervenire nelle relazioni economiche perché si realizzino giustizia e solidarietà al servizio di tutti, a cominciare dai più deboli.
di


















