Bob Dylan compie 80 anni
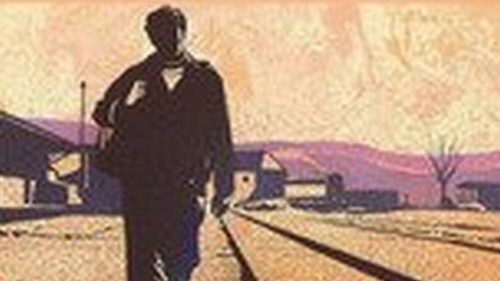
Bob Dylan ha ottant’anni, e sta tornando a casa. I suoi pensieri non fanno altro che vagare (Got a mind to ramble), la sua ossessione rimane il vagabondare (Got a mind to roam), ma ha imboccato la via di casa, lentamente, portando poco bagaglio con sé (I’m travelin’ light and I’m slow coming home). È così che si conclude Mother of Muses, una delle canzoni del suo ultimo (per ora) disco, Rough and Rowdy Ways. Ma la sua casa non è quella che ha lasciato nel Minnesota. Ci vorrà forse tornare, prima o poi, o forse no perché come dice in Mississippi, una canzone del 2001, «tornare si può sempre, ma non da dove sei partito» (You can always come back, but you can't come back all the way). Non è quella la sua “vera” casa. L’ha detto molto chiaramente nell’intervista che punteggia No Direction Home, il documentario di Martin Scorsese del 2006: «Avevo l’ambizione di partire per trovarmi in qualche luogo, in un’odissea di ritorno. Mi sono messo a cercare questa casa che ho lasciato molto tempo fa. E non riuscivo a ricordare esattamente dove fosse, ma mi sono incamminato per arrivarci. E incontrare quello che incontrato lungo la via è stato proprio come l’avevo immaginato… Sono nato molto lontano da dove avrei dovuto, e così sono in viaggio verso casa».
Nel 1965, Dylan chiedeva alla Miss Lonely di Like a Rolling Stone: come ci si sente, cosa si prova, che effetto fa a non sapere più come tornare a casa? No Direction Home, appunto. Essere senza casa, eppure doverci tornare; è l’antica situazione di Ulisse.
Dopo l’assedio e la guerra viene il ritorno, che è altrettanto pericoloso; qualche dio geloso si può sempre mettere di mezzo e impedire l’approdo.
Quando Dylan se la prendeva con Miss Lonely perché aveva vissuto un’esistenza troppo protetta e non aveva mai imparato a vivere sulla strada, se la stava prendendo soprattutto con se stesso, per essersi illuso che il mestiere di eroe del folk, sempre dalla parte del giusto, lo potesse proteggere dalla maledizione/benedizione della strada, dove non sai mai se quello che ieri credevi sacrosanto lo sia ancora domani, alla prossima svolta del destino.
La strada insegna che tutto muta continuamente, gli incontri, le risposte della vita, e soprattutto lo stile, che devi essere capace di indossare e dismettere come un vestito quando cambia il tempo. Chi è ancora troppo giovane può pensare che vivere sulla strada abbia come destinazione la strada stessa, e non c’è parola in Dylan che abbia più risonanza di road (le altre sono wind, rain, train e ship; home non è tra le più significative), ma chi giovane non è più sa che non è così.
Stare sulla strada è eccitante, intossicante, eroico.
Se sei abbastanza pertinace, nonché fortunato, ti fa dare tremila e più concerti in tutto il mondo, ma non avere una casa non è bello.
E avere una casa dove tornare, ma non una casa dove arrivare, è inquietante, pauroso, e insieme necessario, perché un artista, sempre parole di Dylan da No Direction Home, «deve stare attento a non giungere mai in un luogo dove crede di essere arrivato», perché la falsa sicurezza raggiunta gli farebbe dimenticare il dovere di «essere costantemente in uno stato di trasformazione».
Jamie Lorentzen, uno studioso di Kierkegaard che insegna al Saint Olaf College di Northfield, nel Minnesota, crede di avere capito quale sia la casa dove Dylan dove vuole arrivare, o almeno in quale regione del mondo si trovi. E non è che gli sia sconosciuta, proibita, o che Dylan abbia bisogno di chissà quali mappe segrete per arrivarci.
È il Sud degli Stati Uniti, il luogo dal quale è nato tutto il bene e tutto il male del grande paese, tra il Mississippi e la Loui-siana, dove la Highway 61 che parte dalla piccola città di Wyoming nel Minnesota va a morire alle porte di New Orleans, l’unica città d’America che, come ha scritto e cantato Leonard Cohen dopo l’uragano Katrina che l’ha messa in ginocchio, «era meglio dell’America» (Samson in New Orleans). Del resto, Dylan l’aveva già scritto in Chronicles che l’autostrada che ha portato il blues dal sud al nord, da Memphis a Chicago e da Chicago a Duluth, dove Dylan è nato, era la sua strada: «Era la stessa strada, piena delle stesse contraddizioni, gli stessi paesini di quattro case, gli stessi antenati spirituali. E il Mississippi, il flusso sanguigno del blues, inizia proprio dai miei boschi. Non mi sono mai allontanato troppo di lì. Era il mio luogo nell’universo, ho sempre sentito che era nel mio sangue».
Tutto questo, Lorentzen l’ha scritto in un capitolo di Tearing the World Apart: Bob Dylan and the Twenty-First Century, pubblicato dalla University Press of Mississippi nel 2017. In gran parte ha ragione, ma poi manca di rispondere alla domanda più immediata: se Dylan sa dov’è la sua casa, perché allora non ci è già tornato? Perché dichiara al mondo di essere sempre in viaggio se l’ultima dimora, che è anche la prima, non può che essere il Sud? Ma è semplice: perché Dylan sa, e tutta la sua opera è lì a dimostrarlo, che quella casa è già abitata, e che lui può amarla finché vuole, e può dichiararla, se crede, la fine del suo viaggio, ma non è mai stata sua e non lo sarà mai.
È la casa del blues, ma il blues non l’ha creato lui e non l’hanno creato né gli ebrei né gli anglosassoni né gli irlandesi né gli italiani, anche se tutti possono dire, ognuno a modo suo, di averlo imparato e condiviso. L’hanno creato gli afroamericani più poveri e più disprezzati, e nessuno glielo può portare via, neanche se impara nota per nota tutti gli assoli dei suoi chitarristi. Dylan l’ha detto, di essere rimasto in Mississippi un giorno di troppo.
L’ha cantato proprio in Mississippi, una canzone incisa nel 2001 che ricrea a ritroso il mondo che Dylan si è lasciato alle spalle, nelle brume degli anni Sessanta. Nell’autunno del 1963, quando era già un nome, ma niente di più di un nome, ci era andato davvero, a Greenwood nel Mississippi, per un voter registration rally, una manifestazione a favore del diritto dei neri a iscriversi alle liste elettorali (cosa che allora ti poteva procurare una pallottola nella schiena, e anche adesso non è una cosa pacifica).
È stato l’unico intervento autenticamente militante della sua vita, ma ha lasciato il segno. Quel giorno in più passato in Mississippi ha dovuto scontarlo per tutti gli anni successivi, perché non ha mai imparato che cos’è la politica, ma dalle facce dei trecento mezzadri neri ai quali ha cantato With God on Our Side e Only a Pawn in Their Game ha imparato cos’è la dignità. E ci ha dovuto meditare per ventisei anni, finché nel 1989 ha scritto Dignity: «un uomo-ombra che in un campo di cotone cerca la dignità». Nella sua lunga odissea, Dylan di case ne ha trovate tante. Non ci ha mai abitato per molto, ma abbastanza per conoscerne tutti gli angoli: l’Oklahoma di Woody Guthrie, il rock and roll di Elvis come il gospel degli Staples Singers, la ballata folk inglese e scozzese, il canto sanguigno dei ribelli irlandesi, il country e il bluegrass il cui territorio si estende dal Texas ai Monti Appalachi, così come lo standard in tutte le sue ramificazioni, da Billie Holiday a Frank Sinatra.
Ma la casa di Bob Dylan esiste solo se la si cerca, solo se lui continua a cercarla, e c’è il sospetto che quando dovrà smettere nessuno potrà riprendere il viaggio dal luogo in cui lui l’avrà interrotto. Nel frattempo, sarebbe urgente disegnare una mappa dei luoghi fantastici a cui Dylan ha voluto dare un nome.
Sono le città, le vie e gli snodi di una geografia immaginaria che però, una volta tracciate le linee che li uniscono, creano un’America tanto reale quanto quella che si percorre con le scarpe ai piedi: New York vista con gli occhi di chi ci è andato a vent’anni per incontrare Woody Guthrie, la Baltimore dove Hattie Carroll trova una morte tanto razzista quanto incurante, la nave della libertà (e dell’apocalisse) che finalmente entra in porto, le campane della libertà che suonano durante una tempesta, i cancelli dell’Eden che non hanno consistenza in sé, sono solo ciò di cui siamo al di fuori, e poi ancora il vicolo della desolazione — l’unico luogo dove accade qualcosa che vale la pena di essere narrato — le terre della signora dagli occhi tristi sotto il livello del mare, la torre di guardia in cima alla quale i principi apprendono che Babilonia è caduta, l’Egitto messicano o il Messico egiziano dove si aggira la dea Iside, l’orto del Getsemani dove nessuno, tranne Uno, capisce che cosa vi accade, i Caraibi dell’idolo-giocoliere jokerman, il Texas infinito della ragazza di Browns-ville dai denti di perla, e poi ancora le Highlands della Scozia, la Scarlet Town che è Desolation Row quattro secoli prima, e infine la Key West di Rough and Rowdy Ways, un luogo che ha la consistenza di una cartolina dalla Florida e insieme è il centro immaginario di tutte le trasmissioni radio clandestine, quelle che hanno diffuso il rock and roll nel mondo, come le radio a onde corte che trasmettevano dal Messico e dalla Louisiana e arrivavano, ma solo di notte, nella stanza di Robert Zimmerman adolescente che ascoltava Leadbelly e Muddy Waters chiedendosi da quale universo affocato potessero venire quelle voci.
Le case di Bob Dylan sono queste. Alcune le ha visitate una volta sola; in altre è rimasto più a lungo, poi è ripartito. E non sarà un caso che la casa dove davvero abita, quella di Point Dume a Malibu, non è mai entrata in nessuna sua canzone. Come si può ritornare dove non si è mai stati? «Se non dovessi tornare, / sappiate che non sono mai / partito. / Il mio viaggiare / è stato tutto un restare / qua, dove non fui mai». Sarebbe bello che Dylan potesse leggere questi versi di Giorgio Caproni, il Biglietto lasciato prima di non andar via. Forse vi riconoscerebbe molto di se stesso.
di Alessandro Carrera


















