Quell’accorata Lettera
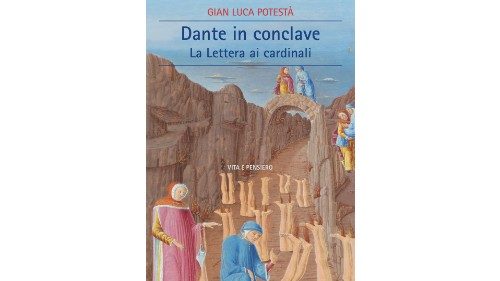
A proposito dei fedeli, il canone 212 del Codice di diritto canonico, che è ripreso anche dal Catechismo della Chiesa Cattolica, recita: «In modo proporzionato alla scienza, alla competenza e al prestigio di cui godono, essi hanno il diritto, e anzi talvolta anche il dovere, di manifestare ai sacri Pastori il loro pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa; e di renderlo noto agli altri fedeli, salva restando l’integrità della fede e dei costumi e il rispetto verso i Pastori, tenendo inoltre presente l’utilità comune e la dignità della persona». Oltre sette secoli fa, a esercitare questo diritto-dovere in maniera particolarmente appassionata fu un fedele laico al quale non facevano certo difetto scienza, competenza e prestigio: il suo nome era Dante Alighieri. Ma andiamo con ordine.
Dopo la morte di Clemente
È questa la situazione che, tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate del 1314, spinge Dante a scrivere un’accorata lettera ai cardinali italiani. A tale famoso documento ha di recente dedicato un ottimo libro Gian Luca Potestà, docente di Storia del cristianesimo all’Università Cattolica di Milano (Dante in conclave. La Lettera ai cardinali, Milano, Vita e Pensiero, 2021, pagine 230, euro 23): in esso l’autore ricostruisce con grande precisione il contesto storico in cui si colloca lo scritto dantesco, propone un’attentissima analisi filologica della missiva e ne coglie il significato più autentico, inquadrandola all’interno della straordinaria vicenda religiosa e letteraria dell’Alighieri. Come sottolinea Potestà, «al centro della Lettera sta la Chiesa romana. Abbandonata da Clemente
Lungo le ben documentate pagine del libro, Potestà chiarisce le tante questioni connesse al testo della Lettera, che spaziano in campi diversi e si intrecciano continuamente: dalla filologia alla storia, dalla teologia alla politica. Di particolare interesse è il ritratto dell’Alighieri che emerge da quanto scrive Potestà, che afferma: «Conoscitore disincantato di conflitti di poteri e dinamiche di corruzione nelle gerarchie, Dante incarna una figura nuova di intellettuale, di laico che nella Chiesa rivendica la parola in virtù della sua fede e conoscenza dei fatti. Qui il poeta e letterato si presenta come profeta, fiero di proclamare da solo e dal basso ciò che tutti sanno, ma nessuno ha il coraggio di dire. Il testo non è un’esercitazione letteraria né una lettera aperta, ma un drammatico richiamo a non rassegnarsi e ad agire al più presto».
di


















