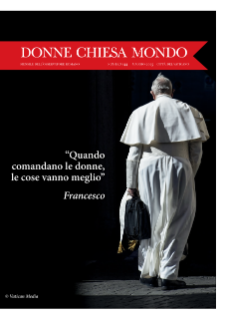E tra tutti svetta Virgilio
Se è vero che in alcuni ambiti la cultura latina è indubbiamente debitrice della greca, ciò non vale per la poesia. La poesia latina è assolutamente originale, unica e strepitosa. La sua forza è tale da nutrire il Medioevo e spandersi poi in una nuova età aurea con Dante, Petrarca e il Rinascimento, illuminando la cultura europea, giungendo a noi oggi ancor vivissima e attuale.
Pensate ai “canzonieri” amorosi di Catullo, Tibullo e Properzio: la poesia greca non ne ha. Per i greci l’amore è un lampo, un’irruzione sconvolgente del divino, che però va e viene, come una malattia. Per i latini è un’esperienza che trasforma l’uomo per sempre, lo fa rinascere a “vita nuova”. Lesbia, Delia, Cinzia, sono come Laura e Beatrice, donne che ti segnano per sempre, anche se ti fanno soffrire, ti abbandonano o non ti corrispondono. La poesia riprese dopo dodici secoli un suo discorso interrotto, così, come se non fosse successo niente, come se non fosse cambiata, anche, una lingua.
Ma ciò che ancor più unisce la poesia latina all’italiana è il realismo. Nei latini è qualcosa di incredibile, qualcosa che non si ripeterà mai più con quella forza, con quella spontaneità e vivacità. Succede anche quando guardate quei busti romani, che non sono “belli” come i marmi greci, ma ci fanno vedere una persona viva, noi vediamo proprio quella persona che è stata, che duemila anni fa ha vissuto e noi ce la ritroviamo davanti. Ci fanno vedere una persona precisa, unica, irripetibile, infinita.
Nel Duecento c’è una polemica tra italiani e provenzali. I provenzali, dolcissimi, cantano l’amor de lohn (amor lontano), l’amata per loro può essere anche non mai stata vista, come la principessa islamica cantata da Jaufré Rudel, che vive sull’altra sponda del Mediterraneo e di cui lui ha solo sentito parlare. Jacopo da Lentini gli risponde dalla Sicilia che «li occhi in prima genera(n) l’amore», che è come dire: l’amata la devi vedere con gli occhi, perché la sua realtà è molto di più di ogni possibile immaginazione.
E poi, poi c’è Virgilio. Virgilio è tutto questo, ma anche oltre, anche altro. Come se avesse sulle spalle tutto questo, come Enea con il padre, ma avesse anche un piccolino nella mano e un mondo da traghettare verso un altro mondo.
La realtà è anche, per Virgilio, anzi è soprattutto, dolore. Ma un dolore non, come Lucrezio, da superare, scavalcare. È un dolore salvifico. Uno stimolo a crescere, ad allargarsi, aprirsi. E un aprirsi, allargarsi, è tutta l’opera di Virgilio.
Prima la fuga, vitale, da un presente inaccettabile (le guerre civili, il caos di una transizione storica allarmante) nella natura, nei boschi, nell’umile vita dei pastori, e tutto ciò è già, in sé, un allargamento. Ma anche nelle Bucoliche è il dolore, anzi campeggia sovrano: l’esilio inevitabile di Melibeo, il pianto inconsolabile della madre per la morte del figlio Alessi, le sofferenze amorose di Coridone e di Gallo, l’amico caro abbandonato dalla sua amata e venuto tra i boschi a cercare consolazione nella natura, nella bellezza, nella musica dei pastori. Ma per quanto Gallo si sforzi di dimenticare, il dolore rimane, ancor più vivo e più vero.
E proprio qui, nella quarta ecloga, è la grande profezia della nuova era di pace, felicità e rinnovamento spirituale di cui è portatore un bimbo, un puer, che sta per nascere (siamo nel 40 circa avanti Cristo). E c’è anche, con il puer salvifico, una Vergine (Iam redit et Virgo). Si capisce perché Virgilio fu ritenuto, oltre che un grande poeta, anche un profeta.
Da questa profezia Virgilio torna alla terra, a un’umiltà (humus = terra) più vera, e scrive le Georgiche. La terra è la base, il fondamento, ma anche il lavoro dell’uomo, che è fatica, dolore, ma vera, sana crescita, nutrimento fisico e spirituale, continua comunicazione col cielo, e con gli altri, perché il lavoro della terra è lavorare insieme, insieme conoscere e insieme crescere. E la coltivazione delle api del quarto libro (il padre di Virgilio era apicoltore) ci mostra l’esempio di una comunità meravigliosamente laboriosa e pacifica, modello di coesistenza e condivisione, come se la natura insegnasse, indicasse all’uomo la via della convivenza pacifica e produttiva.
Ma questo ritorno alla natura, alla terra, questo desiderio di pace e di comunione, questa grande conciliazione, e nuova umiltà, dopo tanta superbia, non è qualcosa di incredibilmente attuale? Non dobbiamo assolutamente rileggere questo autore, proprio pensando al nostro tempo, ai suoi drammatici, impellenti problemi?
Dalla natura alla cultura (che è coltura, soprattutto) e poi, nell’Eneide, il grande salto alla storia, il passato il presente il futuro, quella storia inaccettabile da cui prima aveva cercato di fuggire. Salendo ancora la visione si allarga, e copre tutto fin dalle origini. Appare una Provvidenza, non un semplice destino, che comunica continuamente con l’uomo, in un fitto, continuo dialogo. Enea continuamente prega, chiede e dialoga con il cielo, prima di agire e dopo aver agito. Potremmo dire che il suo pensiero è continuamente un dialogo con il cielo. Nell’Eneide tutto è sacro, la pietas non è solo di Enea, ma irradia di sé tutti i personaggi, irradia le cose, anche loro piangono (sunt lacrimae rerum). Il fato non è cieco ma è Provvidenza che illumina la storia, e la fa crescere, attore invisibile che muove gli eventi, continuamente invocato attraverso la preghiera. Non solo Enea, tutti i personaggi pregano.
Leggendo l’Eneide sentiamo che tutti noi abbiamo dovuto abbandonare la nostra patria e siamo esuli. Ma una Provvidenza ci guida. Una madre celeste, bella e buona, si prende cura di noi. Con dolore e fatica fonderemo una nuova patria, dove troveranno casa, e pace, i nostri penati.
Abbiamo detto tanti bei contenuti, concetti: ma non abbiamo detto che in Virgilio tutto ciò è musica, qualcosa di vivo e reale che ci trascina e sorprende, sempre superando ogni nostra interpretazione. Come ha detto bene Ungaretti: «Virgilio è il poeta più musicale che la storia delle lettere possa ricordare, voglio dire il poeta più capace di distruggere, in soggettivo fluire di musica e in sublime suggestione mentale, la materialità della parola».
di Claudio Damiani