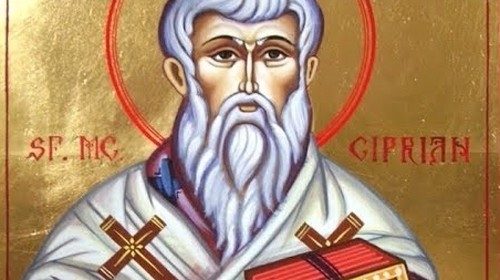
Anche nel tunnel dell’epidemia si continua a leggere (di più in quarantena? Lo speriamo). Ma quali libri? La risposta lega il discorso sull’emergenza socio-sanitaria che ci attanaglia a quello sulle letture che al momento ci intrigano. Fra i titoli più gettonati da febbraio in qua — ce lo dicono i librai, e i bibliotecari confermano — c’è La peste di Albert Camus, il romanzo più noto dell’autore franco-algerino, pubblicato nel 1947 e divenuto un classico del Novecento. Il libro parla di una grave epidemia che scoppia in una città della costa algerina, Orano, e imperversa per mesi causando grandi sofferenze fisiche e morali alla gente e facendo migliaia di morti.
I critici interpreteranno variamente il morbo descritto da Camus, ora come allegoria del nazismo, ora come espressione narrativa della sua visione filosofica, improntata alla lettura della vita-storia umana come un assurdo doloroso. In ogni caso i lettori italiani, travolti dal coronavirus, più che in una filosofia o una poetica hanno voluto come rispecchiarsi nella trama di un grande libro contemporaneo che ricalca il nostro dramma collettivo. E si sono identificati nel protagonista, Bernard, vittima dell’angoscia, tentato dalla disperazione, in cerca degli amici e, lui medico, curvo sui malati a salvare vite umane.
I media non potevano fare a meno di registrare questo risveglio dal coma dell’oblio di un capolavoro letterario, sull’onda di un’attualità a cui avremmo rinunciato con piacere. E qualcuno ne ha colto il destro per ricordare gli autori e le opere più note sul tema della peste, della morìa, del disastro corale (lo sta facendo, tra gli altri, anche l’Osservatore Romano da settimane con la serie dedicata a Il racconto dell’epidemia nei secoli). Da Tucidide a Lucrezio, la voce più originale della poesia latina, ammiratore di Tucidide e autore a sua volta, nel finale del De rerum natura, di una descrizione della peste ateniese più scioccante delle pagine tucididee. Da Daniel Defoe, autore nel 1722 del Journal of the Plague Year (il “Diario dell’anno della peste”) a Boccaccio, testimone oculare della «mortifera pestilenza» del 1348 (come la chiama, vi perse familiari e amici) e genio letterario nell’elezione del tragico sfondo a cornice narrativa del Decameron. Quanto all’arcinota peste di Manzoni, i lettori e soprattutto i nostri studenti, per i quali a volte I promessi sposi è un po’ datato, complice il buio presente potranno ahimé sentirsi più in sintonia con l’autore e scoprirne la drammatica attualità.
Ma fra questi classici, riletti al tempo del covid-19, ne manca uno non meno grande, il De mortalitate di san Cipriano, il più insigne dei Padri preniceni. Cipriano era un retore di Cartagine, metropoli romana e cuore della Chiesa africana.
A 40 anni, verso il 246, si converte al cristianesimo e, colto e retto com’è, il popolo gli “impone” il presbiterato e nel 249 lo vuole vescovo. Diverrà una personalità dominante della Chiesa latina, alla guida di una città e cristianità al centro delle grandi questioni ecclesiali: i lapsi, il battesimo degli eretici, il primato romano, l’unità della Chiesa. Si distinse per la sua coerenza dottrinale, l’accoglienza dei decreti pontifici (ma nella disciplina era più rigorista di Roma) e un grande zelo pastorale, da padre pur nel rigore. Finito nel mirino dei persecutori Decio e Valeriano, morì martire a Cartagine nel 258, decapitato sul prato di un’altura a picco sul mare.
Il De mortalitate, titolo tradotto in genere come “La pestilenza”, ma mortalitas significa pure “mortalità”, “fragilità” e anche “morte”, così come lo abbiamo è un messaggio pastorale (forse elaborato da un’omelia) scritto da Cipriano nel 252 per i fedeli, colpiti da una tremenda pestilenza, forse era vaiolo o virus ebola. La pandemia era esplosa in Egitto e si era sparsa nei territori rivieraschi del Nordafrica, causando migliaia di morti e invadendo la popolosa Cartagine. Il morbo arriverà a Roma, dove farà cinquemila morti al giorno e ricorderà a tutti la peste Antonina del secolo prima, sotto Marco Aurelio. Allora come nel III secolo l’emergenza sanitaria si era accompagnata ad altre sciagure (guerre, invasioni, carestie, fame…) che per i pagani erano castighi degli dèi indignati per la libertà data ai cristiani, mentre per questi preannunciavano la fine del mondo.
Il De mortalitate attesta l’estrema premura pastorale di Cipriano, impegnato sia sul piano socio-sanitario sia dal lato spirituale. Il male colpiva duro, l’autore ci parla dei sintomi: bruciore agli occhi, febbre, coliche devastanti, a tanti si amputavano gli arti. È un “male micidiale”, dice, che strappa i figli ai genitori, i mariti alle mogli, gli amici agli amici.
Ma oltre il realismo c’è la visione cristiana della morte e del dolore, un respiro soprannaturale, l’invito alla speranza e alla meditazione dei valori morali e spirituali eterni. È una consolatio cristiana, dove sfocia una tradizione che viene da Cicerone e Seneca. Ma a volte è severo il vescovo di Cartagine, deciso nello scuotere l’amato e afflitto gregge: «Che motivo c’è di stare in ansia e di essere preoccupati? Chi resta trepidante e mesto tra questi avvenimenti se non chi non ha né speranza né fede?». Niente sconti, in Cipriano c’è l’austerità dell’uomo antico, del romano che è sempre rimasto. Ma egli ridesta la fede e la speranza con una forza e una passione uniche. I pastori oggi hanno più comprensione e delicatezza, per loro è giusto l’attaccamento delle persone e anche dei cristiani alla vita; Cipriano lo critica, lo flagella. Però non arriva a vedere nel contagio il castigo divino dei nostri peccati, come fa padre Parroux, il religioso che è fra i personaggi principali della Peste di Camus.
di Mario Spinelli


















