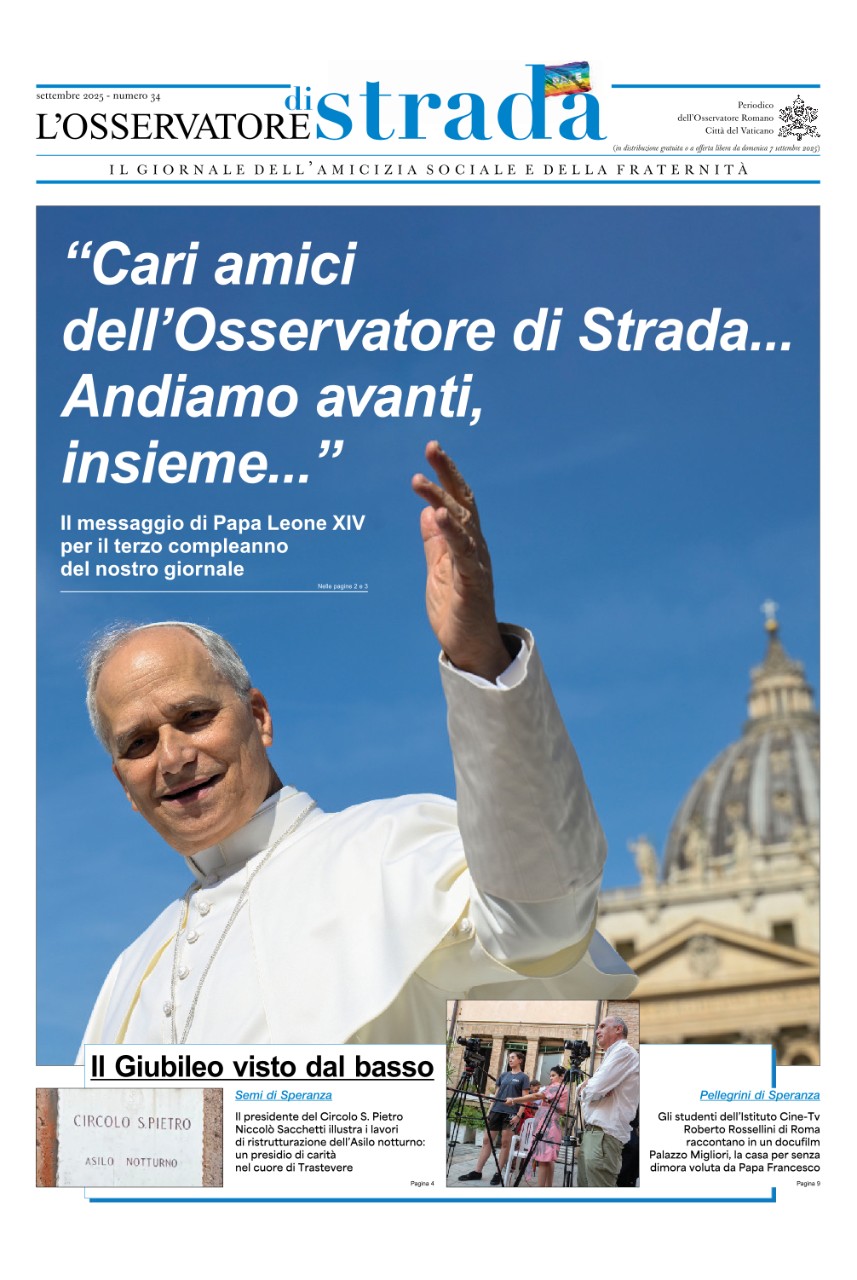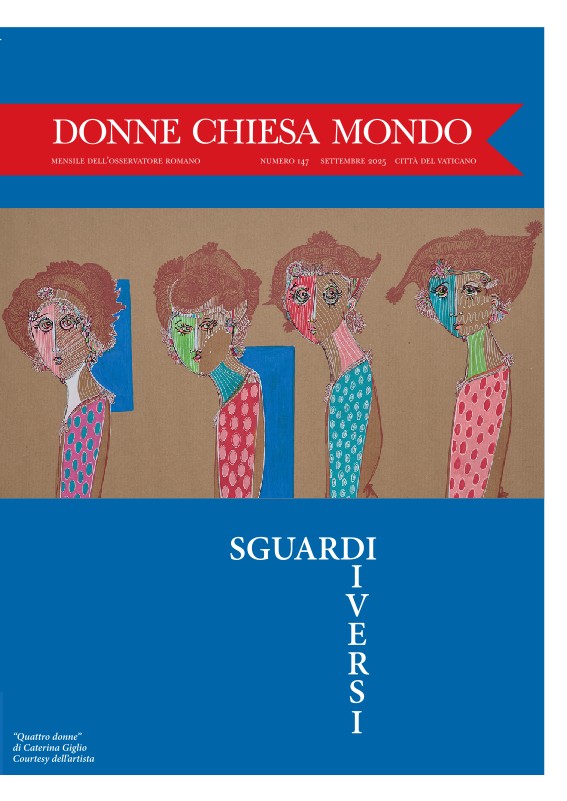Parlare oggi di “genere” in ambito cattolico è spesso un esercizio complicato: il rischio di chiudersi nel rifiuto o, al contrario, di annacquare tutto è sempre dietro l’angolo. Marta Rodríguez Díaz, filosofa e docente, prova a trovare una terza via nel suo libro Il genere, i giovani e la Chiesa. Mettere insieme i pezzi per i Sinodi che verranno. (Città Nuova, 2025).
Il testo parte da un’intuizione semplice ma onesta: quando parliamo di genere, spesso non ci capiamo perché non stiamo parlando della stessa cosa. L’autrice individua tre registri principali con cui il termine viene affrontato: quello politico (dibattiti su leggi e diritti), quello esperienziale (la vita concreta delle persone, le loro storie), e quello antropologico (che cos’è l’identità di genere, come si forma, che rapporto ha con il corpo e il sesso biologico). La mancanza di chiarezza e il sovrapporsi di queste prospettive, spiega Rodríguez, crea cortocircuiti comunicativi, soprattutto tra giovani e adulti.
Una parte centrale del libro è dedicata proprio a questa frattura generazionale. Le nuove generazioni, scrive l’autrice, si muovono spesso da una prospettiva empatica, vicina alle storie degli amici, dei compagni di scuola, alle persone LGBTQ+ che conoscono e amano. Gli adulti, invece, parlano spesso da un piano teorico o normativo. Ne escono dialoghi frustrati, a volte dolorosi. L’autrice racconta anche un laboratorio realizzato in Messico, in cui giovani e adulti hanno potuto finalmente confrontarsi senza pregiudizi, trovando punti in comune e smontando molti stereotipi reciproci. Il messaggio? Il dialogo è possibile, ma va preparato con cura.
Sul piano dei contenuti, Rodríguez ricostruisce con chiarezza la storia del termine “genere”: dalla psichiatria degli anni ’60, al femminismo americano, fino al suo ingresso nei documenti politici internazionali (ONU, Pechino 1995). Mostra come il termine abbia assunto significati diversi e spesso contraddittori, e come questo renda il confronto difficile. Ma – e qui sta il cuore del libro – invita a non buttare via tutto: molte domande poste dalle teorie di genere, anche quelle più critiche verso la tradizione cristiana, sono legittime e pongono interrogativi veri sull’identità, sul corpo, sulla relazione tra natura e cultura.
Nella seconda parte del libro, l’autrice propone una rilettura antropologica della differenza sessuale, mettendo in luce l’importanza del corpo e del dato biologico, ma riconoscendo anche che l’identità personale si costruisce lungo un percorso, spesso complesso, che coinvolge la psicologia, l’ambiente, le relazioni. Affronta anche due temi scottanti: gli stereotipi di genere e l’omosessualità. Qui il suo approccio è molto chiaro: non banalizza, non giudica, ma cerca di offrire strumenti di comprensione, con un linguaggio rispettoso e mai ideologico.
Il libro si chiude con una sezione più pastorale: cosa può fare la Chiesa per accompagnare i giovani su questi temi? La risposta dell’autrice non è moralistica: invita a riscoprire il metodo di Gesù, fatto di ascolto, empatia, verità e accoglienza. Non si tratta di rinunciare ai contenuti, ma di trovare modi nuovi per proporli, partendo dalle domande reali delle persone.
Il genere, i giovani e la Chiesa è un testo che non offre risposte pronte, ma strumenti per orientarsi. Può essere utile a genitori, educatori, insegnanti, ma anche a chi, semplicemente, vuole capire meglio un tema spesso affrontato con superficialità. Rodríguez non nasconde la complessità, ma ci invita a non temerla. E a credere che, anche sui terreni più difficili, il dialogo è possibile.