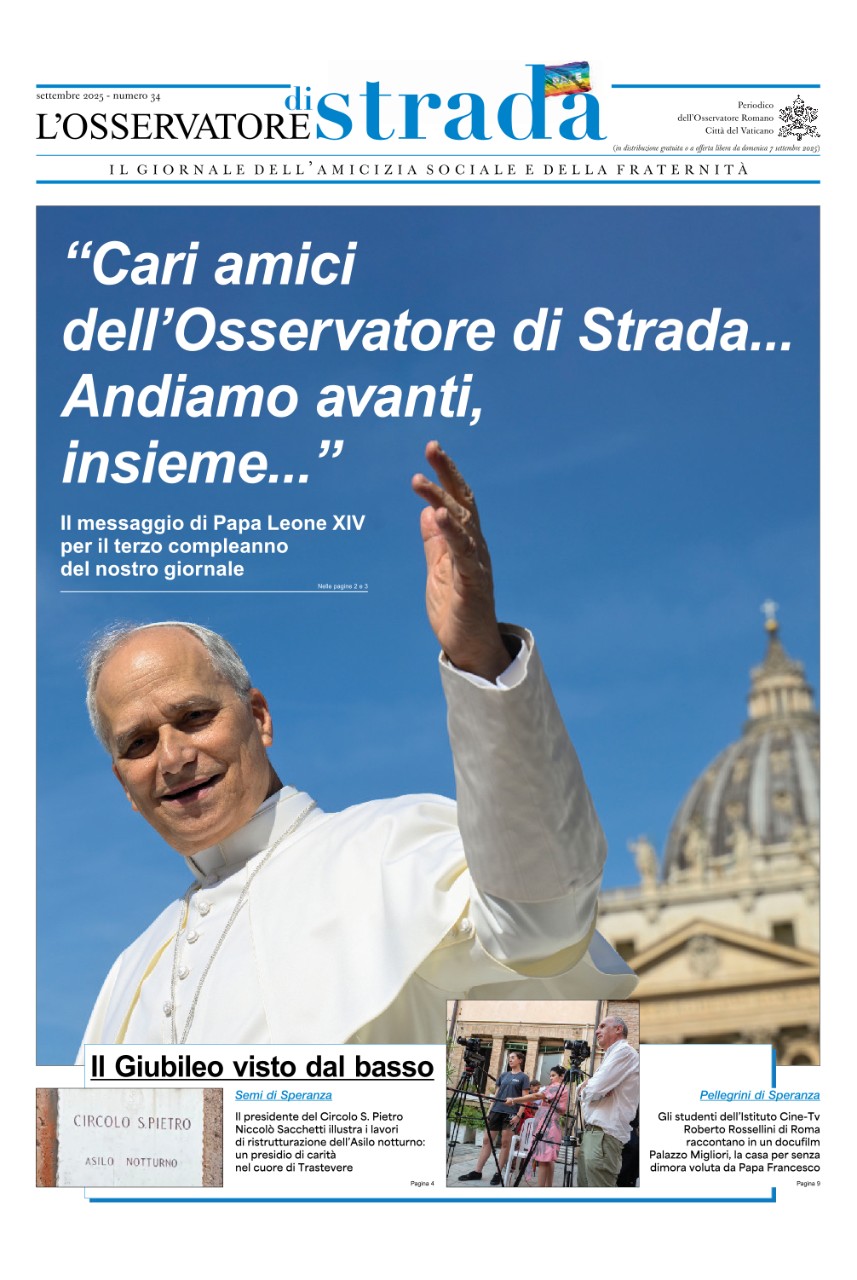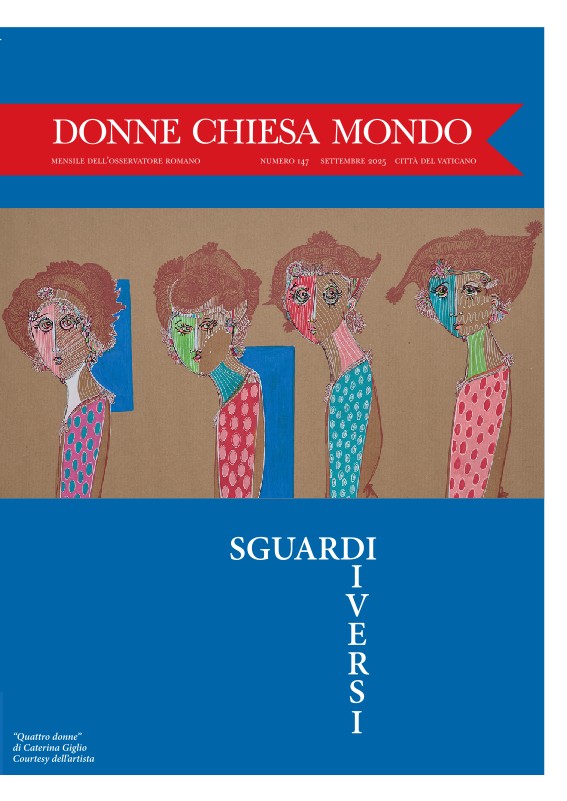L’inganno veniva letteralmente messo in scena quando le future monache erano ancora bambine, ignare di cosa fosse realmente una vita di clausura. Padri e madri conducevano le figlie nei conventi, dove le religiose lavoravano per addobbare le piante del chiostro con dolciumi e leccornie; alle piccole veniva poi raccontato che quello era un giardino delle delizie, dove gli alberi producevano cibi ghiotti. Attirate da una vita apparentemente paradisiaca, senza fatiche e con grande libertà di movimento, le novizie scoprivano presto che quella era soltanto una crudele rappresentazione teatrale.
Per le giovani ingannate la realtà del convento, scrive Arcangela Tarabotti, era infatti simile a un inferno. Anzi, la sua immagine è ben peggiore: «una cloaca di immondizie e incomodità», sia per il corpo che per lo spirito.
Spogliate di tutto, sacrificate dalla famiglia per consentire una dote più ricca alle altre figlie destinate al matrimonio, chiuse nel convento come dentro un carcere, in balìa di invidie, dispetti e disperazione: Tarabotti conosceva bene la condizione delle donne costrette a prendere i voti, visto che nel 1615 a undici anni fu portata nel convento di Sant'Anna in Castello, a Venezia, e non uscì mai più.
Ma scrisse Inferno monacale, un'opera colma di invettive contro un sistema che costringeva centinaia di ragazze a fingere di voler indossare gli abiti monacali, pura ipocrisia per nascondere le vere ragioni di quelle tumulazioni in vita: «Volete che una viva tra gli agi e le pompe del mondo, e che l'altre stiano miseramente chiuse tra mille stenti e infelicità».
Anche ad Arcangela, come a molte ragazze della sua età, i genitori promisero che sarebbe stata coinvolta comunque nelle relazioni e negli agi famigliari, promesse che non vennero mai mantenute. Abbandonate dagli affetti, le monache forzate dovevano spesso patire anche l'onta di chiedere al padre di saldare quanto dovuto annualmente per il mantenimento, circa 60 ducati. A loro non era destinato nulla, anche per legge, visto che entrando in convento firmavano un atto notarile con il quale rinunciavano a qualsiasi pretesa sul patrimonio di famiglia.
Per Tarabotti le durissime privazioni materiali erano soltanto un aspetto aspro della vita conventuale; ciò che faceva disperare le suore senza vocazione era la privazione della libertà, e una convivenza malsana in un ambiente dove Dio era lodato soltanto in apparenza, e poi smentito dai comportamenti delle monache che, esasperate, occupavano le giornate ad avvelenare il convento.
Il pamphlet, uno dei primissimi saggi di denuncia sulla condizione femminile, è rimasto semplice manoscritto fino al 1996 e ora è ripubblicato con la cura di tre ricercatrici statunitensi - Meredith K. Ray, Elissa B. Weaver e Lynn Lara Westwater (Edizioni di Storia e Letteratura), che avvolgono il testo di Arcangela Tarabotti di preziose annotazioni storiche e culturali, come le parole dell'allora patriarca di Venezia Giovanni Tiepolo: «Se duemila e più nobildonne, che in questa città vivono rinchiuse nei monasteri (...) avessero potuto disporre in maniera differente del proprio destino, che confusione! che danno! che disordine!».
Che il convento fosse una soluzione politica per far sparire le donne ritenute in eccesso non sfuggiva a Tarabotti, che della propria vicissitudine fece un grido collettivo di denuncia. Il Concilio di Trento aveva da poco imposto alle religiose la clausura strettissima e il cambiamento fu così drastico che non poche monache tentarono di evadere, o si tolsero la vita. Allo stesso tempo la Chiesa della Controriforma prevedeva un colloquio per le aspiranti novizie in modo da evitare che nei conventi entrassero donne sprovviste della minima vocazione, e Tarabotti non risparmia le sue invettive incandescenti contro tale pratica facilmente aggirabile, visto che non c'era modo di scoprire se una ragazza abbracciava la vita monacale per vera fede o piuttosto per le minacce e le grida dei genitori contro «le figliole, spinte a forza ne' chiostri».
Elena Cassandra Tarabotti, la futura Arcangela, nacque in un momento storico nel quale sposare una figlia femmina era diventato molto dispendioso.
Primogenita di Stefano Tarabotti, chimico, e Maria Cadena de' Tolentini, venne al mondo nel 1604 a Venezia con una zoppìa congenita ereditata dal padre e che agli occhi dei genitori fu un motivo sufficiente per escluderla dal mercato matrimoniale. Capitava spesso che le prime nate non si sposassero per accumulare maggiori fortune da destinare alle sorelle più giovani; dopo Elena Cassandra, infatti, nacquero addirittura altre sei femmine. Una di loro, Lorenzina, sposò con sfarzo l'avvocato Giacomo Pighetti, mentre un'altra - Caterina - diventò pittrice nella bottega di Alessandro Varotari detto il Padovanino; la loro condizione di donne libere, ricche e colte è sia motivo di orgoglio per Arcangela, sia di intensa invidia che la monaca riversa nei suoi scritti amarissimi. La "tradita fanciulla", scrive nell'Inferno monacale, a differenza delle sorelle viene spogliata di qualsiasi ornamento, rasata la testa, fatta indossare una tonaca di materiale rozzo con una cintura di cuoio e una cuffia simile a quella indossata dalle vedove. Il paragone con l'inferno dantesco è intenso e continuo: la libertà dei famigliari rimasti nel mondo diventa un supplizio per le monache che «hanno presenti l'acque senza poterne gustare una minima stilla».
Il tormento è così pesante, scrive Tarabotti, che queste donne «benigne, tacite e care» per natura «divengono sdegnose e inviperite» per colpa di una incarcerazione ingiusta e ingannevole. La scrittrice assolve sempre le badesse e le monache che si comportano in maniera iniqua, e invece non assolve mai coloro che a suo giudizio sono i colpevoli, ossia i padri e la società veneziana. Per le consorelle prova pena, a volte un sentimento simile all'amicizia, spesso stroncata da monache «per invidia livide». Donna colta e lucida, non le sfugge che nemmeno le sorelle di sangue non avevano scelto la propria sorte, comprese le tre che rimasero nubili e che, dopo la morte dei genitori, andarono a vivere presso dei parenti e finirono anch'esse in un monastero. Lei, intanto, a sedici anni prese l'abito e il nome nuovo di Arcangela, fece professione solenne a diciannove e soltanto nel 1629, a venticinque anni, fu consacrata.
Mai nessuna, prima di Tarabotti, aveva descritto le «diaboliche serpi» che tutte insieme congiurano per rinchiudere ragazze innocenti dentro delle vere e proprie prigioni. Può stupire che dietro le mura del convento di Sant'Anna, costretta a liturgie svuotate di significato, Arcangela Tarabotti abbia potuto coltivare una carriera letteraria così fertile. I suoi scritti, in un italiano barocco ed elegante, sono punteggiati di citazioni di Dante, Ariosto, Torquato Tasso e Machiavelli, insieme a quelle dei maggiori classici latini come Ovidio e Seneca. Le ragioni sono tutte nella storia della Repubblica di Venezia, spesso in conflitto con lo Stato della Chiesa. Proprio a Venezia fece fortuna Giovan Francesco Loredan, politico di grande influenza e ostile a Roma, che rimase colpito dagli scritti della monaca, e la aiutò a pubblicare nel 1643 il Paradiso monacale, dove per contrasto Tarabotti descrive invece la beatitudine della vita in monastero per le religiose che l'hanno scelta con gioia. Nonostante Venezia fosse la patria della stampa libera, non fu semplice trovare editori per gli altri saggi della monaca.
Se Inferno monacale pareva anche all'autrice un sasso troppo infuocato da lanciare contro le istituzioni del tempo, nemmeno Loredan ebbe il coraggio di spendere il suo potere in favore di un altro libro di Tarabotti, Tirannia paterna che alla fine venne dato alle stampe a Leida (Paesi Bassi) con uno pseudonimo, per poi finire nel 1661 nell'Indice dei libri proibiti dalla Chiesa con il titolo La semplicità ingannata.
Tarabotti non riuscì a cambiare il destino delle ragazze costrette a diventare monache, se non per qualche migliorìa che i governanti veneziani vollero apportare ai conventi, come l'abolizione dei letti di paglia. Eppure la sua voce, chiara e potente, continuò a denunciare l'ingiustizia morale e materiale commessa ai danni delle donne, non solo religiose. Divenuta una intellettuale rispettata riusciva a convocare nel Parlatorio del suo convento una schiera di nobili e patrizie veneziane, mercanti uomini e donne, scrittrici e poetesse, frati e ambasciatori, un salotto letterario nel quale venivano esaltate le qualità delle donne contro la misoginia del tempo. «Se fossero d'altro sesso, ad esse toccarebbe il comandare e il governare il Mondo», diceva il patriarca Tiepolo con onestà. Tarabotti non poteva essere maggiormente d'accordo. Lo urlò e lo scrisse tutta la vita, fino a quando si spense nel 1652.
di Laura Eduati