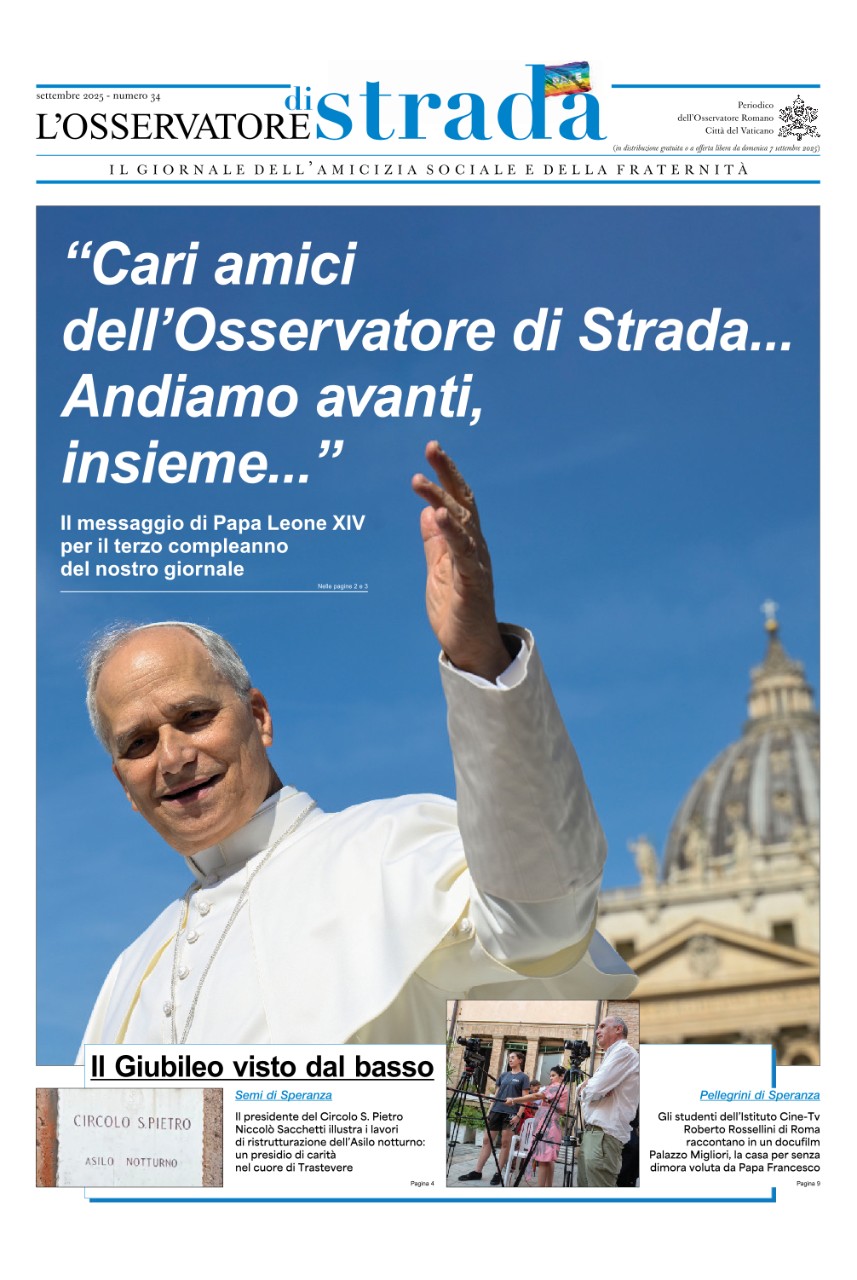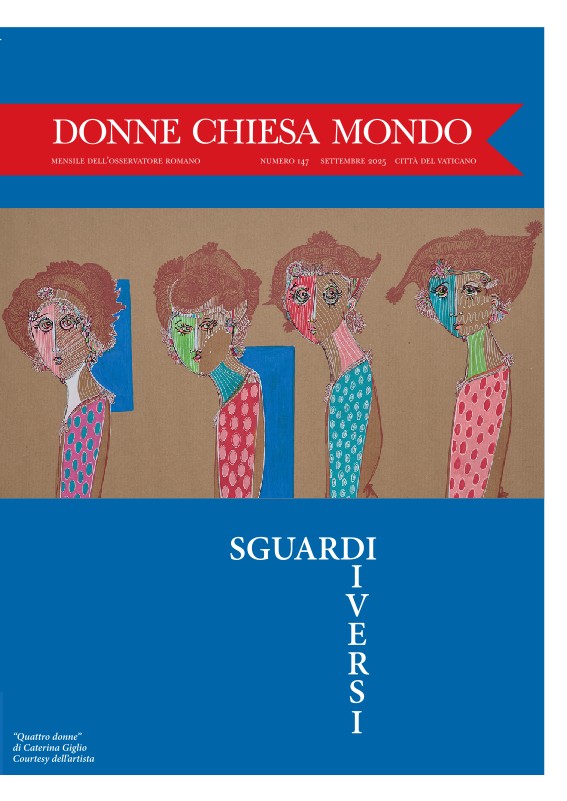A vent’anni, Florence Delay si trovò a incarnare sul grande schermo una delle figure più ribelli della storia: Giovanna d'Arco. Era il 1962 quando Robert Bresson la scelse per Processo a Giovanna d'Arco, un film poetico in bianco e nero che raccontava l’udienza preliminare della Pulzella d'Orléans nella prigione di Rouen. La giovane attrice, accreditata con il cognome materno Carrez per volere dei genitori, riuscì a incarnare perfettamente quella «giovane donna fragile e forte che si oppone al pubblico ministero e vescovo Pierre Cauchon che la condanna al rogo».
Il debutto cinematografico non fu casuale nella vita di Florence Delay, scomparsa a Parigi il 1° luglio 2025 all’età di 84 anni. La scelta di interpretare Giovanna d’Arco rappresentava già una sintesi perfetta di quello che sarebbe diventato il filo conduttore della sua esistenza: l’intreccio profondo tra arte e una spiritualità personale e anticonformista.
Delay, che nel 2000 sarebbe diventata la quarta donna ad entrare nell’Académie française occupando il seggio numero 10, aveva infatti un rapporto molto particolare con la religione. Non era una credente tradizionale (ma non lo era in nulla) e dalla fede si era ad un certo punto allontanata, poi era tornata. Anni fa in un’intervista parlava della necessità di riscoprire «la giovinezza dei primi cristiani, né affermati né potenti, a volte considerati ridicoli. Una debolezza che, in realtà, è una forza».
La sua era una spiritualità che rifiutava i compromessi con il potere, che cercava autenticità lontano dalle istituzioni ufficiali. «Questo ritorno alla semi-clandestina, con la gioia e non il senso di martirio che implica, mi dà energia!», diceva. Ciò che la attraeva era l’idea di una fede gioiosa, liberata dai sensi di colpa e dalle imposizioni: «Personalmente, è l’idea di un cristianesimo gioioso che mi ha avvicinato ad esso dopo averlo abbandonato».
Questa dimensione gioiosa della spiritualità emergeva già nella sua infanzia. Ricordava con tenerezza le recite scolastiche nel suo istituto cattolico, dove interpretava il ruolo dell’asina in La vendetta di Cadichon. Inizialmente scontenta per il ruolo assegnatole, aveva trovato consolazione nelle parole di una suora: «Gesù aveva scelto un puledro per entrare a Gerusalemme». Un aneddoto che rivela come fin da piccola avesse imparato a vedere la bellezza nell’umiltà, la forza nella fragilità.
Il suo rapporto con la fede nasceva in famiglia. «Mia nonna era molto religiosa» raccontava e diceva che aveva «cugini domenicani», ma poi aveva assistito anche all’evoluzione delle generazioni successive: «Oggi mia sorella non pratica più e le mie nipoti sono molto lontane da tutto questo». Questa trasformazione non la scoraggiava, ma la spingeva a immaginare nuovi modi di vivere la spiritualità.
Nel libro Non ci sono cavalli sulla strada di Damasco partiva da un’osservazione apparentemente banale: nei testi originali non si parla di cavalli durante la conversione di Paolo sulla via di Damasco, mentre l’arte ce lo ha sempre mostrato cadere da cavallo. Da questa discrepanza tra testo e immagine, Delay sviluppava una riflessione più ampia su come spesso le rappresentazioni tradizionali si allontanino dalle fonti originali, creando miti che finiscono per sostituire la realtà.
Era una donna che non aveva paura di mettere in discussione le versioni ufficiali, che cercava la sua verità personale anche quando questo significava andare controcorrente. La sua visione del ruolo femminile nella Chiesa era pragmatica e un po’ ironica: le donne «sono già lì, ben presenti, nel catechismo, nelle attività parrocchiali, in tutti questi compiti che la Chiesa riserva ai “non-CEO”».
Florence Delay rappresentava una generazione di donne intellettuali che non si accontentavano di ricevere passivamente una tradizione, ma la interrogavano, la rielaboravano, la facevano propria. La sua fede era un atto di libertà, non di sottomissione. «Anche se i cristiani non fossero altro che un’orda», diceva, «ci sarà sempre, tra loro, un bambino da ammirare».