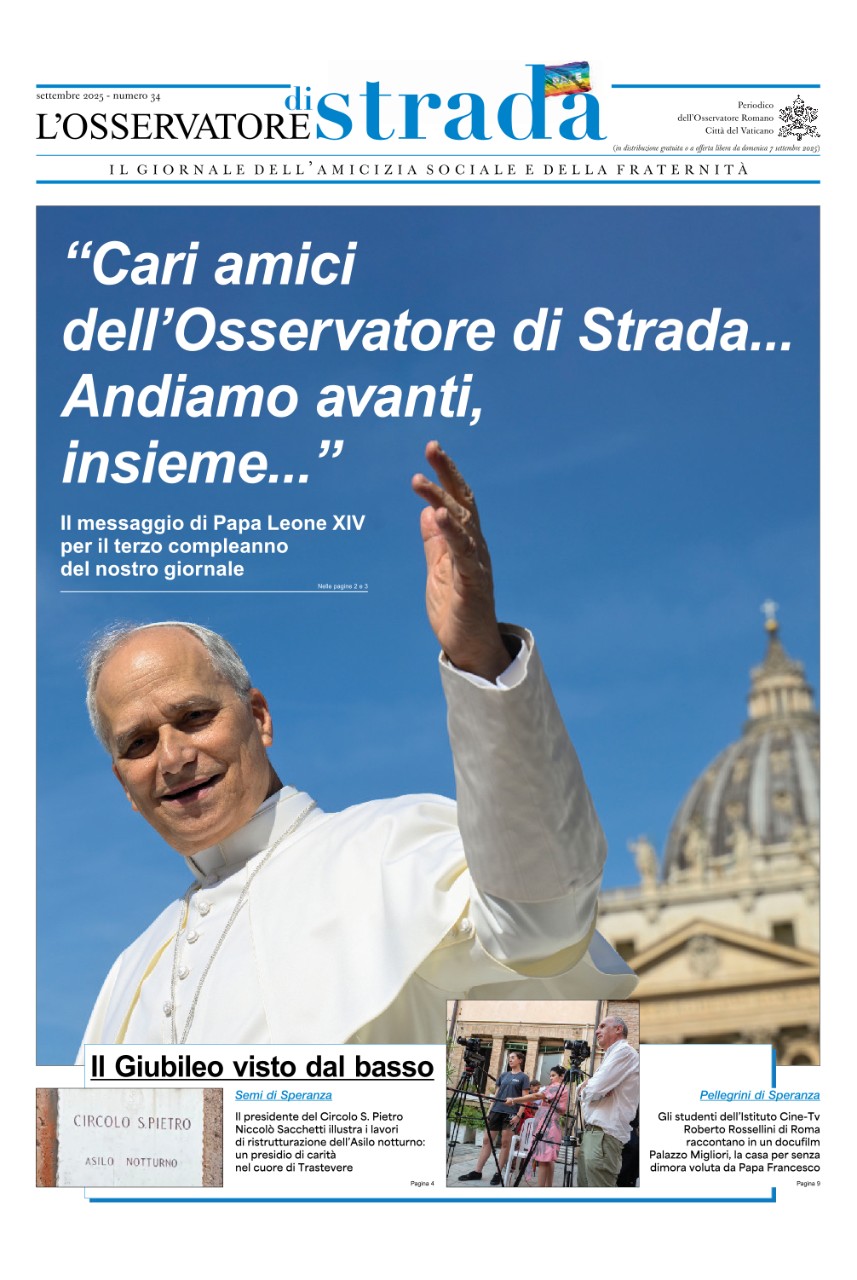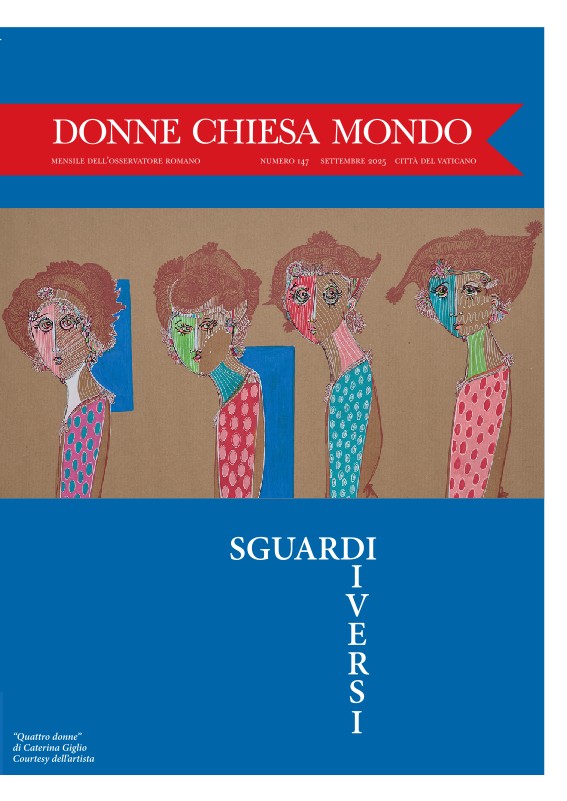E i generali dissero

Ottant’anni fa, di questi giorni, l’Europa si risvegliava libera dal nazifascismo, sgomenta per i lutti, distrutta da anni di guerra, ma forte del suo coraggio e carica di ottimismo nel futuro. Ancora non si era caduti nella spirale della guerra fredda e si poteva esultare tutti assieme per la vittoria del bene sul male. Davvero tutti assieme. Molti religiosi e molte religiose avevano rischiato in prima persona per dare asilo ai perseguitati, ai fuggiaschi, ai resistenti. Alcuni avevano pagato con la vita. E questo ruolo venne riconosciuto apertamente in molti casi. Poi il vento cambiò e le diverse Liberazioni diventarono causa di divisione.
In Francia, in quell’estate 1945, a contendersi il ruolo di leader della Resistenza e in prospettiva di guida politica del Paese erano due celebri generali: Charles De Gaulle ed Henry Giraud. Sul momento, anche perché molto vicino a Churchill e a Roosvelt, sembrò che sarebbe stato il secondo a prevalere. Poi le cose andarono diversamente. Però qui interessa rileggere il libro cult Le mie evasioni del generale Henri Giraud, pubblicato dalla casa editrice Hachette (1946). Pagine e pagine dedicate alla sua rocambolesca fuga da una prigione tedesca e ad una eroica suora vincenziana, Hélène Studler, delle Figlie della Carità, responsabile di un ospedale cattolico a Metz, in Alsazia, che aiutò almeno duemila persone a sfuggire ai nazisti.
«Suor Hélène era stata ella stessa imprigionata dai tedeschi – scrive il generale – a seguito delle multiple evasioni che aveva facilitato, e lei stessa evase da una prigione tedesca per raggiungere la Francia alla fine del 1941. Una vera patriota, di particolare intelligenza». Tra i tanti altri, suor Studler aiutò a scappare anche un giovane ufficiale che si chiamava François Mitterrand. Suor Studler, gravemente malata e ricercata dai nazisti, morì in un ospedale nel 1944, mentre infuriavano i combattimenti per liberare Metz, la sua città. Narra la leggenda che il generale Giraud le tenesse le mani nel momento del trapasso. Due anni dopo fu lui a tenere il suo elogio funebre e a conferirle l’Ordine nazionale della Legion d'onore e la Croce di guerra con palme. Di recente la vicenda di suor Studler è stata raccontata dal film La rete della libertàdel regista spagnolo Pablo Moreno.
In Italia ci fu un’altra suora che ebbe un ruolo cruciale per la Liberazione e un altro grande generale lo riconobbe con riconoscenza. Pochi sanno o ricordano, infatti, che il comando del Corpo Volontari della Libertà, organo di cerniera tra il Governo del Sud, gli Alleati e i partigiani, si nascondeva a Milano nell’Istituto della Riparazione, comunemente detto il Convento delle ragazze traviate, in Corso Magenta. Ed era il 5 maggio 1945 quando una lettera del comandante, il generale Raffaele Cadorna, venne recapitata alla Madre superiora Rosa Chiarina Scolari. Il generale non soltanto riconosceva pubblicamente il grande rischio che madre Scolari e le sue consorelle avevano sfidato, e perciò le ringraziava, ma le invitava addirittura alla sfilata che avrebbe celebrato la Liberazione d’Italia. «Reverendissima Madre Generale – scriveva il comandante in capo di tutta la Resistenza italiana - il Comando Generale militare desidera esprimerle i più vivi ringraziamenti per la cordiale ospitalità datagli nei giorni che precedettero la liberazione, e nella memoranda notte che segnò la fine della tirannide. Per noi quelle ore di intenso lavoro svolto nella serena quiete del suo Monastero rimarranno nel nostro più caro ricordo, come un giorno gli italiani conosceranno che da codeste mura partirono gli ordini per la risurrezione della Patria. Era un riconoscimento importante a sottolineare il carattere patriottico e molto poco politico della Resistenza.
Un altro generale italiano celebre a quel tempo, Emanuele Pugliese, aveva avuto molto da temere nei giorni dell’occupazione nazifascista di Roma. Lo odiavano particolarmente per un duplice motivo: perché di religione ebraica e perché era stato l’unico a volere la difesa della Capitale nell’ottobre 1922, quando gli uomini di Benito Mussolini tennero la Marcia su Roma. La sua fortuna fu l’ospitalità della Chiesa. Lo nascosero, lui e la moglie, ormai anziani, nella Casa guanelliana di Santa Maria della Provvidenza, alla periferia di Roma, che nel 1944 era abitata da centinaia di ospiti sotto la guida della lombarda suor Teresa Vismara. Subito, appena liberata la città, il generale scrisse una lettera di ringraziamento a monsignor Alberto Arborio Mella di Sant’Elia, che era Maestro di camera del Pontefice: «La Rev.da Madre Superiora, Suor Teresa Vismara! Don Giuseppe, parlandomi inizialmente di lei, mi disse: “È un’anima santa!” . Parvemi, dapprima, eccessivo tale giudizio, la constatazione dei fatti lo ha, invece, pienamente confermato».
Suor Vismara non si nascondeva il rischio. Disse poi che s’aspettava ogni giorno di essere scoperta e fucilata. Ma la carità veniva innanzitutto. «Essa, senza nulla sapere della mia situazione, che Don Giuseppe non aveva ritenuto di rivelarle, ma intuendone la gravità, anzi, inizialmente, come mi disse in appresso, avendo perfino dubitato che la mia presenza potesse recar danno all’Opera immensa di carità, da Lei attuata per decine di altri infelici, nel quale il provvedere al migliaio di ricoverati dell’Istituto costituiva un problema quasi insolvibile, seppe ridarmi la pace dello spirito».
La lettera del generale Pugliese è una vivida testimonianza di ciò che vide in quei mesi dietro le mura di una Casa di Don Guanella. «Unitamente alla sua opera memoranda a mio favore, io ho potuto in questi tre mesi di soggiorno presso l’Istituto ammirare quella sublime da lei compiuta, accogliendo, nascondendo, alimentando, (parecchi gratuitamente), decine di ebrei, uomini, donne; di patrioti, ufficiali, militari di truppa, carabinieri, guardie di P. S. costretti ad occultarsi, per non tradire la fede giurata, organizzando, con acuta preveggenza, un magistrale sistema di occultamento per i medesimi, nell’eventualità di probabili perquisizioni… tutto questo, ripeto, Suor Vismara ha fatto, con piena coscienza del pericolo mortale, a cui si esponeva!».
Anche il generale Pugliese sarebbe stato un protagonista dell’immediato dopoguerra in Italia, quando, nel 1946, pubblicò un libro di memorie, Io difendo l’esercito, che vigorosamente spiegava come le forze armate italiane nel 1922 fossero pronte a reprimere l’insurrezione fascista, ma che all’ultimo fu il re a cambiare idea e a dare ordine di smobilitare.
Come ormai è noto, nei mesi più bui dell’occupazione nazista, in Europa le porte di conventi e monasteri si aprirono per accogliere e proteggere molti cittadini di religione ebraica. Un pezzo alla volta questa realtà sta emergendo. Ad esempio la vicenda delle decine di ragazzi ebrei nascosti dai salesiani nell’istituto di Piazza Santa Maria Ausiliatrice. I fatti avvenivano in piena persecuzione nazista, raccontati dal libro Non abbiamo fatto che il nostro dovere di Francesco Motto e dal docufilm Lo scudo dell’altro regia di Gloria Giordani.
A caldo è quanto scoprì con stupita gratitudine un rabbino di Parigi, il capitano André Zaoui, aggregato all’esercito francese come ministro di culto. Il capitano rabbino arrivò a Roma con le truppe Alleate nel 1944 e di getto scrisse una lettera al Papa Pio XII per ringraziarlo e manifestare i «sentimenti di profonda riconoscenza e rispettosa ammirazione dei miei fratelli israeliti per il bene immenso e la carità incomparabile che Vostra Santità ha prodigato agli ebrei. A Roma l’Istituto Pio XI ha protetto per più di sei mesi una sessantina di bambini ebrei. Sono rimasto ammirato per la sollecitudine paterna che i responsabili avevano per queste giovani anime».
Tutto ciò, insomma, venne scritto quando erano ancora travolgenti le emozioni della guerra appena terminata e non si facevano troppi calcoli su quel che era il caso di dire o non dire.
di Francesco Grignetti
Giornalista «La Stampa»