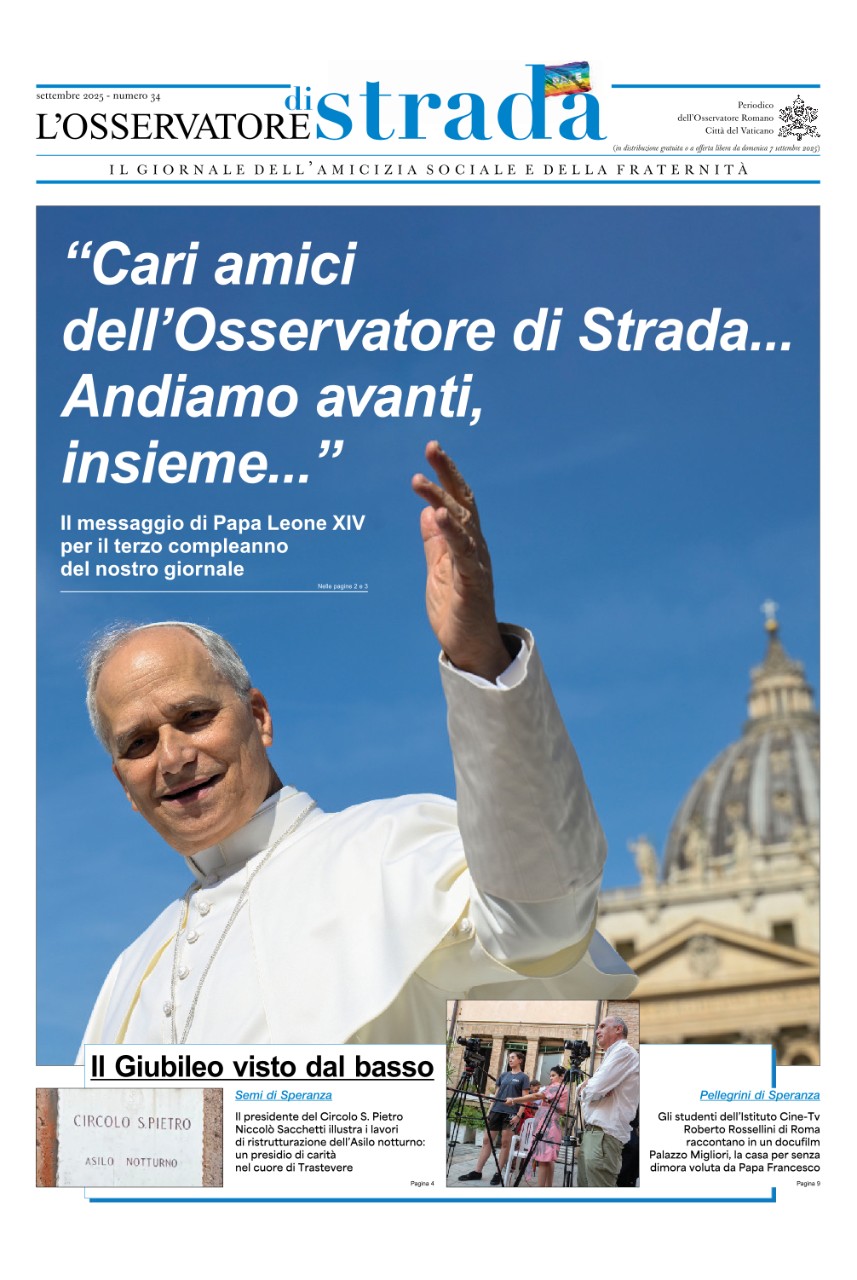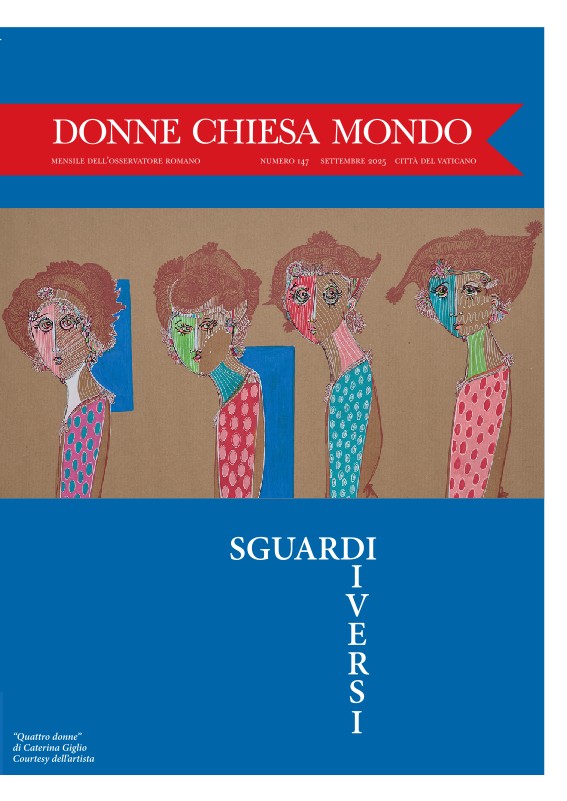Decolonizzare

di Giulio Albanese
Quando parliamo dell’Africa, quali parole usiamo? E da dove provengono quelle parole? Le lingue, in effetti, non sono neutre. Al di là del puro sistema comunicativo finalizzato a relazionare tra loro gli esseri umani, esse sono uno strumento di potere, un dispositivo ideologico che può costruire o distruggere identità. Per chi ha avuto modo d’immergersi nelle culture afro, una delle prime percezioni riguarda l’impatto del linguaggio coloniale sulle popolazioni. Esso ha agito come una sorta di forza invisibile, ma pervasiva, modellando la percezione del continente e di chi lo abita. Da questo punto di vista, il processo di decolonizzazione linguistica in Africa ha trovato nelle Chiese africane, soprattutto nell’epoca postcoloniale, delle agenzie educative in grado di restituire voce e dignità alle culture africane. Ma andiamo per ordine.
In Africa, il linguaggio ha giocato un ruolo centrale nel progetto coloniale, non solo come mezzo di comunicazione, ma come dispositivo ideologico. Decolonizzare la lingua significa dunque smantellare le strutture linguistiche che perpetuano visioni eurocentriche e restituire dignità alle lingue e ai concetti indigeni. Durante il periodo coloniale, le lingue europee — inglese, francese, portoghese — per non parlare dell’arabo, furono imposte — a dire il vero non solo in Africa — come lingue ufficiali, scolastiche e amministrative. Questo processo ha avuto effetti invasivi assolutamente non trascurabili. Ad esempio, ha marginalizzato le oltre duemila lingue autoctone, relegandole a contesti informali o domestici. Non solo: ha introdotto categorie linguistiche che distorcono la realtà africana come nel caso del termine “tribù” come vedremo più avanti. Ma l’uso delle lingue dei cosiddetti conquistatori ha consolidato una gerarchia simbolica in cui il sapere europeo è considerato superiore.
Né la questione può confinarsi solo a retaggio del passato: per restare solo all’esempio più rilevante, la penetrazione economica, sociale e in ultima analisi geopolitica della Cina in Africa si esprime anche con il crescente insediamento di istituti di istruzione della lingua cinese.
Più in generale, come sostiene pertinentemente il filosofo, africanista e storico camerunese Achille Mbembe, il colonialismo non ha solo conquistato territori, ma ha colonizzato l’immaginario, imponendo una grammatica del mondo che escludeva l’Africa come soggetto pensante. Fondamentale per comprendere la posta in gioco è anche il contributo di Ngũgĩ wa Thiong’o, noto anche come James Ngugi, scomparso il 28 maggio scorso, che è stato uno dei principali autori della letteratura africana. Nel suo saggio Decolonising the Mind (1986), egli denunciò l’uso delle lingue coloniali come forma di alienazione culturale. Secondo Ngũgĩ, scrivere in inglese equivale a pensare con la mente del colonizzatore. La sua scelta di abbandonare l’inglese per il kikuyu fu dunque un atto politico: «La lingua è il portatore della cultura. Se perdi la tua lingua, perdi la tua cultura. Se perdi la tua cultura, perdi te stesso». Ngũgĩ propose, pertanto, una letteratura africana scritta nelle lingue africane, capace di esprimere visioni del mondo radicate nei contesti locali e di resistere all’omologazione culturale.
Molti termini usati per descrivere l’Africa, d’altronde, sono carichi di retaggi coloniali. “Tribù”, ad esempio, è spesso utilizzato per descrivere gruppi etnici africani, ma implica una visione arcaica, primitiva e statica. Oggi appare anacronistico pensare che i baganda che vivono in Uganda, che parlano una lingua molto complessa come il luganda e sono circa 14 milioni, vengano considerati una tribù, mentre gli svizzeri che sono 9 milioni, siano considerati una nazione. Gli antropologi contemporanei, come Kwame Anthony Appiah, criticano l’uso del termine tribù, sottolineando che le società africane sono dinamiche, complesse e moderne. Ma non è tutto qui. Prendiamo ad esempio il termine “nativo” o “popolazioni indigene”. Questi termini, sebbene usati anche in contesti legittimi, sono spesso stati impiegati per distinguere i colonizzati dai colonizzatori, con una connotazione di inferiorità o arretratezza. In molti testi coloniali, “nativo” indicava una persona priva di civiltà, educazione o razionalità, in contrasto con l’“europeo civilizzato”. E cosa dire delle abitazioni? Molti testi descrivono le case africane come “capanne”, termine che evoca povertà e primitivismo inteso come estetica del brutto o dell’imperfetto. In realtà, molte strutture tradizionali africane sono frutto di ingegneria sofisticata, adattata all’ambiente e alle risorse locali. Sempre nel contesto afro, il termine “dialetto” è stato spesso usato dai colonizzatori e dunque imposto per sminuire le lingue autoctone, suggerendo che fossero forme linguistiche incomplete, locali, e prive di prestigio. Questo uso alla prova dei fatti non è neutro: è il risultato di una visione coloniale che ha imposto le lingue europee come “lingue vere” e relegato le lingue africane a un ruolo secondario. Secondo la definizione sociolinguistica tradizionale, un dialetto è spesso percepito nell’immaginario nostrano come meno prestigioso, utilizzabile in contesti informali e comunque privo di una tradizione scritta o letteraria.
Ma questa definizione è profondamente influenzata da dinamiche di potere. In realtà, molte lingue africane hanno milioni di parlanti (hausa, luganda, swahili, yoruba), possiedono sistemi grammaticali complessi e vengono oggi usate in letteratura, comunicazione massmediale, istruzione e religione. Come nota il linguista Mauro Tosco, la distinzione tra “lingua” e “dialetto” è spesso politica, non scientifica. In questa prospettiva, decolonizzare il linguaggio significa anche rivedere il vocabolario con cui si parla dell’Africa, evitando espressioni che riducono la sua diversità culturale a stereotipi.
Oggi, molti movimenti culturali e accademici africani promuovono la valorizzazione delle lingue autoctone. Storicamente, i primi furono i missionari cristiani a studiare e documentare le lingue africane. Il loro obiettivo era evangelizzare, ma per farlo dovevano comprendere e tradurre i testi sacri nelle lingue locali. Questo ha portato alla creazione di grammatiche e dizionari di lingue africane, alla traduzione della Bibbia e di testi religiosi nelle lingue dei vari gruppi etnici e all’alfabetizzazione delle popolazioni locali nelle proprie lingue. Nel XIX secolo, missionari protestanti britannici come quelli della Church Missionary Society tradussero la Bibbia in lingue come yoruba, igbo e hausa. Il reverendo Samuel Ajayi Crowther, ex schiavo nigeriano e primo vescovo anglicano africano, fu fondamentale nella standardizzazione della lingua yoruba e nella sua diffusione scritta.
I missionari cattolici fecero lo stesso contribuendo alla codificazione di kikongo, lingala, kinyarwanda, luganda, acholi, alur, madi, lango e tante altre altre. Alcuni istituti missionari, come i Padri Bianchi e i Comboniani, già in epoca coloniale, produssero negli anni materiali didattici e testi liturgici in lingue locali, favorendo l’uso scritto e scolastico di queste lingue. In Sud Africa, l’isiZulu e l’isiXhosa sono lingue ufficiali accanto all’inglese, mentre in Senegal, il wolof è ampiamente usato nei media e nella musica. In Nigeria, scrittori come Chimamanda Ngozi Adichie, incorporano l’igbo nei loro testi in inglese, creando una lingua ibrida che riflette la realtà postcoloniale. Queste pratiche non sono solo estetiche, ma politiche: affermano il diritto degli africani di raccontarsi con le proprie parole. La decolonizzazione linguistica in Africa è un processo complesso, che richiede una revisione critica del linguaggio, delle categorie concettuali e delle pratiche discorsive. Non si tratta solo di promuovere le lingue africane, ma di decostruire le strutture simboliche che perpetuano il dominio coloniale. Come afferma il succitato Ngũgĩ, la liberazione dell’Africa passa anche dalla liberazione della sua lingua.