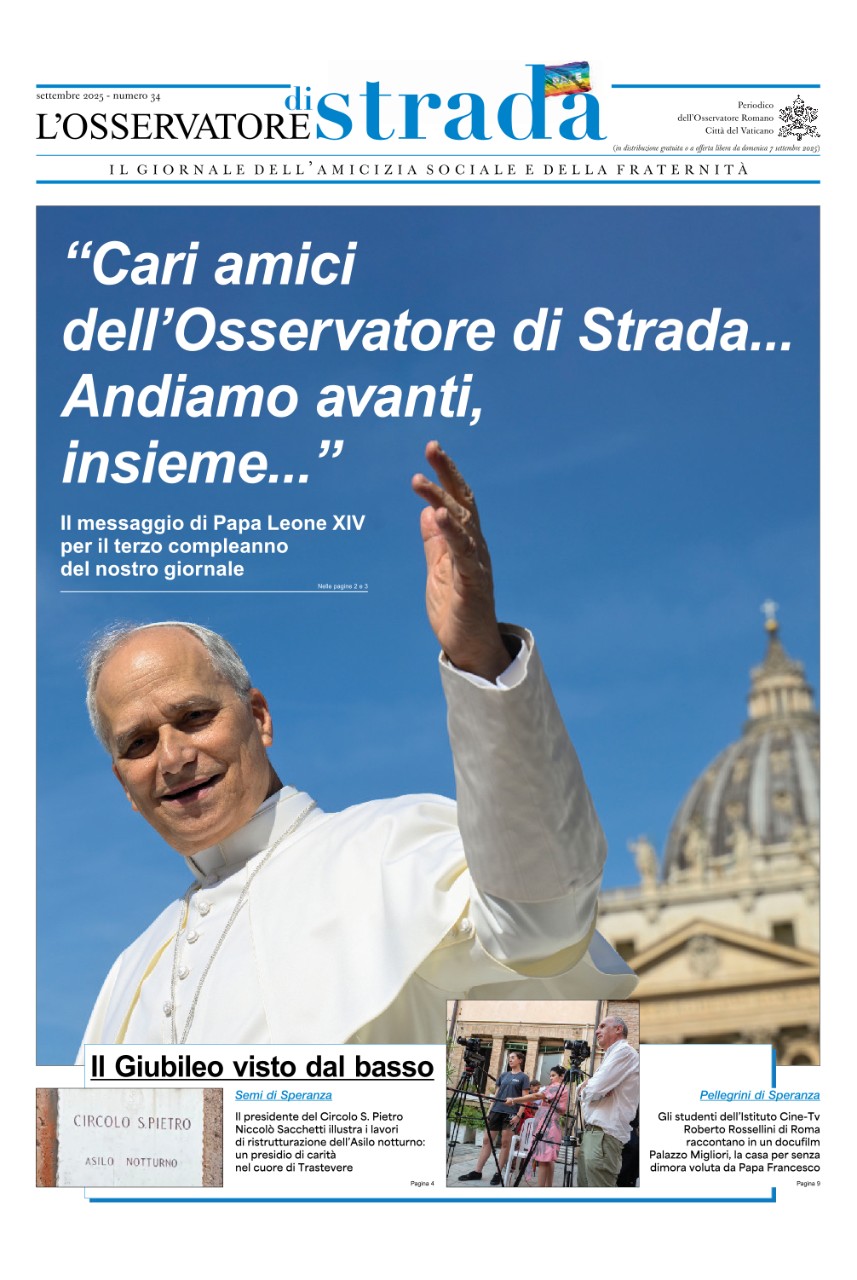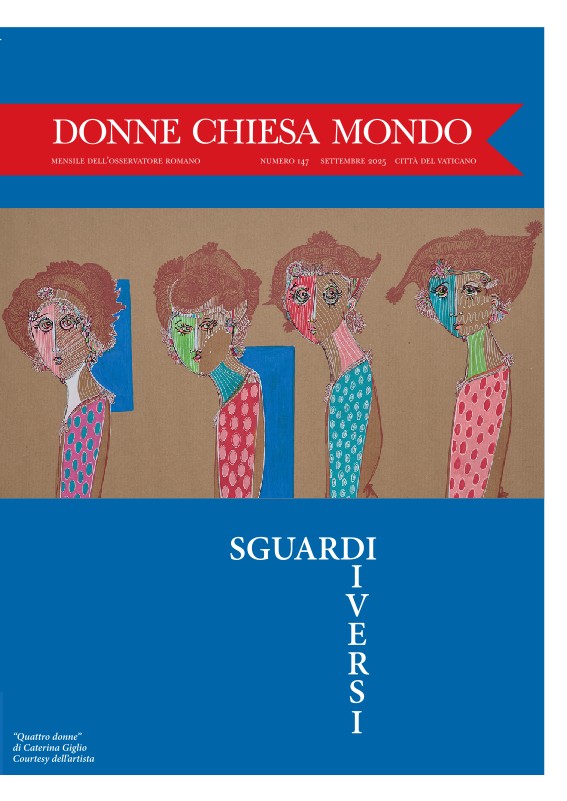La sfida dell’IA

di Antonio Spadaro
Nel passaggio di testimone tra Papa Francesco e Papa Leone un tema appare davvero cruciale, forse più di quanto sia percepibile per chi si occupa esclusivamente di affari ecclesiastici. Nel cuore di un tempo che sembra scivolare in una realtà sempre più automatizzata, Francesco ha lasciato come tema aperto al suo successore la più radicale trasformazione del nostro immaginario contemporaneo: l’intelligenza artificiale. In questo passaggio di pontificato si apre un discorso che non riguarda solo la tecnologia, ma la definizione stessa di cosa significhi essere umani in un’epoca di macchine pensanti.
Nelle loro parole — e già possiamo considerare molto indicative quelle dei primi cento giorni del pontificato di Leone — non c’è nostalgia per un mondo perduto né demonizzazione del progresso. C’è piuttosto il tentativo di pensare criticamente lo scenario che si apre davanti a noi. Di guardare dentro la macchina, e di chiedersi chi stia davvero al centro del suo movimento.
Papa Francesco ha portato nel cuore del dibattito pubblico globale una riflessione sull’AI che non fosse né meramente tecnica né puramente moralistica. Sin dal principio ha riconosciuto il potenziale positivo dell’intelligenza artificiale: non si trattava, per lui, di una semplice minaccia, ma anche di una possibilità. La possibilità, ad esempio, di ridurre la fatica del lavoro umano, di democratizzare l’accesso alla conoscenza, di favorire l’incontro tra popoli e culture attraverso traduzioni automatiche, analisi di dati, reti neurali capaci di elaborare miliardi di informazioni al secondo. Alla fine del suo pontificato è apparso il documento Antiqua et Nova, un’importante Nota sul rapporto tra intelligenza artificiale e intelligenza umana a firma del Dicastero per la Dottrina della Fede e di quello per la Cultura e l’Educazione.
Francesco ha chiarito con insistenza un punto essenziale: l’AI non è neutra. È uno strumento potente, e come ogni potere porta con sé il rischio della manipolazione, della disuguaglianza, della violenza. Francesco ha parlato di «inquinamento cognitivo», espressione che descrive con crudezza l’effetto di una comunicazione digitale sempre più governata da logiche di ottimizzazione e calcolo: le fake news, i deepfakes, la manipolazione dell’opinione pubblica non sono incidenti, ma sintomi di una crisi della verità. L’intelligenza artificiale può essere l’arma perfetta per chi intende piegare la realtà a una narrazione strumentale. E nella sua ultima enciclica, la Dilexit nos, ha affermato: «nell’era dell’intelligenza artificiale, non possiamo dimenticare che per salvare l’umano sono necessari la poesia e l’amore».
Papa Leone XIV ha raccolto questa eredità e l’ha rilanciata sin dalla scelta del suo nome. Il Pontefice neoeletto, incontrando i cardinali che lo hanno scelto, ha spiegato loro le ragioni della scelta del nome: «Papa Leone XIII, con la storica Enciclica Rerum Novarum affrontò la questione sociale nel contesto della prima grande Rivoluzione industriale. Oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di Dottrina sociale per rispondere a un’altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell’intelligenza artificiale, che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro». Nei suoi interventi successivi emerge con chiarezza l’idea che l’AI non possa mai sostituire ciò che è specificamente umano: la coscienza morale, il discernimento, la relazione autentica con l’altro. La macchina può imitare, ma non comprendere; può processare, ma non giudicare; può apprendere, ma non amare. È qui che si gioca il confine, sempre più sottile, tra simulazione e realtà.
L’intelligenza artificiale ha raggiunto un punto in cui può generare testi coerenti, dipinti realistici, composizioni musicali complesse. Può simulare un dialogo, correggere errori grammaticali, persino produrre commenti letterari. Il paradosso è che più la macchina imita l’umano, più l’umano rischia di smarrirsi.
Che cosa significa, allora, essere persone in un mondo dove una macchina può scrivere un saggio sull’amore o comporre una poesia sull’assenza?
Papa Francesco ha insistito sulla necessità di una «sapienza del cuore» che non può essere codificata. Ha parlato dell’urgenza di sviluppare un’etica dell’intelligenza artificiale che metta al centro la dignità della persona umana. Non una retorica astratta, ma una linea di resistenza: la persona come valore non computabile, non surrogabile. E questo significa, tra l’altro, che l’AI deve restare al servizio dell’umano, non sostituirlo. «Non tutto ciò che è tecnicamente possibile è moralmente accettabile», ha scritto.
Papa Leone XIV, da parte sua, ha rifiutato ogni seduzione transumanista, ogni tentazione di pensare la tecnologia come prolungamento dell’umano senza limiti. La macchina, ha detto, può aiutare, ma non redimere. Solo l’umano può aprirsi alle domande ultime dell’esistenza, solo l’umano può orientarsi verso il Vero e il Bene. La vera intelligenza non è quella che analizza dati, ma quella che sceglie responsabilmente, con coscienza. In una parola: quella che discerne.
Nel tempo in cui gli algoritmi decidono chi vedrà cosa, chi otterrà un prestito, chi verrà selezionato per un colloquio di lavoro, l’etica non può più essere un lusso. Papa Francesco ha chiesto esplicitamente un trattato internazionale vincolante che regoli l’uso dell’intelligenza artificiale. Non solo per evitare abusi, ma per stimolare la responsabilità. Ha chiesto che nei dibattiti pubblici vengano ascoltate anche le voci degli esclusi: i poveri, i migranti, i bambini, coloro che non hanno accesso alla tecnologia ma ne subiscono gli effetti.
Papa Leone XIV ha fatto eco a questo appello chiedendo una governance multilivello dell’AI, che sia ispirata ai principi della dottrina sociale della Chiesa ma traducibile in termini laici, condivisibili. In tal senso, il Papa si richiama al concetto di tranquillitas ordinis, la tranquillità dell’ordine proposto da sant’Agostino in De Civitate Dei. Non basta infatti regolare l’AI: bisogna regolare anche le sue finalità. La macchina non può essere lasciata sola a dettare l’agenda.
Entrambi i pontefici vedono il pericolo non solo nella tecnologia, ma nella visione del mondo che essa incarna: una visione che rischia di ridurre la complessità dell’umano a un problema di efficienza. Per Papa Leone XIV la macchina non deve solo funzionare, deve contribuire a un ordine più umano delle relazioni sociali. L’obiettivo dell’AI non deve essere solo la performance, ma la giustizia. Non solo l’efficienza, ma la comunione. In un tempo che sogna di «aumentare» l’umano attraverso la tecnologia, il rischio è di ritrovarsi con un’umanità diminuita, impoverita della propria capacità di giudizio, relazione, meraviglia. Di qui l’urgenza, condivisa da entrambi i Pontefici, di un’educazione al pensiero critico, alla responsabilità, alla cura. In fondo, la vera questione non è che cosa può fare l’intelligenza artificiale, ma che cosa vogliamo fare noi con essa. E soprattutto: chi vogliamo essere.
Nel celebre racconto Hako Otoko cioè L’uomo-scatola nel 1967 lo scrittore giapponese Kōbō Abe immagina un futuro in cui gli uomini, per evitare il dolore, si fanno sostituire da simulacri artificiali. O meglio, scelgono di rinchiudersi volontariamente in una scatola diventando essi stessi esseri-simulacro. L’uomo-scatola è, in un certo senso, un proto-avatar: un corpo che non comunica direttamente, ma filtra la realtà. Ogni volta che la vita fa troppo male, l’avatar prende il loro posto. Ma alla fine, nessuno ricordava più chi fosse l’originale. I fantasmi erano entrati nella macchina.
Forse oggi siamo a quel bivio. E forse per questo la voce di due Pontefici, di due maestri di umanità, risuona con forza in un’epoca che si illude di potersi salvare attraverso il codice. L’IA è qui per restare. Ma noi umani siamo qui per interagire con le nostre domande, i nostri errori, la nostra libertà. In un tempo in cui in Medioriente un esercito bombarda la popolazione facendo scegliere gli obiettivi da una intelligenza artificiale al quale ha dato il nome di Gospel («Vangelo»), ci rendiamo conto che abbiamo sempre più bisogno di ciò che nessuna macchina potrà mai imparare, sebbene ben istruita dai codici: la compassione.