I temi della settimana
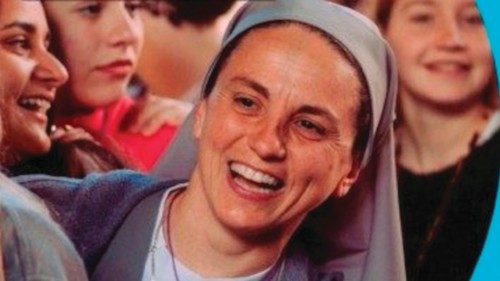
L’eco del Concilio Vaticano ii è fortissima nell’intenzione che per il mese di ottobre il Papa affida all’Apostolato della preghiera. Un’eco che dopo sessant’anni si lascia distinguere così chiaramente deve provenire da una voce più che umana e da profondità imperscrutabili quanto l’abisso del cuore.
La reciprocità invocata da Francesco è narrata da ogni pagina del Nuovo Testamento, così vicino e così lontano: lo ascoltiamo ormai nella nostra lingua, ma resistiamo a modellare la nostra avventura ecclesiale sulla comunione dei primi cristiani. Distinzioni millenarie — fra clero e laici, o fra uomini e donne, ad esempio — non cessano di farsi sperimentare come separazioni che demotivano, quando davanti ai nostri occhi «la messe è molta e gli operai sono pochi». È molta, perché Dio è puntualmente in anticipo e a ogni latitudine — è la meraviglia della cattolicità — ci mostra il miracolo della fede, la feconda stranezza di diventare oggi cristiani. L’abbondanza della grazia e l’ampiezza delle sfide — sembra dirci il Papa — ci chiamano a convergere.
Dobbiamo riconoscere, però, che della reciprocità il cuore umano ha paura. La desidera ardentemente, perché è teso all’intimità, ma a tal punto cerca riconoscimento da temere la presenza altrui come un’ombra e da viverla come un ostacolo. Fraternizzare è difficile. Per questo, dal principio, cristiani si diventa.
È un movimento di sequela in cui gli apostoli per primi, e oggi i loro successori, camminano dietro a un Altro, di conversione in conversione. È lui a portarli nella propria intimità, per rivelare loro a loro stessi e sciogliere la paura.
Se questo non avviene, come attestano i vangeli la chiamata si traduce in privilegio, il gruppo in casta e si riproducono forme del sacro e del governo che proprio in Cristo Dio ha smentito. «Tra voi non è così»: c’è in queste parole del Maestro più di un augurio.
Nella preghiera, anche oggi, la Chiesa si affida alla loro qualità performativa, alla loro potenza trasformativa. Intrisa di misericordia, la liberazione dal clericalismo è un’opera divina da assecondare, una vera e propria de-mondanizzazione, che del sale custodisce il sapore e della luce aumenta l’intensità.
L’espressione “sacerdozio comune” ha spaventato molti, con la sua forza evocativa, e sembra non aver contribuito a coniugare diversamente la missione ecclesiale. Identità più sfumate e più sfidate hanno accentuato la rivendicazione di ruoli e l’accentuazione delle specificità.
Il “comune battesimo”, in questo scorcio della storia, ha maggiori chance di legarci polifonicamente nel medesimo Mistero. Siamo cristiani, non a prescindere, ma dall’interno delle nostre differenze culturali, d’età, di genere, di vocazione e di sensibilità. «Gesù ci ha chiamati, gli uni e gli altri: non gli uni sopra gli altri, né gli uni da una parte e gli altri dall’altra, ma completandoci reciprocamente. Siamo comunità». Papa Francesco, con queste parole, non solo libera i sacerdoti dalla prigione di un sacro che separa e distanzia, ma apre la loro vita alla gioia di vicinanze e di collaborazioni che nutrono lo spirito.
La Parola di Dio ha bisogno di comunità per lasciarsi intendere: essa vibra della vita di tutti, racconta la storia dell’altro, chiede una permanente uscita da se stessi. Non c’è Ecclesia docens senza comune discepolato.
In effetti, “mondo” — quello che Dio ha amato tanto da dare il Figlio suo — non è una parola cattiva per i cristiani. La Chiesa non gli si oppone, né potrebbe farlo, perché ne è intessuta e lo abita, pur recando in se stessa un altrove che squarcia gli status quo e apre in ogni ambiente umano porte e finestre al soffio di Dio. Così, la dinamica espressione “Apostolicam actuositatem” con cui Paolo vi denominò il decreto sull’apostolato dei laici sembra sospingere ancora i battezzati, sacerdoti compresi, ad attuare il Concilio.
La sfida di allora e di oggi, infatti, è riconoscere il Risorto nel mondo contemporaneo, essere sorpresi dal Regno di Dio che viene in molti modi e scoprire — «la messe è molta» — con quante sorelle e fratelli poterci mettere al suo servizio. È una percezione, oltre che una prospettiva, che libera dal lamento e introduce all’evangelii gaudium, quello delle beatitudini. Gesù le pronuncia demolendo confini e separazioni, perché povertà di spirito, mitezza, misericordia, purezza di cuore, fame e sete di giustizia, esposizione di sé per il Regno non coincidono con uno stato di vita, non sono garantiti da un’appartenenza, non appartengono a una sola Chiesa. Dio li vede germogliare ovunque e, semplicemente, ci chiede in Cristo di guardare il mondo con lui, gioendo della possibilità di lavorare insieme, con chiunque ci sta.
Superare un’astratta distinzione fra Chiesa e mondo, liberarsi della mondanità che annacqua il modo d’essere di Gesù, farsi tutti e insieme di nuovo suoi discepoli — Ecclesia audiens — per vedere squarciarsi le nebbie che raffreddano tanto la vita ecclesiale, quanto la convivenza civile.
Forse proprio questo salto di qualità ci chiedono i decenni trascorsi ribadendo il dettato conciliare, senza venirne fino in fondo cambiati. Ci siamo parlati addosso.
Nelle nostre diversità si deve fare più chiara la differenza cristiana: essa non riproduce mai la logica noi-loro, perché è la differenza di Colui che tutti avvicina, senza cancellare nessuno, facendo invece spazio e dando parola e respiro. Se questo è chiaro, l’intera mappa dei ministeri può essere ridisegnata. «Siamo comunità», come scrive il Papa. Lo siamo in luoghi reali, in tempi precisi. È una comunione così profonda, così donata, da renderci per vocazione flessibili, attenti, creativi. Liberi. Come ultimamente — confessiamolo — non siamo stati.
di Sergio Massironi








