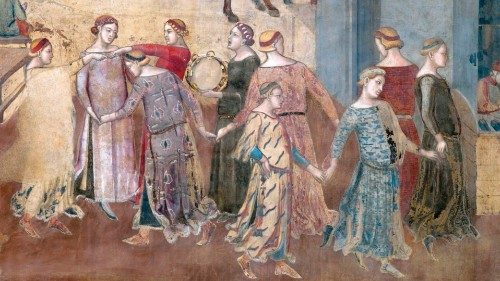
L’avere meno di trent’anni non mi dà il diritto di parlare per un’intera generazione di giovani. Tra coetanei ci sono modi diversi di vivere ogni cosa, compresa la liturgia. C’è però un’esperienza del mondo che è comune alle persone che hanno più o meno la stessa età – eventi storici, riferimenti culturali, meccanismi relazionali. L’attuale generazione di venti-trentenni in Italia si riconosce, per esempio: nell’essere nativa digitale, figlia dell’Europa e del mondo, vittima della solitudine del Covid negli anni della propria formazione, vittima designata della crisi climatica. Può sembrare che queste coordinate c’entrino poco con il rapporto tra giovani e liturgia. Invece la liturgia è il luogo dove il mondo viene portato davanti a Dio; dipende eccome dal legame dei suoi soggetti con l’ambiente che li circonda.
Il desiderio di stare bene
È ingenuo parlare di una disaffezione dei/delle giovani ai riti (che per definizione sono ripetitivi/stabili) senza tenere conto che la nostra è una generazione abituata all’instabilità e disillusa sul futuro. Non vuol dire che ci serva un rito non rituale, senza formule o riferimenti alla speranza, piuttosto un rito rigenerativo, uno spazio familiare (stabile) dove recuperare un po’ di fiducia nella vita. Tanti/e giovani oggi fanno psicoterapia, o meditazione, o in ambito cristiano riscoprono le veglie di adorazione, esprimendo ovunque un desiderio di benessere e pace. Forse cerchiamo solo una liturgia che sia per noi, in cui non siamo braccia da animazione o target pubblicitario. Stella Morra e Marco Ronconi la chiamano «la dimensione terapeutico-compensativa dell’esperienza religiosa» (Incantare le sirene. Chiesa, teologia e cultura in scena, EDB), cioè la garanzia che la liturgia non sia «un impegno in più in agenda» ma un sospiro di sollievo dal disordine quotidiano: riposante e dunque desiderabile. Per chi fa parte stabilmente di una comunità cristiana questo aspetto della liturgia è raro: c’è sempre qualcosa da fare o far fare. Manca la spontaneità, si assegna tutto prima a pochi selezionati, come in uno spettacolo condotto da dietro le quinte. Serve invece non avere paura del silenzio che precede una lettura o una preghiera nell’attesa che qualcuno si proponga. Serve generare, tra le parole rituali, un fuoriposto di voci: aprire finalmente la predicazione a laici e laiche competenti in una pluralità che renda anche il commento alla Parola un luogo di respiro e di riconoscimento della realtà. Riposante è un luogo in cui le persone non chiedono permesso, e anche i/le giovani possono sentirsi adulti/e per dignità battesimale: quella è casa loro.
Salvare la comunità
In ogni comunità la liturgia cambia un po’: dal nord al sud, dalle città ai paesi, il rito è fatto per rendersi familiare a chi lo fa e lo frequenta. Per noi giovani spesso girovaghi, allora, è facile sentirsi estranei. Ci accorgiamo presto che per dimostrare affetto alle nostre comunità dovremmo rinunciare a spostarci. C’è un cortocircuito tra mobilità (di studio o lavorativa) e cura della comunità: o cresciamo professionalmente o cresciamo in una chiesa. Così la liturgia, anziché essere il momento in cui la comunità si raduna, diventa quello in cui si disperde: il fuorisede a Milano, la lavoratrice del weekend, il giovane che si è rifugiato a Taizé, il turista a Roma, sono membri della stessa comunità di provenienza che si ritrovano ospiti anonimi in altrettante comunità. Bisognerebbe dare credito a quest’instabilità, ovvero notare il carisma che c’è nell’essere un cristiano ospite, che è lo stato più comune non solo ai/alle giovani, ma anche ad alcune figure professionali nomadi (non ultima, quella di teologi e teologhe). Un(’)ospite conosce più realtà, perciò è in grado di tessere relazioni e arricchire il rito. Poi ritorna alla sua comunità, quella che l’ha cresciuto/a nella fede, e si ritrova a casa. Ma non è detto che questo ritorno sarà sempre possibile: presto in molte chiese non ci saranno più persone stabili a garantire per noi instabili. Allora serviranno comunità fondate su relazioni e non su luoghi. Noi giovani funzioniamo già così, ci reggiamo su reti flessibili e soluzioni creative: pregare al telefono, o trovarsi a bere un caffè prima o dopo le celebrazioni, per custodire un po’ di familiarità. Due o tre persone amiche, che radunano le loro diverse comunità di provenienza: se siamo ospiti, almeno non siamo ospiti da soli, e nella comunità che ci accoglie portiamo tutte le nostre.
I venti-trentenni di oggi, tra strategie e fatiche, sollecitano oggi tutta la Chiesa al tentativo benedetto di salvare la comunità. Nella liturgia, noi portiamo davanti a Dio un mondo fin troppo individualista ed efficientista, che la liturgia stessa rischia di fomentare. Invece essa dev’essere lo spazio di fraternità e sororità che manca altrove. Uno spazio riposante, spontaneo, dove emerga la complessità e la pluralità delle esperienze: donne, uomini, figlie, studenti, poveri, lavoratrici, nomadi, adulte, giovani.
di Alice Bianchi
Dottoranda in Teologia Fondamentale presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma








