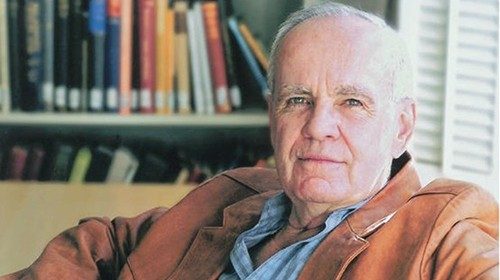
«La realtà è perdita e ogni perdita è definitiva»: è questa la consapevolezza cui giunge il protagonista del suo grande testamento spirituale, Il passeggero. Passeggero come lui, come tutti noi, Cormac McCarthy era pronto per partire, mentre noi dobbiamo fare i conti con la sua, di perdita, avvenuta ieri 13 giugno. Classe 1933 (avrebbe compiuto 90 anni il prossimo 20 luglio) McCarthy è assurto a cult ancora in vita. Scoperto dal grande pubblico solo alla quinta opera, anche grazie all’appassionata divulgazione di critici come Harold Bloom, su questa sponda dell’Atlantico è diventato familiare grazie ai film tratti dai suoi romanzi e al premio Pulitzer nel 2007 per The Road, da molti ritenuto una sorta di Vangelo del Terzo Millennio. Il raro accordo di critica e di pubblico si spiega forse con la capacità di rivitalizzare generi pop — il picaresco, il western, il romanzo di formazione, l’on the road, il noir, la distopia post apocalittica — innervandovi una dirompente tensione metafisica che perfora e dilata la forma-romanzo, come già avveniva negli autori che ha dichiarato essergli più cari: Hermann Melville, Fedor Dostoevskij, William Faulkner, Flannery O’Connor.
All’indomani della sua scomparsa, ripercorrere alcuni dei temi persistenti nell’opera di McCarthy può aiutarci ad avvicinare un universo simbolico all’apparenza molto duro e abbozzare alcune chiavi di lettura. L’incisività della scrittura dell’eremita di El Paso non è stata raggiunta “nonostante” l’orizzonte cupo, truculento e talora grandguignolesco che grava sulla sua opera, ma proprio attraverso di esso, ingaggiando un corpo a corpo radicale con la letteratura quale strumento di conoscenza. Il lettore di McCarthy non è rassicurato da facili risposte, ma riscaldato da braci di speranza accese nel regno della desolazione, e fermamente richiamato alla responsabilità di mantenerle vive. Per limiti di spazio non daremo conto dell’ultima e importante fase del percorso dell’autore — l’opera in due parti, composta da Il passeggero e Stella Maris — autentica epitome letteraria, nonché suo testamento esistenziale, di cui abbiamo peraltro già parlato in queste pagine.
La prova del sangue
L’interrogativo che ha innescato l’opera di McCarthy fin dal suo esordio (Il guardiano del frutteto, 1965) è quello sulla presenza del male nel mondo, interrogativo che è andato via via approfondendosi slittando dal piano socio-psicologico a quello dichiaratamente mitico e biblico (Il buio fuori, 1968). La scelta di raccontare senza compiacimento, tra i tanti possibili volti del male, una galleria di assassini e massacri assolutamente irrazionali va a comporre uno “stato d’inferno” che non è possibile ignorare e con il quale non si può patteggiare.
Il disadattato sociale Lester Ballard, protagonista di Figlio di Dio (1973), è il primo e a suo modo più umano di questi personaggi. In seguito a una serie di incidenti che lo derubano delle sue misere proprietà, Ballard si trasforma nel prototipo del serial-killer, rivestendosi degli abiti e degli scalpi delle proprie vittime, i cui cadaveri vengono occultati «come santi nelle catacombe» nelle grotte in cui si è rifugiato, parodia della comunità che lo ha esiliato. Ballard, che è ancora capace di versare lacrime davanti alla bellezza del mondo e di rispecchiarsi nel volto di un bambino intravisto sull’autobus, si riunirà infine al consorzio umano. In lui coincidono gli opposti abissi dell’umanità: rappresenta l’«avvento futuro di mostri ancora peggiori», ma al tempo stesso è «un figlio di Dio come voi, forse».
I killer dei successivi romanzi sono creature imparagonabilmente più crudeli. Appaiono dal nulla, esseri senza passato né futuro che hanno volutamente rimosso ogni legame con la razza umana, verso la quale si rapportano come spietati cacciatori. In Meridiano di sangue (1985) la guida spirituale di una sanguinaria banda di cacciatori di scalpi — il giudice Holden, quasi una fusione del capitano Achab con la Balena bianca — ci viene descritta attraverso un climax di indizi che sfonda la soglia del diabolico. Anton Chirugh, il «profeta della distruzione» di Non è un paese per vecchi (2005), ammazza le proprie vittime con il pistone ad aria compressa adoperato per il bestiame nei macelli. La glaciale Malkina (Il procuratore, 2013) giustifica lo sterminio alle proprie spalle con una dichiarazione d’amore verso la purezza dei predatori. Le bande di cannibali che popolano il mondo di La strada (2006) non sono che una volgare riproduzione in massa di questi personaggi su scala globale.
Per nessuno di essi si paventa il dubbio che possano essere — o tornare a essere — “figli di Dio”. La loro scelta di campo è definitiva e irredimibile, dunque infernale: agenti di un male ultraterreno, sprezzatori dell’umano, blasfeme epifanie del mysterium iniquitatis nella storia. «L’esistenza di Satana spiega un mucchio di cose che altrimenti non si possono spiegare», osserva un attonito sceriffo in Non è un paese per vecchi. McCarthy ha condiviso la lezione di Flannery O’Connor, per la quale «a garanzia del nostro senso del mistero, occorre un senso del male che veda il diavolo come uno spirito reale, spirito che va costretto a dichiararsi, e non semplicemente come un male indefinito, bensì con una personalità specifica per ogni occasione». Tale esplicazione chiama in gioco la responsabilità, e dunque la libertà, del protagonista (e del lettore), costretto a una inequivoca presa di posizione tra la codarda passività della connivenza o il coraggio disilluso del combattimento. “Disilluso” perché chi accetta lo scontro sa che non ne uscirà indenne. In questo scontro frontale la sola vittoria possibile non è decisa dal “salvare la propria vita”, quanto dalla disposizione a mettere a rischio la propria anima. Pertanto la violenza non è mai fine a se stessa, ma risulta anzi necessaria in quanto strumento insostituibile affinché l’uomo riveli — è ancora Flannery O’Connor — «i tratti insopprimibili della sua personalità: tutto ciò che dovrà portare con sé nell’eternità». A questa visione McCarthy ha aderito integralmente. Per mettere alla prova le cose, ricorda, è necessario farle sanguinare: «le vergini, i tori, gli uomini. E in definitiva Dio stesso» (Cavalli selvaggi).
La strada, il racconto
Inseguiti e inseguitori, fuggiaschi, vagabondi, pionieri o pellegrini, i personaggi di McCarthy non conoscono casa né riposo, metafora dell’esistenza umana incamminata verso l’appuntamento con il destino che le viene incontro per la resa dei conti.
Da Suttree (1969) alla Trilogia della frontiera (1992-1998) fino a La strada (2006) individuiamo alcune significative variazioni di questa immagine. Suttree e La strada, in particolare, possono essere considerate due autobiografie antitetiche. Il più voluminoso tra i romanzi di McCarthy narra con raffinata eleganza i vagabondaggi di Cornelius “Buddy” Suttree, alcolista ex carcerato che, abbandonati moglie e bambino di cui non ricorda neppure il volto, ammazza il tempo in una baracca lungo il fiume tra espedienti, «cameratismo da condannati», sbronze e risse con i compagni della bidonville, una quasi-paternità verso un adolescente sgangherato, occasionali storie di sesso e nostalgie d’amore autentico. La vita di un fuggitivo terrorizzato dalla morte. «Devo andare» è l’imperativo interiore che lo costringe a non restare in nessun luogo, tuffandosi a capofitto in un groviglio di sentieri senza destinazione.
Se Suttree conteneva, per ammissione dell’autore, numerosi episodi di gioventù, potrebbe apparire strano sostenere che ancora più autobiografica sia quella parabola distopica che è La strada. Qui solo, tuttavia, appare ben esibita un’intrusione della vita privata dell’autore nell’opera, cioè la dedica in apertura (unica nell’intera opera dello scrittore) al figlio John Francis. Due anni dopo l’uscita del romanzo, quasi a giustificarsi, McCarthy ha spiegato di considerare John coautore del romanzo, poiché numerosi dialoghi non sono che la trascrizione parola per parola delle conversazioni con il figlio. Il risultato è una prosa essenziale, sorvegliata, persino lapidaria. Protagonisti di La strada sono un uomo e un bambino, barboni ben più cenciosi di Cornelius Suttree, costretti ad aggirarsi in lande ridotte a un inanimato «mare di rifiuti». Due figure che camminano nel nulla, e tuttavia hanno una mèta: il sud, il mare temperato, la speranza di sopravvivere forse a un altro inverno. E se il titolo evoca una tradizione letteraria che va da Jack London a Jack Kerouac, la strada è al tempo stesso un modo di stare al mondo, un percorso etico dal quale non è ammesso deviare se si vuole conservare la propria umanità: non cibarsi delle altre persone, non diminuire le vite altrui per accrescere la propria. “Essere buoni” risulta un punto d’arrivo che non si conquista con le proprie forze, perché nonostante l’uomo sia mantenuto in vita dalla responsabilità verso il figlio, al tempo stesso sarà il bambino — «calice d’oro, buono per contenere un dio» — a prendersi cura dell’uomo, stimolandone gli atteggiamenti atrofizzati da un mondo dominato dal terrore: lo stupore, il ringraziamento, la pietas, la preghiera, la fiducia negli altri, la condivisione.
Tra Suttree e La strada, McCarthy ha scritto i romanzi di formazione della complessa Trilogia della frontiera, grandioso affresco sulla spinta che conduce l’uomo a lasciare i confini noti della propria casa per necessità materiale o per anelito di libertà, nel desiderio di costruire il futuro senza mai guardarsi indietro o nell’illusione di riscattare il passato senza mai guardarsi avanti. La Trilogia sviluppa, tra gli altri temi, una lunga meditazione sul rapporto tra realtà e rappresentazione, concludendosi con una decisa adesione alla letteratura in quanto testimonianza tipologica della vita: «Questa carne non è che un memento, eppure dice il vero. Alla fine, la strada di ciascuno è la strada di tutti» (Oltre il confine).
Anche il vagabondo solitario come «tronco senza radici né rami» mantiene infatti un legame con il resto del genere umano, poiché «tutti gli uomini sono uno e non vi è un’altra storia da raccontare». Depositario di una verità più grande di se stesso, l’uomo può percorrere la propria strada come ignaro testimone del mistero che arde nel fondo delle cose. Ogni storia e ogni dettaglio risultano necessari, pertanto nessun uomo merita disprezzo in quanto tipo dei suoi simili. L’atteggiamento da assumere è precisamente quello contrario. «Questa tua vita non è un ritratto del mondo. È il mondo stesso, e non è fatta di ossa o di sogni o di tempo, ma di devozione», recitano le ultime pagine di Città della pianura. E ancora: «La morte di ogni uomo fa le veci di quella di ogni altro. E poiché la morte non viene per tutti, non c’è altro modo di placarne la paura se non amando l’uomo che fa le nostre veci. Non stiamo ad aspettare che la sua storia venga scritta. È passato di qui molto tempo fa. Quell’uomo che è tutti gli uomini, e che sta sul banco degli imputati al nostro posto, finché non arriva il nostro momento e tocca a noi starci al posto suo. Lo ami, quell’uomo? Onori il cammino che ha intrapreso? Sei pronto ad ascoltare ciò che ti narrerà?».
Il fuoco delle generazioni
Nella notte senza confini che dilaga sulla prateria addormentata, la fiamma di un bivacco perfora la tenebra come stella solitaria in un cielo capovolto. Insieme al viaggio, anche l’immagine del fuoco è tra le più persistenti nella narrativa di McCarthy. Poiché el compartir es la ley del camino, come ricorda uno degli indimenticabili messicani della Trilogia della frontiera, niente meglio del fuoco racchiude in sé la coincidenza tra civiltà e ospitalità, la condivisione come fondamento della comunità umana, pur con le sue mille ambiguità (il fuoco può segnalare la propria presenza al nemico) e contraddizioni (attorno al fuoco ci si può anche uccidere). Ma è pur sempre una fiamma che illumina, riscalda, asciuga, cuoce, raduna gli uomini e allontana le bestie selvatiche. Fuori del suo perimetro di luce vi è il mondo inumano dei predatori e dei messaggeri delle tenebre che vi si aggirano come monadi che non abbisognano di aiuto, ingenerate e incapaci di generare.
I protagonisti hanno invece un forte quanto conflittuale legame con le generazioni precedenti: non solo il padre, ma anche la terza generazione, gli immancabili e autorevoli “vecchi”, quasi padri supplementari, anello di congiunzione con l’aurea epoca degli Avi, custodi di un ordine oggi smarrito. Così lo sceriffo Bell di Non è un paese per vecchi vive uno schiacciante complesso di nostalgia e di colpa nei confronti degli uomini di legge che lo hanno preceduto: «Non sono un uomo del passato, come molti credono. Mi piacerebbe, ma non è così. Sono un uomo del presente». Un presente spietato, nel quale l’ultima parola di speranza è rappresentata dal sogno del nonno che lo precede a cavallo, portando una torcia per accendere un fuoco e attenderlo, nonostante il buio e il freddo. L’immagine del fuoco trasmesso da una generazione all’altra diventa fondamentale in The Road, quasi una keyword identificativa dei “buoni”: portatori del fuoco sono l’uomo e il bambino, portatori del fuoco la famiglia che compare alla fine, tutti accomunati dall’atto di fede nella bontà del generare e dare alla vita. Il fuoco è qualcosa dentro di noi, ma che al tempo stesso si riceve, mantenuto accesso, curato perché sia visibile all’esterno e ravvivato anche negli altri.
È quanto avviene in The Sunset Limited (2006), unico «romanzo in forma drammatica» di McCarthy inchiodato a una stanza (una casa!), priva di peregrinazioni, quasi fosse un punto d’arrivo. Intorno a un tavolo si fronteggiano in una partita a scacchi metafisica tra il Bianco e il Nero, dove in palio c’è il significato della vita. Il Bianco ha deciso di farla finita, il Nero tenta di rinvigorirne il fuoco nascosto, perché nonostante tutto anche nell’uomo di fronte a lui c’è «una luce buona. Una luce vera». In Sunset Limited, per la prima volta, McCarthy non si è appellato al Dio imperscrutabile dei suoi precedenti romanzi, ma a Gesù: «Lui ha detto che si poteva avere la vita eterna. La vita. Averla oggi. Tenerla in mano. E poterla vedere. Emana una luce. Ha anche un certo peso». Un Gesù che, va detto subito, si radica nella sua antropologia tipologica («Non c’è verso che Gesù sia un uomo senza che un uomo sia Gesù») e nella conseguente devozione all’umanità («Bisogna amare i propri fratelli, altrimenti si muore»). Per il Premio Pulitzer — convinto assertore di una giustizia retributiva in quanto solo le decisioni personali, seppure inconsce, hanno la capacità di attuare nel reale i mondi del possibile — la religione è in primo luogo un atto di responsabilità verso i propri fratelli. Una “religione dei vivi” che non deve debilitare la coscienza sostituendosi a essa, ma rafforzarla in preparazione degli inevitabili scontri con le forze disgreganti della comunità.
di Paolo Pegoraro
Il finale de «Non è un paese per vecchi»
«Non è un paese per vecchi» non è il romanzo migliore di McCarthy, ma senz’altro il più famoso, grazie alla trasposizione cinematografica con la quale i fratelli Coen vinsero l’Oscar nel 2007. Qui di seguito l’ultima, memorabile, pagina del romanzo.
Quando uscivi dalla porta del retro di casa, da un lato trovavi un abbeveratoio di pietra in mezzo a quelle erbacce. C’era un tubo zincato che scendeva dal tetto e l’abbeveratoio era quasi sempre pieno, e mi ricordo che una volta mi fermai lì, mi accovacciai, lo guardai e mi misi a pensare. Non so da quanto tempo stava lì. Cento anni. Duecento. Sulla pietra si vedevano le tracce dello scalpello. Era scavato nella pietra dura, lungo quasi due metri, largo suppergiù mezzo e profondo altrettanto. Scavato nella pietra a colpi di scalpello. E mi misi a pensare all’uomo che l’aveva fabbricato. Quel paese non aveva avuto periodi di pace particolarmente lunghi, a quanto ne sapevo. Dopo di allora ho letto un po’ di libri di storia e mi sa che di periodi di pace non ne ha avuto proprio nessuno. Ma quell’uomo si è messo lì con una mazza e uno scalpello e aveva scavato un abbeveratoio di pietra, che sarebbe potuto durare diecimila anni. E perché? In che cosa credeva questo tizio? Di certo non credeva che non sarebbe cambiato nulla. Uno potrebbe pensare anche a questo. Ma, secondo me, non poteva essere così ingenuo. Ci ho riflettuto tanto. Ci riflettei anche dopo essermene andato da lì quando la casa era ridotta a un mucchio di macerie. E ve lo dico, secondo me quell’abbeveratoio è ancora lì. Ci voleva ben altro per spostarlo, ve lo assicuro. E allora penso a quel tizio seduto lì con la mazza e lo scalpello, magari un paio d’ore dopo cena, non lo so. E devo dire che l’unica cosa che mi viene da pensare è che quello aveva una specie di promessa dentro il cuore. E io non ho certo intenzione di mettermi a scavare un abbeveratoio di pietra. Ma mi piacerebbe essere capace di fare quel tipo di promessa. È la cosa che mi piacerebbe fare più di tutte.








