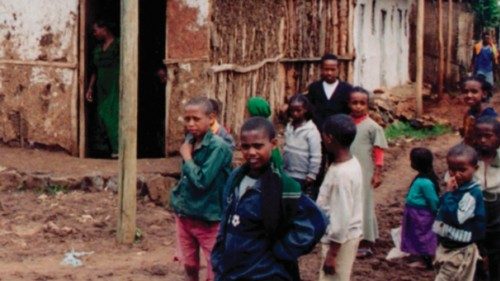
Il bilancio della guerra nel Tigray, nel nord dell’Etiopia, è scioccante. Si parla di mezzo milione di morti, soprattutto civili, e di almeno 2 milioni di persone sfollate, con l’aggravante della fame che nei prossimi mesi accrescerà il numero delle vittime. Sebbene l’attenzione della stampa internazionale sia polarizzata sulla crisi ucraina, la situazione umanitaria del Tigray sta degenerando di giorno in giorno. Lo si evince dai rapporti delle Nazioni Unite e delle agenzie umanitarie, ma soprattutto lo testimoniano autorevoli fonti della società civile.
Questa guerra civile vede contrapposti — dal novembre del 2020 — due distinti schieramenti: da una parte l’esercito regolare etiope, che risponde al primo ministro Abiy Ahmed, a cui si sono unite milizie etniche e truppe della vicina Eritrea, e dall’altra il Fronte di liberazione popolare del Tigray (Tplf) che rivendica l’indipendenza della regione settentrionale del Paese africano.
La crisi ha comunque un impatto che va ben oltre i confini del Tigray, e interessa anche le regioni di Amhara e Afar. Infatti, al momento vi sono, complessivamente, oltre 10 milioni di persone bisognose di assistenza alimentare e il numero degli sfollati è di oltre 3 milioni. A questi vanno aggiunti 65.000 rifugiati che hanno trovato riparo in territorio sudanese. L’Ocha (Ufficio di coordinamento delle attività umanitarie dell’Onu) ha affermato peraltro che l’assenza di scorte medicinali e di carburante ha reso molto difficile rispondere all’emergenza dei feriti e sta portando al totale collasso del sistema sanitario del Tigray.
Da rilevare comunque che nonostante il quadro generale sia poco confortante, fonti indipendenti della società civile ritengono che stia reggendo la tregua umanitaria dichiarata a fine marzo dal governo di Addis Abeba e accettata dalle autorità del Tigray in cambio dell’ingresso di aiuti nella regione dell’Etiopia settentrionale. Di converso si segnala un accesso molto lento dentro il perimetro dell’area di crisi, per non dire a singhiozzo, dei camion carichi di aiuti alimentari e medicine. È dallo scorso dicembre che l’area non si riusciva a raggiungere via terra e le agenzie umanitarie erano state costrette a trasferire gli aiuti via aerea. Considerando che gli aerei a disposizione trasportano quantitativi di merci limitati a costi molto elevati (in alcuni casi 25 volte quelli dei convogli via terra) è evidente che s’impone l’esigenza di una accelerazione dell’intero comparto umanitario prima che sia troppo tardi. C’è da considerare che nel Tigray quasi il 90 per cento dei presidîi sanitari è stato spazzato via dai bombardamenti, per non parlare delle scuole e di altri edifici pubblici distrutti dalla guerra.
A tutto questo, come se non bastasse, si aggiunge la grave siccità che sta colpendo la regione. Secondo il Programma alimentare mondiale (Wfp) almeno 20,4 milioni di persone hanno bisogno di immediata assistenza nell’intero Paese. Per dovere di cronaca è bene rammentare che l’Etiopia ha visto negli ultimi vent’anni ritmi di crescita sostenuti, superando più volte la soglia del 10 per cento annuo nella crescita del Prodotto interno lordo. La traiettoria ascendente del Paese era stata sostenuta anche dall’arrivo alla guida del governo del premier Abiy Ahmed, nel 2018, che aveva ridato forte prestigio al Paese, sia come punto di riferimento della comunità economica regionale, l’Igad (Autorità intergovernativa per lo sviluppo), come anche nell’ambito dell’Unione africana (Ua) la cui sede centrale è proprio ad Addis Abeba.
Naturalmente ora si guarda con grande preoccupazione all’escalation della guerra nel Tigray, che si assomma agli effetti della pandemia da covid-19; una situazione in costante evoluzione, con un pesante impatto sull’economia nazionale, che gli analisti stanno monitorando per i suoi prossimi sviluppi.
Emblematico è il rapporto congiunto pubblicato il 6 aprile scorso da Amnesty International e Human Rights Watch, intitolato «Vi cancelleremo da questa terra», in cui le due organizzazioni impegnate nella difesa dei diritti umani hanno spiegato che i civili tigrini sono stati presi di mira in «una campagna implacabile di pulizia etnica» nella regione nordoccidentale del Tigray. Da rilevare che non è la prima volta che emergono le prove di crimini contro l’umanità nella regione. Si tratta infatti dell’ennesima conferma che in particolare le truppe eritree e le milizie Amhara, con l’acquiescenza e la possibile partecipazione delle forze federali dell’Etiopia, hanno tentato una pulizia etnica contro la popolazione civile del Tigray.
Ciò non toglie che anche le forze tigrine del Tplf, come la stessa Amnesty International ha recentemente documentato, si sono macchiate degli stessi crimini lo scorso autunno (uccisioni arbitrarie e di massa, violenze di gruppo contro le donne, saccheggio degli edifici pubblici e privati…), seppur con numeri inferiori, nelle zone limitrofe dell’Amhara e dell’Afar.
Di fronte a questo scenario segnato da devastazioni d’ogni genere, viene spontaneo domandarsi per quale ragione la grande stampa internazionale non sia in grado di raccontare quanto sta accadendo nel nord dell’Etiopia. In effetti, mentre in Ucraina gli orrori perpetrati nei confronti dei civili a Bocha, Borodyanka e Irpin sono stati ampiamente documentati, in alcuni casi in diretta televisiva, la crisi del Tigray è precipitata nel dimenticatoio. Le ragioni sono almeno due: anzitutto sono state imposte forti restrizioni ai giornalisti per conseguire l’accesso sul campo; dall’altra si percepisce un evidente disinteresse da parte dell’opinione pubblica internazionale nei confronti del conflitto nel Tigray che si assomma al lungo elenco delle guerre dimenticate. Al momento la tregua è ancora fragile ed è dunque evidente che l’unica via di uscita sarà quella di un negoziato che possa portare ad una conclusione delle ostilità. D’altronde, la guerra civile in atto costituisce un pesante e forse insostenibile fardello, anche economico, per un Paese già impegnato nella ricerca di maggiore stabilità e migliore governance.
La crisi profonda che si è aperta, con lo scoppio della guerra in Etiopia, tra la dirigenza del Tigray e le autorità di Addis Abeba, segnala l’urgenza di riforme incisive, rivolte ai necessari adeguamenti nei processi d’integrazione delle varie componenti etniche. Il rischio di un’involuzione “jugoslava”, indotta in Etiopia da un’analoga «combinazione volatile di federalismo etnico, democratizzazione e risentimenti etnici irrisolti dormienti»(F. Bieber, W.Tadesse Goshu, It’s not too late to stop the Ethiopian civil war from becoming a broader ethnic conflict, in Foreign Policy, 18 Nov. 2020), in un Paese chiave per la stabilità del Corno d’Africa e dell’intero continente, non può essere affatto sottovalutata. Se a ciò aggiungiamo le sfide sul fronte esterno, quali ad esempio il contenzioso con l’Egitto e il Sudan sul progetto di riempimento, con le acque del fiume Nilo, dell’invaso della Grande diga del rinascimento etiopico (Gerd), o le preziose azioni diplomatiche di contenimento nei confronti del Sud Sudan e della Somalia, è evidente che la posta in gioco è alta. Stiamo parlando di un Paese, l’Etiopia, che dispone di immense potenzialità le quali hanno attirato l’interesse, in questi anni, di non pochi investitori stranieri.
Tutto questo è però avvenuto molto spesso secondo i canoni del bilateralismo, innescando meccanismi di competizione tra gli attori internazionali. Serve pertanto un approccio più responsabile e inclusivo. Finora i grandi player internazionali hanno assistito inermi al processo di sfaldamento di un paese, l’Etiopia, che ha un’importanza geostrategica da non sottovalutare. Con il risultato che finora non sono stati adottati provvedimenti significativi, finalizzati a conseguire una pacificazione tra le parti in conflitto o quantomeno ad alleviare in modo cospicuo una crisi umanitaria che sta stremando la popolazione civile.
Per dirla con le parole di Papa Francesco, all’insegna del «multilateralismo come espressione di un rinnovato senso di corresponsabilità globale», non escludendo, come spesso accade, i poveri e i più vulnerabili che in Etiopia sono oggi drammaticamente davvero tanti.
di Giulio Albanese








