Una “risorsa”
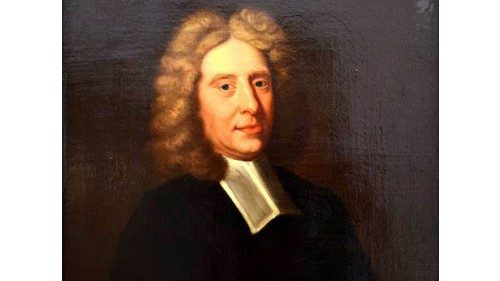
La teologia cristiana ha indubbiamente un debito nei confronti del deismo, perché in definitiva la parte più consistente dell’apologetica moderna — il trattato De Revelatione — è sorta dal confronto serrato con quei deisti che negavano non l’esistenza di Dio, ma la possibilità e il darsi di una rivelazione di Dio nella storia. Ed è in fondo proprio grazie alla provocazione del deismo che lo specifico della fede cristiana si identifica oggi con la parola “rivelazione”. C’è in questo ambito un filone della storia della teologia moderna che rimane tuttora pressoché inesplorato e riguarda in particolare l’apologetica che ha segnato la modernità e che, sorta in tale epoca, è rimasta duratura nella sua forma fino a ridosso del concilio Vaticano
Il punto di partenza di Clarke è al tempo stesso metafisico ed etico. Come scrive Sabetta nell’introduzione, se l’obiettivo è dimostrare la certezza sul piano della possibilità e dell’effettività storica della rivelazione cristiana così che non possano più esserci argomentazioni razionali plausibili per non abbracciarla, allora il punto di partenza è una riflessione ontologica da cui far derivare una teoria della moralità che rappresenti l’argomentazione fondamentale per stabilire la realtà della religione, cioè il bisogno di una rivelazione che vinca la generale corruzione morale del mondo che impedisce agli uomini di vivere secondo ragione
Alla necessità della rivelazione segue l’affermazione che non esiste altra religione al mondo, se non il cristianesimo, che si possa considerare con sufficiente apparenza di ragione la rivelazione della volontà di Dio all’umanità. Gli argomenti addotti da Clarke per mostrare la credibilità ovvero l’origine divina della rivelazione cristiana, oltre ai suoi contenuti, sono quelli classici dell’apologetica ovvero il compimento delle profezie, i miracoli di Gesù (è interessante che in Clarke vi sia un’accezione di miracolo molto articolata e ben diversa dall’improponibile idea tradizionale del miracolo come “sospensione delle leggi naturali”) e infine, soprattutto per noi che viviamo distanti dai fatti del Cristo, la testimonianza degli apostoli e la certezza della trasmissione autentica fino a noi di questa testimonianza.
Lorizio nella sua postfazione si ricollega all’attualità rilevando come Clarke richiami la necessità per la teologia di ancorarsi sempre alla provocazioni del tempo e dei contesti, come fece lui appunto con il deismo. In secondo luogo il teologo inglese ci mostra come l’istanza deista e illuminista sopravviva anche oggi in quelle forme che ritengono i contenuti della fede cristiana riassorbiti dal pensiero e tali da poterli affermare senza passare per la fede. E ci ricorda che l’“abbracciabilità” del cristianesimo dipende molto dalla sua capacità di essere una proposta capace di rendere gli uomini più umani; in questo oggi incontriamo una grande sfida di fronte, come rammenta C. Theobald, alla «difficoltà della tradizione cristiana a rendere credibile la sua visione globale del mondo in società che sembrano volgersi di nuovo verso modi di vita pagani e sapienze che esistevano in Occidente prima che questo divenisse cristiano e che continuano a esistere nel resto del mondo» (Urgenze pastorali, pagina 63).
di








