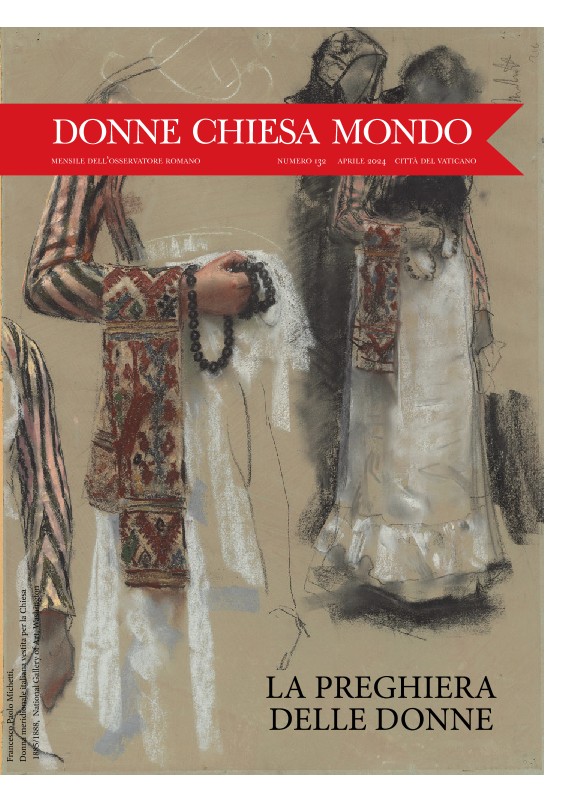Sono le donne il seme di speranza per la drammatica situazione dei rifugiati rohingya che, fuggiti dal Myanmar, stazionano in Bangladesh. Anche se in passato vittime di ingiustizie, violenze e abusi, sono loro le principali partner delle organizzazioni non governative e fortemente impegnate ad animare programmi di assistenza e formazione, prezioso ausilio per gli operatori umanitari. «Le donne svolgono un ruolo chiave nell’incoraggiare la leadership tra di esse e nel portare avanti servizi alla comunità che, grazie a loro, sono rimasti inalterati durante la pandemia», spiega il gesuita Jerry Gomez, impegnato con il Jesuit Refugee Service (Jrs) a Cox’s Bazar, località bangladese a ridosso del confine birmano dove sono assiepati oltre 1,3 milioni di profughi, suddivisi in trenta campi allestiti dal governo di Dacca.
In una cornice di emergenza prolungata, che dura da circa un decennio, enti e gruppi cattolici in Bangladesh hanno attivato una rete di aiuto che vede capofila Caritas Bangladesh, Jesuit Refugee Service e Catholic Relief Service, quest’ultima con sede negli Stati Uniti. In un piano strategico di assistenza umanitaria e sociale, in corso nel 2021, l’impegno principale è aiutare lo sviluppo dei bambini, offrire consulenza e istruzione agli adolescenti, assistere le donne e le madri. Le organizzazioni cattoliche bangladesi e internazionali, presenti e attive nei campi profughi rohingya dal 2017, oltre a fornire aiuti alimentari e sanitari, si occupano anche di programmi di istruzione e formazione professionale. In particolare i volontari gesuiti religiosi e laici del Jrs, che ha celebrato il suo quarantesimo anniversario di fondazione nel novembre scorso, curano programmi di aiuto diretti soprattutto a bambini, adolescenti e giovani. «Sono loro, le generazioni nate e cresciute nei campi profughi, che possono e devono ritrovare la speranza per un futuro di prosperità e benessere. Lavoriamo perché non venga loro negato anche il futuro», spiega padre Gomez. L’esperienza di una donna rohingya di nome Hosneara, divenuta formatrice professionale per laboratori di sartoria e impegnata a sua volta a istruire altre giovani donne, è paradigmatica, riferisce il religioso: mostra che piccoli gesti e iniziative, necessari per tenere vivo il senso della vita in una comunità altrimenti disperata, possono contribuire a ricostituire il futuro di un popolo.
Quella dei rifugiati rohingya è una “ferita infetta” che ancora sanguina e produce effetti negativi nella società, nei rapporti tra popoli e nazioni nell’Asia del sud. La vita e la presenza di oltre 1,3 milioni di profughi di questa etnia in Bangladesh da anni occupa le cronache internazionali senza trovare soluzioni adeguate. Il popolo dei rohingya, una delle più importanti comunità musulmane del Myanmar, non trova cittadinanza, e pace. Privati dei diritti civili in base a una legge sulla nazionalità approvata dal regime militare birmano nel 1982, e confinati nello Stato birmano di Rakhine, sono apolidi, senza libertà di movimento e altri diritti fondamentali. Per loro Papa Francesco, nel suo viaggio in Myanmar del 2017, ebbe parole di profonda compassione: «Chiedo perdono ai Rohingya, oggi Dio si chiama anche così» mentre, proprio in quell’anno, si registrava il grande esodo di oltre 850 mila Rohingya verso il Bangladesh, dove arrivarono a ondate, l’ultima nell’estate del 2017. Dal dicembre dello scorso anno il governo di Dacca ha iniziato a trasferire una parte dei profughi sull’isola di Bhashan Char (sono già circa ventimila), per alleggerire la pressione sui campi a Cox’s Bazar. Nelle scorse settimane, durante la visita di una delegazione delle Nazioni Unite, migliaia di rifugiati dell’etnia si sono ribellati per denunciare le loro condizioni di vita a Bhashan Char, isola martoriata dai cicloni al largo delle coste del Bangladesh, definita dalla ong “Human Right Watch” «una prigione a cielo aperto».
Quanto al possibile rimpatrio verso il Myanmar, non è mai iniziato, se si esclude qualche famiglia che tenta il ritorno clandestinamente, mentre il colpo di stato del 1° febbraio in Myanmar, con le seguenti, diffuse proteste popolari, ha ulteriormente allontanato la prospettiva del rientro. Oggi i rohingya subiscono anche lo sfruttamento di una mafia di trafficanti di esseri umani, che promettono la fine dell’agonia per raggiungere la Malaysia o altri “porti sicuri” e che invece si tramuta spesso in una vita da schiavi.
di