Le ultime parole
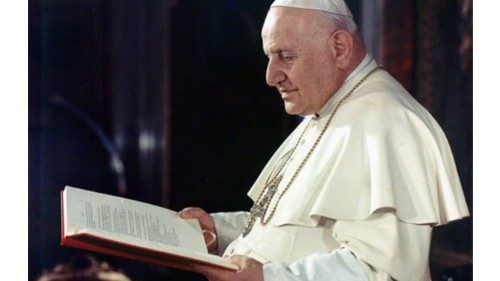
Il 3 giugno 1963 moriva Papa Giovanni XXIII. Il ricordo di Angelo Giuseppe Roncalli si unisce oggi a quello di dom Ghislain Lafont — il monaco e teologo benedettino morto lo scorso 11 maggio a 93 anni — che nel 2013 fu invitato a Sotto il Monte per celebrare il cinquantesimo anniversario della morte del Pontefice. Riproponiamo di seguito la meditazione che Lafont tenne in quell’occasione e che è stata pubblicata quasi per intero sul numero 3/2013 di «Munera», la rivista europea di cultura edita da Cittadella.
Non posso nascondere che il fatto di essere tra di voi, qui a Sotto il Monte, per celebrare il cinquantesimo anniversario della morte di Papa Roncalli, mi commuove profondamente. Viene alla mia memoria la prima volta che lo vidi: era il 22 di luglio 1946: ero diciottenne, novizio nel monastero francese Sainte Marie de la Pierre qui Vire. Lui aveva presieduto a Vézelay, un santuario non lontano da noi, un gran pellegrinaggio di penitenza, di riconciliazione e di speranza dopo la seconda guerra mondiale. Poi era venuto a pernottare nell’abbazia; la sera, ci aveva intrattenuti nella sala capitolare; occupava la sede dell’abate, alla quale noi novizi eravamo vicinissimi.
I miei ricordi sono vivissimi: di questa serata, anche della messa che celebrò l’indomani in chiesa, in una maniera direi “bergamasca” alla quale non eravamo abituati! Nessuno di noi comunque immaginava che questo nunzio, piccolo, tondo, loquace, senza pretesa, semplice, sarebbe stato il successore dell’immenso Pio
Eccomi allora di fronte a voi, sacerdoti bergamaschi, ai quali lui teneva e tiene ancora come alla pupilla dei suoi occhi! Nel 1927, ad esempio, ricordava «la buona tradizione del clero bergamasco, tradizione di disinteresse e di sacrificio, di lavoro e di fedeltà, non solo per conservare, ma per accrescere le energie sante di un popolo robusto, e fiero della fede dei suoi padri» (Mario Benigni - Goffredo Zanchi, Giovanni
Essendo oggi più anziano di quanto non fu Giovanni
La nostra meditazione di oggi si fermerà sulla morte stessa di Giovanni
La morte del Papa
Ritorniamo insieme al 3 giugno 1963. Alla fine del mese di maggio di quell’anno mi trovavo in un ospedale nei dintorni di Parigi, dove l’abate mi aveva inviato per sostituire per qualche giorno il cappellano, anche lui benedettino, assente per non so quale ragione. Erano gli ultimi giorni di vita di Papa Giovanni. Rimasi colpito dal clima del tutto eccezionale che si respirava in ospedale: nelle camere dei pazienti, negli uffici dei medici, degli infermieri e del personale di servizio, i transistor (una delle innovazioni tecnologiche del momento!) erano accesi per raccogliere le ultime notizie del Papa e per non perdere il contatto con lui durante gli ultimi momenti della sua vita. Il tempo e lo spazio sembravano come sospesi, concentrati su quella stanza del Vaticano nella quale il Papa stava morendo. Si capiva che il doloroso evento, atteso e ora vissuto, era qualcosa di personale, che riguardava ciascuno: donna o uomo, credente o indifferente.
Di quel giorno, frère Roger, il fondatore di Taizé, ha scritto: «Il 3 giugno 1963, venni a sapere della morte di Giovanni
L’ultima conversazione con Cristo
Mentre tutto il mondo si volgeva in questo modo verso di lui, che cosa faceva il Papa morente nella sua stanza, che ci permetta di comprendere il silenzio, l’emozione, l’attesa che — da tempo — l’avvolgevano? Il Papa guardava al Crocifisso: «Egli mi guarda ed io gli parlo. Nelle lunghe e frequenti conversazioni della notte, il pensiero della redenzione del mondo mi è apparso più urgente che mai. Et alias oves habeo, quae non sunt ex hoc ovili - “ho altre pecore che non sono di questo ovile”. Quelle braccia dicono che lui è morto per tutti, per tutti: nessuno è respinto dal suo amore, dal suo perdono. Ma è particolarmente l’unum sint che il Cristo ha affidato come testamento alla Chiesa sua» (Benigni-Zanchi, lop. cit., p. 429). Durante le sue ultime ore, Giovanni
Gesù, morto per tutti, per tutti
Al momento della sua morte, quale parola gli esce dunque dalla gola? Quale parola in occasione della sua ultima conversazione con Cristo? L’abbiamo appena letto: un’ultima e profondissima intelligenza della Redenzione, ovvero del desiderio che abita il cuore di quel Cristo crocifisso che egli contempla dal suo letto; una volta di più è dato ad Angelo Roncalli di «comprendere con tutti i santi quale sia l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità, e di conoscere l’amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza (Ef 3)»: Gesù uomo per tutti, per tutti, per l’umanità intera da Lui creata: ut sint unum, ut sint unum. Giovanni
Il Vangelo: cominciamo a comprenderlo meglio
Il Papa traccia, con queste parole, una nuova immagine di Chiesa. L’aveva descritta qualche momento prima: «Ora più che mai, certo più che nei secoli passati, siamo intesi a servire l’uomo in quanto tale e non solo i cattolici; a difendere anzitutto e dovunque il diritto della persona umana e non solo quelli della Chiesa cattolica». Dopo un accenno al discorso d’apertura del concilio Gaudet Mater Ecclesia, aggiunge quindi: «Non è il Vangelo che cambia, siamo noi che cominciamo a comprenderlo meglio» (Benigni-Zanchi, op. cit., p. 428).
Dobbiamo meditare in profondità su questa affermazione. Scrivendo queste pagine, mi sono chiesto cosa essa significhi e mi è venuto in mente il giovane chierico Roncalli, il giovane prete tanto radicato nella tradizione tridentina — da san Carlo Borromeo a Papa Leone
Non solo la Chiesa cattolica, ma l’uomo in quanto tale
In che cosa consiste questo “novum”? Nel fatto che il Vangelo non è solo per la Chiesa, ma per gli uomini, per tutti gli uomini. Di conseguenza la Chiesa è essenzialmente profetica in un doppio senso: in quanto rende testimonianza non a se stessa ma a Gesù Cristo, e in quanto modella la propria parola su Gesù in modo tale che gli uomini possano riceverla. Forse sta proprio qui il vero senso del famoso aggiornamento: capire, mediante lo Spirito, la corrispondenza nascosta fra l’Evangelo immutabile di Cristo e l’attesa — anch’essa nascosta — dell’uomo di oggi. D’altra parte, la Chiesa è profetica anche perché cerca di individuare ovunque — in ogni uomo e in ogni gruppo di uomini — il cammino nascosto del Vangelo, per riconoscerlo e per confermarlo: il che richiede continuamente una conversione, alla Chiesa e agli uomini. In questo senso, un certo decentramento della Chiesa da se stessa è una condizione fondamentale dell’annuncio del Vangelo. Possiamo cogliere più chiaramente questo messaggio nel discorso inaugurale del concilio, laddove il Papa parla dell’unità non solo voluta, ma bramata da Cristo stesso: unità per la quale il Signore ha sacrificato tutto, anche il successo immediato della sua missione divina. Sono parole spesso citate: «Unità dei cattolici tra loro, solida ed esemplare; unità dei cristiani appartenenti alle differenti confessioni, di coloro che credono in Cristo, ortodossi, protestanti ecc. Unità di coloro che appartengono alle differenti famiglie religiose non cristiane, che rappresentano la parte più importante del genere umano, esse pure riscattate dal sangue di Cristo, ma che non hanno ancora partecipato alla grazia e alla Chiesa di Gesù, il Redentore di tutti» (
Ora, una tale visione era profondamente radicata nel cuore del Papa ed essa sola consente di comprendere appieno il perché egli ripetesse così frequentemente le parole ut unum sint, ut unum sint. Lo testimonia anche frère Roger nelle pagine del suo ultimo saggio su Giovanni
Se volessi fare un commento dell’immagine dei cerchi concentrici, direi che, sul letto di morte, il problema del Papa non era di precisare se la Chiesa Cattolica sia il Corpo di Cristo o se il Corpo di Cristo subsistit in Ecclesiam catholicam. Non si tratta di questioni oziose, ma sono — per così dire — questioni preliminari. Se ci si sofferma troppo su simili problemi d’identità, la Chiesa si dissecca e, in essa, il Vangelo. Nella rete invece di tanti cerchi concentrici viventi, la Chiesa cattolica funge da centro aperto che promuove i vari cerchi: non da se stessa però, ma grazie alla potenza dello Spirito, il quale diffonde il Vangelo. La Chiesa si rallegra allora di essere al centro, ma dimentica subito il privilegio ricevuto: vive e celebra il Vangelo, l’annuncia, ma anche lo scopre, nella misura in cui esso sempre la precede.
L’uomo innocente
«Qual era il segreto di Giovanni
Soffermiamoci un poco su questa parola: innocenza. Dopo la morte di frère Roger, uno dei suoi primi compagni a Taizé mi diceva: «Frère Roger era un innocente». Forse solo un innocente può riconoscere un altro innocente. La parola “innocente” è negativa: indica una persona che non nuoce perché — in un certo senso — ignora il male, che gli è come estraneo. Bernanos, nel suo Diario di un curato di campagna, parla della Madonna in questo senso: «Era l’innocente [...]. Lo sguardo della Madonna è l’unico sguardo infantile, l’unico vero sguardo di bambino che si sia mai alzato sopra la nostra vergogna e miseria. Sì, ragazzo, per pregarla bene si deve sentire su di sé questo sguardo di tenera compassione, di dolorosa sorpresa, di non si sa quale sentimento inconcepibile, inesprimibile, che la fa più giovane del peccato, più giovane della stirpe da cui è nata e, anche se è madre per grazia, madre delle grazie, ella però è la “più piccola” del genere umano». In un certo senso si potrebbe dire che chiunque si avvicini a Lei si stia come purificando, e che la Vergine, guardandolo, lo purifichi. Allo stesso modo, secondo la testimonianza di frère Roger, Giovanni
«Oboedientia et pax»
«Motto del mio stemma le parole Oboedientia et pax, che il padre Cesare Baronio pronunciava tutti i giorni baciando in San Pietro il piede dell’Apostolo. Queste parole sono un po’ la mia storia e la mia vita. Oh, siano esse la glorificazione del mio povero nome nei secoli» (Benigni-Zanchi, op. cit.p. 174).
Non si capirebbe niente di Angelo Roncalli se non si facesse attenzione al suo motto episcopale. Roncalli veniva da una cultura profondamente gerarchica: egli, povero ragazzo contadino, si era trovato nel gradino più basso della scala: al di sopra c’erano i signori, i proprietari della terra; per quanto riguarda la religione, c’era il parroco, poi il monsignor vescovo e così via fino al vertice. C’era il re, ma era un usurpatore dello Stato Pontificio e dunque fuori causa; al di sopra di tutto stava il Papa, che era — al contempo — “santo prigioniero” nella Città del Vaticano (come si diceva all’epoca), e Vicario di Cristo, e dunque oggetto della venerazione di tutti i cattolici del mondo. L’obbedienza era normale all’interno di una tale struttura mentale, rispetto alla quale baciare il piede dell’Apostolo era un gesto del tutto conseguente. (Per inciso: sarà un segno dei tempi, ma nelle mie numerose visite alla basilica di San Pietro a Roma, non ho mai visto nessuno farlo...)
Al di là di tale mentalità gerarchica, che può certamente in parte spiegare l’obbedienza, vi è però un atteggiamento fondamentale, che è valido in qualsiasi tipo di cultura. Si tratta dell’atteggiamento che l’etimologia del termine obbedire suggerisce: in latino ob-audire significa infatti ascoltare, sentire in profondità. Ovvero cercare la volontà del Signore, non la propria; percorrere i cammini che ci sono proposti, non i nostri. Questo spossessamento radicale, che caratterizza in pieno l’anima di Cristo, Roncalli l’ha sempre cercato e messo in pratica, fin dagli inizi della sua vita.
Vorrei citare un testo molto esplicito, tratto da una lettera che scrive durante il tempo della delegazione apostolica a Sofia: «Reputo anche caratteristico per veri servitori del Signore il sentirsi chiamati a fare una cosa e invece il doverne fare un’altra. È un po’ ciò che accade [a me]. Non avrei potuto fare il buon canonico del Duomo [di Bergamo]; aiutare del mio meglio i giovani chierici del seminario, un po’ di scuola di religione, esercitare un po’ di pazienza con umili anime che si accontentano di poco? Tale avrebbe potuto essere la mia vita. Invece ecco che mi tocca fare. Ho una dignità immeritatissima e una potestà di ordine che non posso esercitare neanche come fa il semplice sacerdote; rarissime volte l’occasione di un discorsetto spirituale, mai confessare, tutto il giorno occupato sulla macchina da scrivere o in conversazioni fastidiose, fra molte difficoltà e punture, in mezzo a gente che pur appartiene a Gesù Cristo e per diritto alla Chiesa cattolica, ma non ha per nulla il sensus Christi; meno ancora il sensus ecclesiae; sempre in contatto coi cosiddetti “grandi” del mondo, ma desolato per la piccolezza del loro spirito quanto a ciò che è sopranaturale, preparando con cura avvenimenti da cui dovrebbe derivare tanto bene, e poi spettatore della fralezza delle speranze umane» (Ivi, pp. 193-194). Era innocente Roncalli, ma per niente ingenuo. Il tessuto della sua vita quotidiana era fatto, come del resto ogni vita umana, di seccature e — come egli stesso scrive — di “punture”. Egli non ha però mai cercato di tracciare un percorso di vita più in linea col suo temperamento, col suo piccolo mondo personale. Si manteneva fedele alle risposte maturate nelle sue conversazioni con Gesù Cristo: risposte che l’avevano destinato a mondi lontani. Quante volte avrebbe in seguito riconosciuto a qual punto fosse debitore delle esperienze fatte in mondi tanto diversi dal suo. Se avesse rifiutato di partire, se avesse scelto di vivere a Bergamo nell’attesa di ciò che non sarebbe mai capitato (o forse sì, ma con molto ritardo), mai avremmo avuto un concilio basato sulla sua consapevolezza che il Signore ha dato la vita per tutti gli uomini, al di là delle loro diversità culturali, sociali e religiose.
Un profeta dell’“instinctus interior caritatis”
Mi limito, in conclusione, a esprimere una mia convinzione personale: la morte di Giovanni
All’inizio del suo pontificato, Benedetto
Dio è dunque amore. Non si deve però dimenticare, a questo punto, che l’Amore è di per sé sempre “ferito”. Amare significa infatti aprire il proprio cuore affinché ne esca qualcosa per gli altri, e affinché si possa accogliere in sé il dono che cerca di entrare in noi. Se questo è vero, nell’essere stesso di Dio c’è dunque una ferita originale. L’apertura del fianco di Gesù sulla croce, affinché ne escano l’acqua della vita e il sangue dell’amore, è dunque una rivelazione dell’apertura del Cuore divino stesso (all’interno della Trinità immanente). Sarebbe quasi impossibile che il Cuore di Cristo non fosse stato aperto, che avesse custodito dentro di sé il suo sangue. Mistero di un Dio infinito che non esiste se non dando la vita a un Altro — un Altro che non esiste se non nel rendimento di grazie verso Colui che dà la vita e l’essere, di uno Spirito che è essenzialmente comunione, comunicazione, relazione. Dio è dunque una ferita primordiale? Questa è, in ogni caso, l’immagine di Dio fatta propria dal Vaticano
Ci vuole tempo per accogliere un messaggio profetico: esso è sempre inaudito e dunque difficile da integrare nelle categorie — teoriche e pratiche — precedenti; è ancora più difficile quando si tratta di integrare la dottrina precedente nella nuova prospettiva. Ci vuole tempo per capire che la tradizione non è calpestata, ma trasfigurata dalla profezia: cambia certo figura, ma proprio mediante tale cambiamento essa raggiunge la sua verità. Così è stato per i profeti del Primo Testamento, per Gesù — con la sua predicazione del Regno di Dio egli non distrusse nulla, ma portò tutto a compimento — e per Paolo, il quale non volle conoscere nulla se non Gesù e questi crocefisso, pur non volendo, con ciò, mancare di fedeltà alla sua vocazione ebraica... Così, infine, è per Giovanni
Ma, in ogni caso, credo che, ripetendo fedelmente le ultime parole di Giovanni
di








