Specchio che riflette
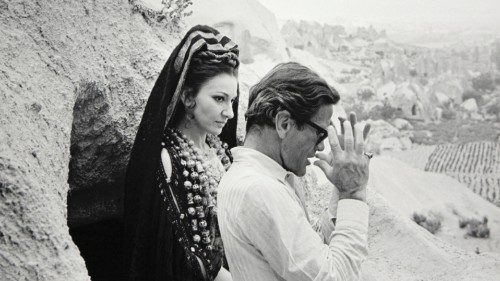
Nell’autunno del 1821 un giovane intellettuale inglese residente a Pisa compose un dramma lirico, Hellas, in cui riversò la sua ardente passione filellenica con lo sguardo rivolto alla guerra d’indipendenza combattuta dal popolo greco per liberarsi dal giogo ottomano (obiettivo che sarebbe stato raggiunto solo nel 1832). Quel grande poeta e drammaturgo romantico, autoesiliatosi in Italia, si chiamava Percy Bisshe Shelley (1792-1822).
Nella prefazione alla sua opera teatrale, grondante di ammirazione per il faro di civiltà della Grecia classica, per un retaggio di democrazia e cultura da risuscitare nel panorama di un’Europa oppressa da regimi dispotici ma anche gravida di germi insurrezionali, Shelley inserì un proclama di lapidaria solennità: We are all Greeks, «Noi siamo tutti greci». E così giustificava la sua affermazione: «Le nostre leggi, la nostra letteratura, la nostra religione, le nostre arti hanno le loro radici in Grecia. Senza la Grecia, Roma, la maestra, la conquistatrice o la metropoli dei nostri antenati, non avrebbe con le sue armi diffuso alcuna luce».
Ancora oggi, duecento anni dopo l’asseverativo enunciato di Shelley, i risultati conseguiti dagli studi otto-novecenteschi grazie allo sviluppo delle scienze dell’antichità attestano che noi abitanti del
Come sottolineò un celebre saggio di Benedetto Croce scritto nel 1942, in piena tempesta bellica, per rivendicare la centralità del Cristianesimo, protagonista della «più grande rivoluzione che l’umanità abbia mai compiuta», e spiegare da una prospettiva storico-filosofica «perché non possiamo non dirci cristiani». Shelley e Croce, dunque, apostoli laici delle due tradizioni simbiotiche, greco-romana ed ebraico-cristiana, dei due fondamentali archetipi su cui si regge, consapevole o inconsapevole, l’Occidente contemporaneo in ogni aspetto della sua civiltà.
Richiamandosi esplicitamente al “motto” shelleyano e attingendo alla sua vasta esperienza di grecista alla Statale di Milano, Giuseppe Zanetto aveva intitolato Siamo tutti greci (Milano, Feltrinelli, 2018) un’affabile apologia dell’approccio alla letteratura greca in quanto fonte inesauribile e sorprendentemente attuale di pensieri, sentimenti, passioni, comportamenti, linguaggi radicati nel nostro vissuto individuale e sociale: «Siamo greci quando parliamo, e pensiamo quello che diciamo (...) Siamo greci quando non ci adagiamo su formule già pronte, ma elaboriamo qualcosa di nuovo. Siamo greci ogni volta che costruiamo il futuro» (proprio in questo senso Giuseppe Pontiggia aveva contrassegnato un suo «viaggio nei classici», edito da Mondadori nel 1998, con un titolo paradossale: I contemporanei del futuro).
Il concetto di una grecità dello spirito alla quale tutti apparteniamo trova vitaminico alimento in un nuovo prodotto di “saggistica narrata” che Zanetto ha affidato al medesimo editore: Miti di ieri storie di oggi (Milano, Feltrinelli, 2020, pagine 144, euro 13). Sette capitoli, sette “lezioni” tendenti a dimostrare che l’attualità della tragedia ellenica, al di là del fascino insito nel codice del teatro, consiste nel ricorso al linguaggio del mito, autentica «bibbia del popolo greco»; «linguaggio forte e semplificato», d’ineguagliabile idoneità ad «affrontare i temi del vivere, i temi universali che sono presenti in tutte le culture ed epoche» come perenni paradigmi antropologici.
Ecco il prodigio che si rinnova 2500 anni dopo la fioritura drammaturgica del
Ancora una volta Zanetto adotta un’impostazione didattica del tutto peculiare. Non calata dall’alto della sua cattedra universitaria, ma proposta con lucida passione “orizzontale”, con accattivante confidenzialità. Si ha quasi l’impressione di vedere gli attori intenti a recitare indossando le loro maschere “espressionistiche”, di assistere alla rappresentazione di scene dei drammi che vengono di volta in volta icasticamente evocati, agilmente riassunti con l’ausilio di citazioni di brani tradotti ad hoc e sobriamente commentati da un docente seduto accanto al lettore-spettatore sulla stessa gradinata di un teatro antico: magari quello, il più greco di tutti, che sorge a Epidauro, con la sua cavea adiacente al santuario di Asclepio, dio della medicina, immersa in una favolosa cornice paesaggistica e dotata di un’acustica strabiliante.
È una prosa nitida e perspicua, espressione di uno stile deliberatamente antiaccademico, quella che Zanetto impiega nel ripercorrere le trame di una ventina di tragedie, nello scioglierne i principali nodi problematici, nel valorizzarne gli spunti tematici più ricchi di significato poetico ed esistenziale, più stimolanti per la nostra riflessione. Ma c’è anche dell’altro: il meccanismo sotteso a questa riattualizzazione del teatro ateniese consiste in un sistematico gioco di specchi tra passato e presente. Numerose versioni tragiche di racconti mitici rivivono, infatti, riflesse sia nelle loro rielaborazioni moderne sia, in modo ancor più sorprendente, nelle vicende reali del nostro tempo.
Tra i termini letterari di paragone rispetto alla crisi pandemica tuttora imperversante sono state richiamate le descrizioni delle storiche pestilenze di Atene (Tucidide, La guerra del Peloponneso), di Firenze (Boccaccio, Decameron) e di Milano (Manzoni, I promessi sposi), oltre all’immaginaria Peste di Orano narrata da Camus. Un micidiale contagio si sta diffondendo anche a Tebe all’inizio di quella che Aristotele considerava «la tragedia perfetta», l’Edipo re di Sofocle. Sollecitato dalla popolazione sgomenta, il sovrano, appunto Edipo, manda a interrogare l’oracolo di Delfi, «l’equivalente — osserva Zanetto — delle commissioni di esperti consultate dai governanti di oggi». Il responso di Apollo profetizza la liberazione della città dal terribile morbo, frutto di contaminazione, solo se ne verrà espulso l’assassino del precedente monarca, Laio. Di qui l’avvio di un’indagine che condurrà Edipo prima alla sconvolgente scoperta di aver inconsapevolmente ucciso il padre e sposato la madre, poi all’autoaccecamento e all’esilio. Similmente, l’odierno mondo globalizzato attende con ansia che, per effetto delle vaccinazioni di massa, il virus omicida venga espulso dal pianeta.
La vicenda mitica drammatizzata da Eschilo nelle Supplici, l’approdo ad Argo delle cinquanta figlie di Danao — arrivate con il padre dall’Egitto in cerca di asilo, per sfuggire alle nozze coatte con i cinquanta cugini che le inseguono — solleva un ineludibile confronto con tre argomenti di scottante attualità: la violenza sulle donne (qui sventata, ma inferta alla cognata Filomela dal re di Tracia Tereo nell’omonima, frammentaria tragedia di Sofocle), il fenomeno migratorio e il dilemma della scelta tra accoglienza e respingimento. Queste analogie con la drammatica realtà del Mediterraneo attraversato dai barconi dei migranti hanno suggerito al regista Gabriele Vacis la messa in scena, davanti al mare tra la Sicilia e la Libia, di un emozionante adattamento del modello eschileo, Supplici a Portopalo.
Una nuova, libera interpretazione delle Supplici è stata poi curata da Moni Ovadia per il festival di Siracusa del 2015, mentre una riproposta dei Sette a Tebe, sempre di Eschilo, ha avuto come scenario il cimitero militare tedesco del Passo della Futa. In altri casi, ad attingere al repertorio tragico sono stati i cineasti: Cacoyannis si è ispirato nel 1977 all’Ifigenia in Aulide di Euripide, Lars von Trier nel 1988 (preceduto nel 1969 da Pasolini) alla Medea pure di Euripide.
Il messaggio transtemporale che ci consegnano le tre versioni del Filottete (di Eschilo ed Euripide in gran parte perdute, integra invece quella di Sofocle) sembra infine riverberarsi direttamente sulla cronaca travagliata di questo ancora indecifrabile 2021: nei momenti più critici bisogna saper superare le divisioni e affrontare le difficoltà con spirito unitario. «Le parole d’ordine sono: dimenticare i rancori e le inimicizie, aiutarsi reciprocamente in vista del bene comune, affidarsi alla divinità». Ed è qui che risuona una nota inequivocabilmente in armonia con lo spartito della Fratelli tutti di Papa Francesco. Viene allora da chiedersi, chiudendo il libro di Zanetto: sperare che l’Enciclica «sulla fraternità e l’amicizia sociale» possa gettare un seme di riconciliazione e pacificazione anche sul campo di battaglia — fino a ieri così turbolento — della politica italiana, è davvero solo un’ingenua utopia?
di








