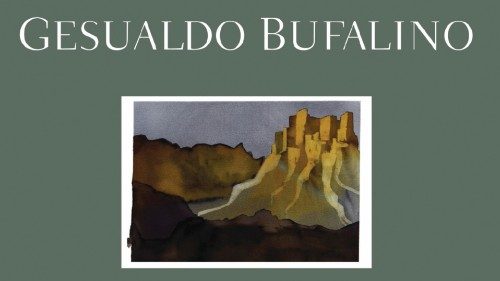
«Avrei serbato i miei coturni, e le tirate al proscenio dell’eroe che avevo presunto di essere, in un angolo della memoria. Per questo forse mi era stato concesso l’esonero; per questo io solo mi ero salvato, e nessun altro dalla falcidia: per rendere testimonianza, se non delazione, d’una retorica e d’una pietà». Parole che Gesualdo Bufalino fa recitare all’io narrante nell’ultima pagina di Diceria dell’untore, romanzo che narra la convivenza in un sanatorio della Conca d’oro, nel 1946, di alcuni giovani reduci di guerra, presumibilmente inguaribili, in lucida tenzone con se stessi e con la morte. Di sorpresa il protagonista guarisce e, come dice l'autore, «rientrando nella vita di tutti i giorni vi porta un’educazione alla catastrofe di cui probabilmente non saprà servirsi, ma anche la ricchezza di un noviziato indimenticabile nel reame delle ombre».
La memoria di quel reame, quell’impalpabile crìnis che separa la vita dalla morte, dove tutto accade come in sogno e pare «di volare» viene raccontata in modo magistrale, anche ai più piccoli, ne La Favola del Castello senza Tempo, edizione Bompiani, con le pregevoli illustrazioni di Lucia Scuderi e l’esauriente introduzione di Nadia Terranova (Firenze, 2020, pagine 64, euro 12).
Come sempre nelle fiabe s’inizia con «una volta» e con un piccolo protagonista, Dino, sperso in un «bosco nero». C’è entrato al seguito di una farfalla dalle ali gialle e dal dorso bruno sul quale una macchia bianca con due puntini, ricorda la forma di un teschio. È Atropo, l’Acherontia Atropos, «messaggiera del Buio e del Mistero» nelle rime di Gozzano.
Dino ne è ammaliato, la insegue nella radura «mentre la luce si faceva via via più fioca e più difficile il sentiero, tanto da metter paura», cerca di catturarla. Per un attimo pensa di averla fra le dita e sta per riporla nella propria scatoletta da collezionista, ma «una voce s’udì». Dino si guarda intorno e, non vedendo anima viva, comprende che è stata la farfalla a parlare «con voce agra e lamentosa di donna». Cantelinando, lamenta la perduta libertà di volare nel miele dei fiori, di vagare nell’aria, «fra queste quattro pareti dovrò per sempre languire».
Dino, novello Alacris Theresia, cui forse ironicamente l’autore allude, «educato da savie letture a tutte le delizie della pietà», si commuove, fa per liberare la farfalla, ma lei non c’è già più: approfittando del momento di commozione del ragazzo, è volata via e lo deride con una «risata di scherno».
Finalmente il gioco si palesa, Atropo si presenta e indica il suo reame nelle «contrade della notte». Si dichiara onnipotente e «terribile all’intero universo» «sovrana dovunque» ma respinta da un solo luogo, il castello senza tempo, come fosse una «lebbrosa», latrice di contagio e malattia.
Il castello senza tempo è la dimora degli Immortali, dove vivono gli antichissimi uomini scampati al diluvio, una sorta di malinconico limbo. I suoi abitanti sono stati creati «quando ancora non c’era il tempo» e, dunque, «vivono senza tempo» non invecchiano e non si corrompono mai, ripetono all’infinito gesti già compiuti e parole già dette, ri-giocano a dadi, a due a due, la stessa partita. Una ciclicità del Tempo/nonTempo dell’Eternità, il male peggiore, la non vita.
Gli abitanti non possono uscire dal Palazzo, sebbene lo desiderino, perché un «portiere e servo», Rutilio, impedisce loro la fuga e trasforma, chiunque tenti di entrare, in ragno, in verme o in topo al solo tocco di una bacchetta. Dino è il prescelto a spezzare l’incantesimo, ha «giovinezza, coraggio e innocenza» e con l’esuberanza della gioventù si offre di compiere l’impresa, vi farà entrare Atropo.
«Cammina cammina» giunge ai piedi di una gran torre e, grazie alle tre parole magiche «cugno cutugno balacanzicula», supera il «gigantesco guardiano» e s’introduce, alfine, nel castello. Castello che appare, a una prima occhiata, deserto, ma che è arredato con un gusto barocco da horror vacui che affastella «divani sbilenchi, letti a baldacchino pendenti da un fianco, armadi zeppi di cianfrusaglie, specchi torbidi come stagni… e quadri» ma quadri che raffigurano solo il medesimo volto «mostruoso e tuttavia triste, d’una nobile tristezza», quasi come nel Ritratto di Dorian Gray.
Gli abitanti, simili alle anime dantesche, si palesano all’improvviso in processione, «creature di straordinaria statura, vestite tutte di bianco», giovani nell’aspetto «ma cerei, cinerei» con uno sguardo d’ineffabile desolazione. Gli rivelano però che l’interdetto è scaduto e che il loro padrone e re, chissà se per misericordia o fastidi, ha deciso di non fare più la guerra agli intrusi. E come in ogni percorso di formazione, il protagonista subisce l’inganno rivelatore: a nulla sarebbero valse le sue parole magiche, il volo di Atropo senza il consenso del padrone del castello e ancora una volta fa il proprio ingresso nella narrazione la metafora del gioco.
Il padrone si è stancato del proprio «inerte giocattolo», spalanca, le porte del castello all’esterno, fa entrare il tempo e con lui la memoria e la morte. Subito i visi degli Immortali si riempiono di cicatrici, ma prima di afflosciarsi al suolo «come fantocci di pezza» ringraziano Dino per aver regalato loro «l’epilogo giusto». Mille pendole che riprendono a battere le ore, «dodici colpi vibrò contro uno scudo il pugno di bronzo d’un Moro sulla cornice d’un campanile, un filo di sabbia prese a scorrere nella clessidra, un gallo disse chicchirichì».
Una sveglia tedesca a doppia carica, «inflessibile trombettiera dell’indomani», riporta Dino alla realtà: deve alzarsi, vestirsi e correre a scuola, prima che il bidello Rutilio, non a caso omonimo del custode del castello, chiuda il cancello davanti ai ritardatari. Dino si precipita giù per le scale di casa, «cugnu cutugno bacalanzicula», ancora lo rassicurano in brandelli di visioni, tutto sembra essere tornato nei ranghi, ma dal libro di Scienze, rimasto aperto sul tavolo, si è dileguata proprio l’immagine della farfalla Acherontia atropos.
Si chiude con una suspense la bella favola, come nel migliore dei noir, col franco stupore sull’ancora da scoprire, ma in armonia con la poetica bufaliniana per cui non si può che vivere nella storia, accettando il naturale explicit della morte, accogliendo la dimensione del tempo unica latrice di memoria. Si può esistere, darsi un’identità solo nella memoria: «Memini ergo sum , mi piace ripetere» scrive in Cere perse.
di Nicla Bettazzi








