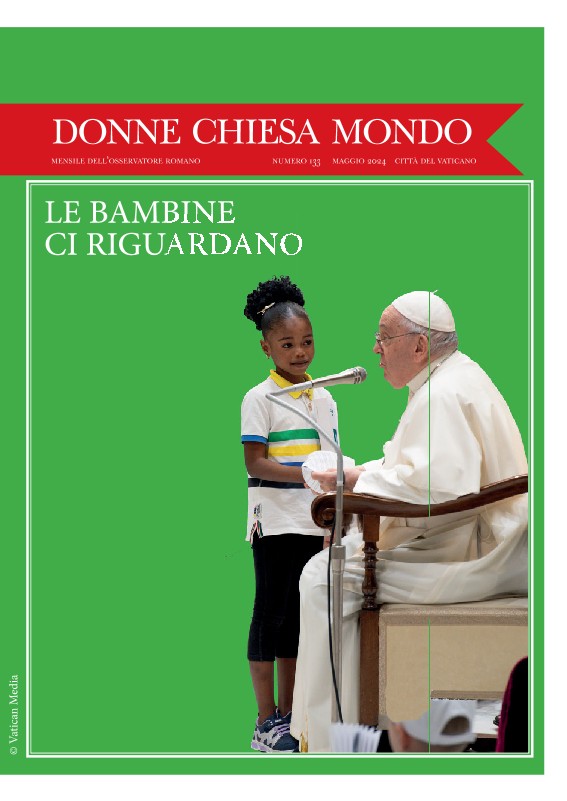La polizia arresta due sospetti di un reato punibile con tre anni di reclusione ma, avendo prove sufficienti solo per un’infrazione minore che prevede un anno di carcere, escogita il seguente stratagemma. Mette gli accusati in isolamento e a ognuno offre di denunciare il complice ottenendo in controparte un patteggiamento di pena di due anni che, nel caso in cui l’altro convenuto si fosse rifiutato di collaborare, sarà mutato in libertà condizionale. Cos’è meglio per un accusato: tacere e prendere un anno di carcere, rischiandone tre nel caso in cui il complice lo tradisse, oppure, accusare quest’ultimo, prendersi due anni di galera con la speranza di uscire libero se il correo fosse rimasto zitto? Questo celebre paradosso formalizzato a Princeton dal matematico Albert Tucker (1905-1995), sotto il nome di “dilemma del prigioniero”, permise al suo alunno John Nash — interpretato da Russell Crow nel film A Beautiful Mind, pellicola ricompensata agli Oscar del 2001 — di vincere il Premio Nobel per l’economia nel 1994, per aver introdotto nella “Game Theory” – descritta nel 1944, da Johnny von Neumann (1903-1957) e Oskar Morgenstern (1902-1977) — il principio dell’“Equilibrio di Nash”, che si verifica quando un giocatore non ha un interesse a cambiare la sua tattica, almeno di potersi coordinare con gli altri in una strategia collaborativa.
Uno degli aspetti più intriganti della Teoria dei Giochi è quello di aver formalizzato i procedimenti logici inerenti alla presa di decisioni. Nel best-seller The Decision Book. Fifty Models for Strategic Thiking (Profile Books, 2017), Mikael Krogerus e Roman Tschäppler della Neue Zürcher Zeitung, sono riusciti a descrivere in un pratico manualetto, corredato da ottimi diagrammi chiarificatori, ben 50 tipi di processi decisionali, per lo più utilizzati a livello aziendale. Ognuno di questi offre punti di forza a seconda dell’attenzione che consacra ad aspetti specifici del decision making: la Eisenhower Matrix (dall’omonimo generale e presidente statunitense) ha il vantaggio di distinguere le problematiche urgenti da quelle rilevanti, ottimizzando l’efficienza dei processi decisionali; il Swiss Cheese Model (elaborato da Dante Ornandella e James Reason all’Università di Manchester, sulla metafora di fette di emmenthal che concentrino i loro buchi nello stesso punto di un panino) permettere di minimizzare le coincidenze delle vulnerabilità, riducendo la probabilità di errori concomitanti; la Johari Window (contrazione dei nomi dei suoi inventori, Joseph Luft e Harry Ingham, della U.C.L.A.) favorisce soluzioni socialmente funzionali a scapito di altre divisive, aumentando così la coesione di un gruppo.
Esiste tuttavia una causa più fondamentale che impedisce a qualsiasi modello, per quanto elaborato esso sia, di contemplare tutte le opzioni e questa causa è, in ultima istanza, riconducibile ai meccanismi stessi insiti al funzionamento della mente umana, come intuiva con arguzia Peter Drucker (1909-2005) — da molti ritenuto il padre della gestione aziendale moderna — che si era imposto la regola di scrivere, ogni volta che prendeva una decisione importante, le ragioni della medesima e le conseguenze che preveda, per poi controllarne la fondatezza un anno dopo — scoprendo, troppo spesso, che si era sbagliato sia nelle sue premesse, sia nelle sue previsioni.
In tale senso, è illuminate il recente saggio di Albert Moukheiber, Votre cerveau vous joue des tours (Allary Éditions, 2019). Il giovane ricercatore francese si è prefisso l’obiettivo di armonizzare i dati dalla neuroscienza e quelli della psicologia cognitiva per comprendere meglio il funzionamento della mente umana nell’interpretare le informazioni, nel conservarle, nel rielaborarle e nell’utilizzarle per risolvere problemi. Per il Chargé de Cours a Paris VIII Vincennes-Saint-Denis, il nostro cervello, per assicurare la sopravvivenza della nostra specie, si è evoluto non tanto nella ricerca rigorosa di verità astratte quanto nell’estrapolazione e nell’approssimazione di informazioni all’interno di schemi capaci di rispondere adeguatamente a sfide pratiche.
Si consideri, prima di tutto, la percezione visiva. Il genio dei fratelli Lumière fu quello di utilizzare la pellicola fotografica sviluppata dal fondatore della Kodak, George Eastman (1854-1932), per proiettare in sequenza immagini fisse. Oggi sappiamo che l’occhio umano può vedere almeno 600 immagini al secondo, ossia una frequenza di 600 frames per secondo fps. Ma ancor prima che Walt Disney animasse Mickey Mouse, Otto Messner si rese conto che i movimenti del gatto Felix risultavano credibili lavorando alla frequenza di sole 12 immagine al secondo (12 fps), ma ripetendo una stessa immagine due volte per 1/24 di secondo. L’efficacia della tecnica ancora in uso del take-on-twos non dipende quindi dai limiti di impressione delle immagini sulla retina, ma dalla propensione del nostro cervello ad armonizzare i dati a sua disposizione (in questo caso, facendo ricorso all’illusione del movimento).
Questa propensione si estende ben al di là della visione e coinvolge tutte le funzioni cerebrali, fra cui la memoria e il linguaggio. È quanto osservarono, nel 1974, i ricercatori Elisabeth Loftus e John Palmer, facendo visionare dei filmini di incidenti automobilistici a dei giovani, con la scusa di un progetto sulla sicurezza stradale. Dopo la proiezione, notarono che degli elementi inesistenti nei filmini erano dati come certi da quanti lo avevano visionato — alla domanda: «Ricordate il parabrezza rotto?», i ragazzi rispondevano affermativamente, benché nessun parabrezza rotto fosse stato proiettato — e che persino l’interpretazione dei fatti era dipendente dalla verbalizzazione — alla domanda: «A che velocità stimate che i veicoli si siano toccati (contacted) / colpiti (hit) / urtati (bumped) / scontrati (collided) / distrutti (smashed)?», le rispettive risposte furono: 50 / 55 / 60 / 65 / 70 chilometri orari all’incirca.
Oggi, grazie a studi e strumenti più sofisticati, i neuroscienziati cercano di scoprire le funzionalità elementari del nostro cervello sottogiacenti alla creazione di schemi interpretativi nella mente umana. Alcuni postulano persino che il modello matematico più vicino al funzionamento basilare della nostra mente adoperi principi matematici simili a quelli della inferenza bayesiana, dal nome del matematico e ministro presbiteriano Thomas Bayes (1701-1762), vittima della persecuzione riservata ai puritani non-conformists dalla Chiesa di Inghilterra. La inferenza bayesiana è una forma complessa di inferenza statistica, la quale permette di postulare delle previsioni oggettive tenendo conto della soggettività delle osservazioni. Si pensi a un sacco contenente 100 palline, 80 blu e 20 rosse e a un osservatore che abbia come solo strumento di osservazione quello di estrarre una pallina alla volta per poi rimetterla nel sacco e ricominciare con un’altra estrazione; l’inferenza statistica è la procedura che calcola il numero di estrazioni necessarie per scoprire la composizione del sacco, al di dentro di intervalli di confidenza e di margini di errore (per questo, la maggior parte dei sondaggi avvertono che le risposte — le risposte, non la realtà si badi bene — sono, 19 volte su 20, attendibili con scarti di ±2 punti percentuali).
Ridurre il funzionamento del cervello a una procedura probabilistica può apparire ingiusto; non di meno, appare necessario chiedersi se, nella nostra mente, la correlazione e la causalità siano congiunte al punto che quest’ultima non sia che la probabilità di un evento ridotta a “0” (non può succedere) o stimata a “1” (succederà sicuramente)? D’altronde, un altro grande matematico contemporaneo di Bayes, Daniel Bernouilli (1700-1782), mentre risiedeva presso la corte imperiale di Russia, formulò, sulla base del gioco testa-o-croce, un’altra nota antinomia, il “Paradosso di San Pietroburgo”, che suggeriva che la mente umana si sdoppiasse tra la fedeltà a un dettato probabilistico e la soluzione concreta da conferire a un problema. Sicuramente, neppure questa duplicità rende giustizia alle meravigliose funzioni del nostro cervello evidenziate dal neurochirurgo Giulio Maria nel suo appassionato saggio cui titolo si ispira dal noto poema 632 di Emily Dickinson, Il cervello è più grande del cielo (Milano, Solferino, 2019) — «perché se li metti fianco a fianco, l’uno l’altro conterrà, con facilità e con te in aggiunta» — ma rinforza però il messaggio del meno conosciuto, ma forse più tagliente poema 937: I felt a cleaving in my mind, as if my brain had split. I tried to match it seam by seam, but could not make it fit — («sentì una fessura nella mia mente, come se il mio cervello si fosse spezzato in due; cercai di riconnetterlo cucitura per cucitura, ma non riuscii a farle combaciare).
di Carlo Maria Polvani