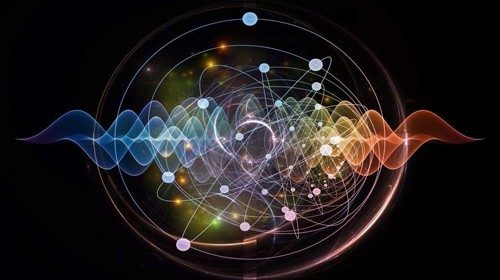
Aveva studiato ingegneria al Trinity College di Cambridge dove il corpo docente si distinse per miopia non riuscendo a vedere, nemmeno a intravederne il talento e le capacità: il 30 agosto di ottant’anni fa moriva Joseph John Thomson, fisico britannico che, nel 1897, scoprì la particella di carica negativa, l’elettrone. Nel 1906 gli fu conferito il premio Nobel per la fisica. Dal 1894 al 1919 fu direttore del laboratorio Cavendish di Cambridge. Membro di numerose accademie scientifiche (tra cui quella dei Lincei), rivestì la carica di presidente, dal 1915 al 1920, della Royal Society di Londra.
Autore di importanti lavori sull’elettromagnetismo indagato dal fisico scozzese James Clerk Maxwell, rivolse in seguito la sua attenzione allo studio della natura dei raggi catodici, argomento, questo, largamente discusso all’epoca. Dopo che il fisico francese Jean Baptiste Perrin, nel 1895, aveva dimostrato che i raggi catodici trasportano cariche elettriche negative, Thomson ottenne, due anni dopo, la loro deviazione in un campo elettrico: si convinse così che i raggi catodici sono costituiti da cariche elettriche negative portate da particelle di materia, dette poi elettroni, dei quali determinò le principali caratteristiche. Sempre nel 1897, con un esperimento passato alla storia, sottopose i raggi catodici all’azione di due contemporanei campi, uno elettrico, l’altro magnetico, e riuscì così a misurarne il rapporto tra carica e massa, nonché la velocità. Successivamente, osservando la migrazione collettiva di goccioline di nebbia cariche in campo elettrico, giunse ad una prima valutazione della carica dell’elettrone, e quindi della sua massa.
Mediante la misurazione del rapporto tra carica e massa, il fisico dimostrò che negli effetti fotoelettrico e termoelettrico sono emessi elettroni. Avvalendosi poi della preziosa collaborazione del chimico e fisico neozelandese Ernest Rutherford, mise a punto il metodo di misurazione dell’intensità delle radiazioni emesse dalle sostanze radioattive basato sulla ionizzazione da essa prodotta in un gas. Thomson utilizzò la scoperta degli elettroni per affrontare il complesso studio del fenomeno legato al passaggio di elettricità attraverso i gas, interpretandolo con la teoria della ionizzazione. Fu questo studio, quanto mai arduo e ostico anche per i modesti strumenti tecnologici disponibili all’epoca, a valergli il premio Nobel. Per ironia della sorte, anche al figlio, George Paget, fu conferito, nel 1937, il Nobel per la fisica, per aver dimostrato che l’elettrone è, di fatto, un’onda. Non è dato conoscere quelle che furono le reazioni del papà: fu felice per il riconoscimento dato al figlio, o fu meno felice perché George aveva in qualche modo corretto, anche grazie a una strumentazione più progredita, le dimostrazioni che aveva realizzato e i risultati cui era pervenuto? Tra le opere di Thomson figurano Conduction of electricity through gases (1903), The corpuscolar theory of matter (1907), Rays of positive electricity and their applications to chemical analysis (1913).
La scoperta dell’elettrone riproponeva il problema della struttura della materia e Thomson propose un modello di atomo, costituito da una distribuzione continua di elettricità positiva, nella quale si muovono su varie traiettorie circolari concentriche tanti elettroni quanti sono necessari per compensare la carica positiva. Il modello atomico di Thomson, poi superato da quello forgiato da Rutherford, ebbe comunque una significativa importanza poiché evidenziò il problema delle instabilità radioattive comune a qualunque modello atomico. Il suo lavoro fu continuato dal suo fedele assistente Francis William Aston che, nel 1920, pervenne alla costruzione dello spettrografo di massa, allora chiamato parabola spettrografica, uno strumento che consentiva di determinare il rapporto tra la massima e la carica degli ioni e che da allora è diventato uno strumento di nevralgica importanza nella chimica.
Per quanto stimato in vita, e le prestigiose cariche rivestite lo confermano, Thomson in realtà non godette della piena e incondizionata fiducia della comunità accademica. Tra realtà e finzione si tramanda che il Nobel gli fu conferito perché quell’anno la concorrenza non era molto competitiva e agguerrita. Solo dopo la morte, come non di rado, accade, l’autentico valore dei suoi studi e delle sue ricerche, fu riconosciuto all’unanimità. Quasi come un atto riparatore va letta la decisione, da parte delle autorità istituzionali, di riservargli la sepoltura nell’Abbazia di Westminster, accanto a Isaac Newton.
di Gabriele Nicolò








