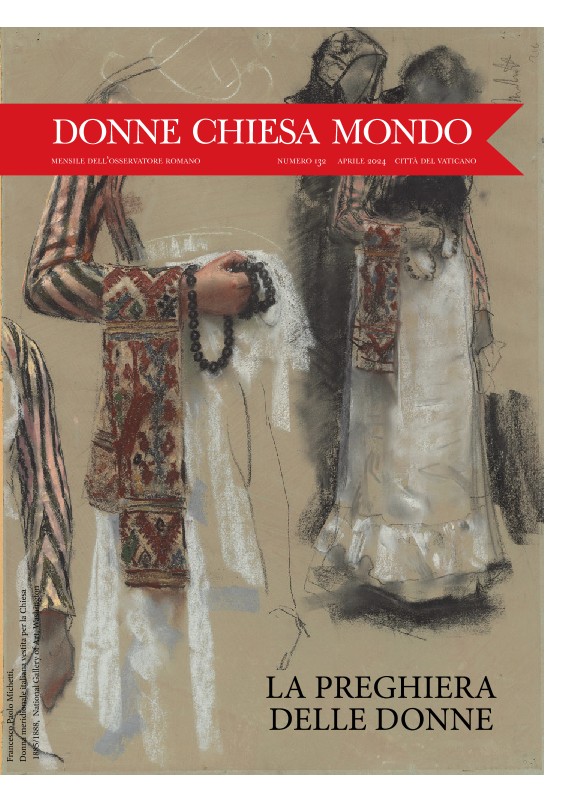Con Alan Parker se ne va uno degli ultimi outsider del grande schermo. Uno di quei registi che, pur facendo un cinema spettacolare che non disdegna l’intrattenimento, vogliono rimanere dei cani sciolti allergici alle dinamiche del sistema commerciale. Non stupisce affatto, in tal senso, la recente dichiarazione dello stesso Parker a proposito del rifiuto di dirigere episodi della serie di Harry Potter. Allo stesso tempo, il regista britannico non ha mai aspirato molto alle passerelle dei festival, dove pure a volte i suoi film sono stati presentati.
L’eclettismo di Parker, nato a Islington il 14 febbraio 1944 e scomparso il 31 luglio a Londra, non era un modo di piegarsi alle direttive dei produttori, ma un’inclinazione del tutto personale e istintiva. Se ha girato film sempre attraverso produzioni o coproduzioni americane, è stato solo per assicurarsi un alto standard tecnico. La varietà dei temi affrontati gli ha impedito di avere una poetica coerente da autore in senso stretto, ma non una personalità e uno stile viceversa fortemente riconoscibili.
La personalità è stata quella dell’avventuriero che sonda ogni volta zone cinematografiche nuove per avere in prima persona un senso di sorpresa da inglobare nel suo modo di fare cinema, allo stesso tempo molto tecnico ma anche molto spontaneo.
Il suo stile, davvero peculiare, concilia la vecchia matrice realista del cinema britannico — fino ad arrivare, a tratti, ad accenti da documentario — con la nascente estetica del videoclip e degli spot pubblicitari, di cui il regista cavalca in particolare le qualità emozionali e l’uso ipertrofico del montaggio, di cui diventa un maestro. Il risultato è un flusso di immagini e suoni che dà l’impressione di assecondare esclusivamente l’inventiva del suo autore, seguendo più un percorso di associazioni di idee che non un filo strettamente narrativo e drammaturgico.
È un cinema figlio dei suoi tempi, fatto molto più di immagini che non di costruzione dei personaggi o di un racconto inteso nel suo modo più convenzionale. Per lo spettatore si tratta, almeno nelle prove migliori, di un viaggio sensoriale straordinariamente immersivo e coinvolgente. Un cinema di cui già si sente molto la mancanza, in un periodo in cui la televisione sta viceversa appiattendo l’uso delle immagini sul dominio della parola e del racconto più piano.
Dopo alcuni trascorsi come autore proprio di spot pubblicitari, la carriera di Parker nel cinema comincia in patria ma con un film che già guarda esplicitamente oltreoceano. Bugsy Malone (1976) è un omaggio ai gangster-movie americani interpretato però solo da bambini che usano torte al posto di armi. Non è solo un divertissement, dato che il tema dell’infanzia e dell’adolescenza, più in generale dell’innocenza, in contrasto con la durezza del mondo tornerà ciclicamente nella filmografia del regista. Midnight express (1978), storia vera del calvario di uno studente statunitense nelle prigioni turche, è l’esordio americano e il primo film di successo. Anche a causa della mano un po’ sopra le righe di Oliver Stone in sede di sceneggiatura, il sensazionalismo non manca, ma il film è il primo esempio della capacità di Parker di immergere lo spettatore in un racconto con la semplice forza delle immagini, e di rendere con straordinaria fedeltà sensoriale l’atmosfera di un ambiente.
Fame (1980) è un film sottovalutato forse a causa della più banale serie televisiva a cui darà vita. È uno dei pochi musical del cinema moderno e condensa alla perfezione le passioni del regista: la musica, il mondo dell’adolescenza, il desiderio di inserire i personaggi in un contesto realistico restituito con fedeltà allo sguardo del pubblico. Shoot on the moon (1982) è un buon dramma familiare e l’unico film con cui il regista si è avvicinato a una moda, in anni in cui pellicole come Gente comune e Kramer contro Kramer vincevano Oscar. Con Pink Floyd – The Wall (1982), però, Parker torna subito a un cinema più personale e alla sua passione per la musica, firmando un videoclip di due ore che rappresenta una riuscita versione visiva del famoso album della band britannica.
Birdy (1984) è un altro film lontano da qualsiasi schema. La storia di un reduce dal Vietnam che diventa pazzo e dell’amico che cerca di farlo rinsavire è di nuovo un omaggio alla forza della giovinezza e il ritratto di un’innocenza perduta. Si parla di Vietnam ma il modo di interiorizzare la guerra e di declinarla in senso intimistico è fortemente british. Con Angel heart (1987) il cinema di Parker si mantiene ad alti livelli. Il film è un horror mefistofelico che parte come una detective-story alla Raymond Chandler. La capacità del regista di rendere un ambiente – in questo caso la Louisiana degli anni Cinquanta e di immergere lo spettatore nel racconto — un’agghiacciante discesa agli inferi scandita da riti esoterici e incubi che forse sono invece ricordi — raggiunge il culmine. Il periodo d’oro prosegue con Mississippi burning (1988), solido dramma sulle discriminazioni razziali nel sud degli Stati Uniti degli anni Sessanta, in bilico ma in perfetto equilibrio fra spettacolo e impegno civile.
Dopo il meno riuscito dramma storico Come see the paradise (1990), Parker firma forse il suo film migliore con The Commitments (1991), irresistibile storia di un gruppo di ragazzi di Dublino che vogliono diventare famosi con una band di musica soul. Quasi un nuovo Saranno famosi, ma ben più sentito. I sogni dell’adolescenza in contrasto con la dura realtà vengono raccontati stavolta con leggerezza ma con grande passione e humour. Il ribellismo e gli scontri generazionali sono mitigati da un senso di appartenenza alle proprie origini che si fonde con la ricostruzione ambientale dei sobborghi dublinesi, resi con consueta maestria.
Dopo questo ulteriore picco, gli ultimi dieci anni della carriera del regista sono meno esaltanti. The road to Welville (1994), satira sul salutismo, è l’unico film da dimenticare, nonostante l’ennesima ammirevole ricostruzione ambientale. Evita segna invece un ritorno al musical con uno spettacolo stranamente un po’ statico, sontuoso ma inamidato, dall’opera teatrale della grande coppia Webber-Rice. E anche Angela’s ashes (1999) non si rivela all’altezza della fonte, il best-seller di Frank McCourt.
Dall’ultimo film, The life of David Gale (2003), un ritorno all’impegno civile in questo caso contro la pena di morte, era già passato quasi un ventennio. A fermare il regista è stata una lunga malattia ma anche un cinema che nel frattempo aveva smesso di assomigliargli.
di Emilio Ranzato