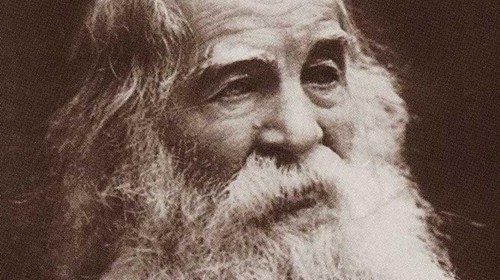
Diverse indagini religiose degli ultimi anni ci hanno consegnato un dato empirico concordante: gli Stati Uniti sono uno dei Paesi occidentali dove la popolazione assegna alla fede un’importanza significativa nella propria vita. Ciò avviene soprattutto in quella Bible Belt, la “cintura della Bibbia”, quegli Stati della zona centro-occidentale degli Usa nei quali l’esperienza religiosa — cristiana nelle sue diverse denominazioni: l’esperienza nata dal Vangelo si è disseminata in una polverizzazione comunitaria di mille e diverse sigle — ha plasmato e plasma tutt’ora la coscienza civile e dà forma al vivere sociale. Nelle sue diverse esperienze questa dimensione, al contempo molto personale ma che assume anche volti peculiarmente comunitari, è quanto Marilynne Robinson o Elizabeth Strout, per fare due nomi, cantano e ritraggono con grazia e profondità nei loro convincenti romanzi: ovvero, che la dimensione religiosa tocca e intreccia la vita quotidiana.
Qualcosa del genere è quanto ci restituisce l’ultimo romanzo di Nickolas Butler, Uomini di poca fede (Marsilio, Venezia 2020, pagine 271, euro 17), ambientato nel Wisconsin, patria di questo narratore che ci offre un testo profondo, dove le domande urticanti sul credere e sul come credere pongono i personaggi davanti al mistero dell’affidamento al divino. L’intera vicenda narrata da Butler gira intorno ai grandi interrogativi: il male, il dolore innocente, la preghiera e la speranza, la malattia e il fideismo estremista.
In sintesi i fatti narrati: il protagonista Lyle e la moglie Peg hanno perso il figlio in giovane età, a soli 3 anni. Per questo tutto il loro amore si riversa sul nipote Isaac, figlio della figlia (adottiva) Shiloh. La figlia ad un certo punto inizia a frequentare e poi ad unirsi sentimentalmente al giovane pastore Steven, molto carismatico rispetto al più anziano e più tradizionale reverendo Charlie, il pastore del villaggio. Il nodo del romanzo ruota intorno al fatto che Steven ritiene che Isaac abbia poteri soprannaturali e che possa guarire le persone ammalate grazie all’imposizione delle mani. E qui si concentra il materiale incandescente del romanzo: come si fa a credere? Cosa credere? In un dio o in Dio? Butler sembra dare le risposte a queste domande attraverso i vari personaggi che si alternano sul proscenio del suo romanzo. Le risposte che Butler ci sottopone esemplificano le diverse gradazioni con le quali la popolazione yankee considera importante (o non considera) la religione all’interno della scala di valori della propria esistenza.
Una risposta dell’autore è la fede estremista di Steven, sicuro che il piccolo Isaac sia un guaritore. Solo alla fine del romanzo scopriamo che si tratta di un losco figuro, che approfitta della debolezza delle persone e che già in altri paesi aveva «rubato» la fiducia della comunità.
Butler ci suggerisce una seconda risposta: la non fede nell’aldilà e nemmeno in Dio di Otis, l’amico di Lyde, che di fronte alle domande del protagonista («Pensi che ci sia qualcos’altro, Otis, dopo che noi… dopo questo?»), risponde: «Cibo per i vermi. Ecco cosa viene dopo. Un composto gustoso per l’erba che ci ricopre. Non ce l’ha insegnato il buon Walt Whitman?». C’è la fede umana di Charlie, il pastore della comunità di Sant’Olaf: «Lyle, essere un cristiano — diamine, essere una brava persona — consiste nel prendersi cura di tutti, di tutta la vita umana. Io ti voglio bene, amico. Ma ci sono momenti in cui mi sembri convinto che le persone tradiscano la religione se non fanno la-cosa-perfetta-ogni-maledetta-volta. Tu sei Lyle Hovde. Ti è permesso dubitare del mondo, di te stesso, della religione. Io però ti conosco. Nemmeno tu hai tutte le risposte. Altrimenti non busseresti alla mia porta alle dieci di sera nel bel mezzo di un temporale».
E, infine, c’è la fede sofferta, in cammino, affannata ma sincera di Lyle, marito, padre e nonno. Colui che afferma di non aver fede quando risponde alla figlia esaltata con il suo «Tu non credi, vero?» e che risponde: «Non lo so. No, suppongo di no». Anche perché reduce dalla terribile esperienza di aver perduto un figlio in tenerissima età, Lyle non crede, non riesce a credere in un Dio buono. È quello che confessa al reverendo Charlie: «Ci ho provato, Charlie. Ho provato a credere. Ho provato ad aprirmi, davvero… Ma non ci sono riuscito. Non ce l’ho fatta». Ma poi anche Charlie, man mano che le vicende si intersecano — ad esempio, con la malattia dell’amico Hoot — arriva a sperimentare la forza di un Altro che si fa presente nella sua vita: «In quella stanza d’ospedale ho sentito qualcosa. Non riesco a spiegarlo» confida alla moglie. Eccole le diverse gradazioni della fede che l’autore sembra suggerirci: la fede estremistica; la non fede per definizione; la non fede a causa di una sofferenza; e c’è la fede che sente il mistero oltre le cose.
Butler scrive il suo romanzo rifacendosi a un fatto di cronaca: una bambina che nel 2008 nel Wisconsin morì perché, invece di curare il suo diabete, i genitori preferirono affidarsi alla preghiera. Ma non è propriamente questo il contributo più convincente che Butler offre al lettore. Le estremizzazioni dei suoi personaggi, la ricerca spirituale del protagonista, la natura e l’amore per il creato che sembrano un contraltare cosmico al senso di famiglia e di comunità (a volte malato, come quello del pastore Steven) che contraddistinguono i paesi della Bible Belt, questi sono gli elementi che rendono Uomini di poca fede un romanzo di spessore, nel quale rintracciare i molti volti con i quali gli uomini e le donne del nostro tempo si pongono davanti alla Grande Domanda della vita.
di Lorenzo Fazzini








