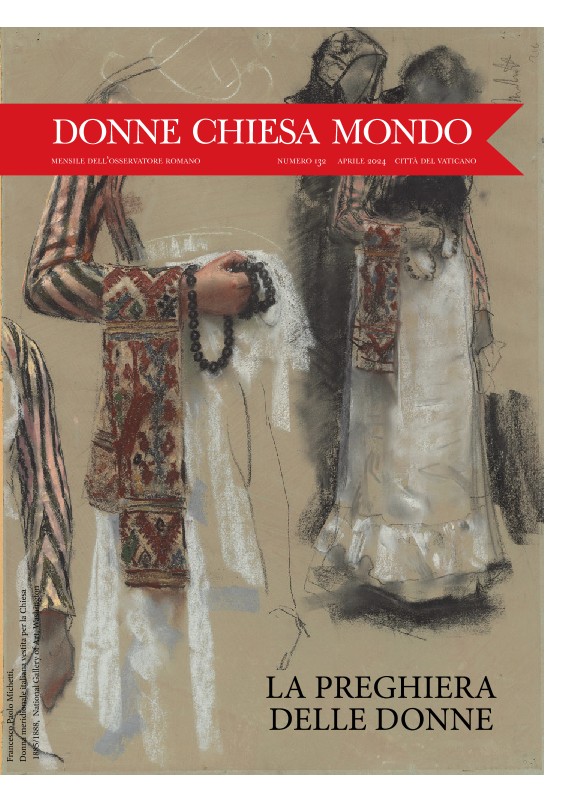L’appuntamento per l’intervista è alle 21 ora italiana. Meglio vedersi su Skype, è più sicuro, si evita il rischio di essere intercettati e di trasformarsi in un obiettivo dei cecchini o di qualche bomba “intelligente”. E poi ci si può guardare dritto negli occhi, per non nascondere le emozioni. Non siamo soli, nella chiacchierata virtuale. Da un sottoscala di Kiev, mentre fuori si continua a bombardare, si collega anche un suo amico, don Maxim, un salesiano che non è scappato, nonostante i cadaveri nelle strade, i palazzi collassati come burro fuso e quasi più nulla da mettere sotto i denti. «Scusate il ritardo ma avevo ospiti con i quali stavo parlando. Li ho appena salutati» esordisce il religioso, con un italiano quasi perfetto.
Ospiti in un bunker, in tempo di guerra: una pennellata di vita quotidiana che, da questa parte del mondo, appare a tratti surreale. Meno male che alla fine si è collegato, don Maxim. Con il mio inglese imperfetto, non avrei potuto intrattenere oltre il mio interlocutore, che, tra l’altro, della lingua di Sua Maestà conosce ben poco. Prima di chiedere a don Maxim di iniziare a tradurre, ho un attimo di esitazione: ma davvero quel ragazzo dalla carnagione chiara, i capelli corti e ben ordinati, gli occhi grandi e limpidi, il sorriso sempre sguainato, è il prete che celebra coraggiosamente la messa nei bunker e negli scantinati mentre fuori infuria la battaglia? «Vuoi sapere davvero quanti anni ha Mykhailo Kramar? Ne ha 27 e soltanto da cinque mesi è stato ordinato sacerdote» mi dice, quasi compiaciuto, don Maxim. Non ci posso credere: così giovane e già amministratore apostolico della parrocchia greco-cattolica presso l’università nazionale del politecnico di Kiev e responsabile della pastorale giovanile dell’arcieparchia della capitale ucraina. «Sono anche sposato. Anzi, prima mi sono sposato e poi sono diventato sacerdote» racconta don Kramar. Sicuramente sua moglie sarà stata fiera di lui nel vedere una foto che toglie il fiato: Mykhailo, con indosso la stola, celebra l’eucaristia all’interno di un bunker. Uno spazio basso e angusto, illuminato da una lampadina e come altare un semplice tavolino. Dietro di lui, donne e bambini assorti in preghiera, con le mani giunte. «Quella foto è stata scattata di domenica nella mia città natale, Vyšhorod, dove ora mi trovo» ci tiene a precisare il sacerdote. Dista venti chilometri da Kiev e sente il rumore delle bombe ogni giorno avvicinarsi sempre di più. Ecco perché lui ed un altro prete della parrocchia cittadina hanno pensato bene di utilizzare i kit portatili per la messa andando a celebrarla negli appartamenti e nelle case delle famiglie che ne fanno richiesta. È meglio non far rischiare la vita ai fedeli, che potrebbero essere colpiti nel percorso di andata o di ritorno per raggiungere la chiesa: la vita preferiscono rischiarla loro. «Se ci troviamo in casa mentre suona l’allarme scendiamo nei bunker e lì continuiamo la celebrazione» spiega il sacerdote col volto da bambino. «L’alternativa sarebbe quella di farla solo con il chierichetto, senza il popolo» aggiunge, facendo capire che l’ipotesi non l’ha mai seriamente presa in considerazione, neanche per un attimo.
Passano i minuti, l’intervista continua, ma don Kramar non è stanco. La luce fioca del bunker rende ancora più eterea la sua figura, la fa quasi sbiadita, come se ci si dovesse concentrare più sulle sue parole, sulle sue preoccupazioni. Con voce squillante, ricorda che fin dall’inizio del conflitto «i fedeli hanno espresso il bisogno di potersi confessare o semplicemente poter condividere i propri sentimenti con i sacerdoti ed ottenere parole di conforto e di speranza». Ed i preti non si sono tirati indietro. Quando il traduttore, don Maxim, ascolta la storia di una parrocchiana toccata profondamente dal comportamento di don Mykhailo, prima di trovare le parole giuste per raccontarla in italiano sembra avere un momento di commozione: «Dopo che la signora ha partecipato alla messa celebrata nel suo appartamento ha esclamato: “Io non torno più nel bunker, perché oggi il Signore ha visitato la mia casa”. E così ha fatto, nemmeno con le esplosioni che risuonavano sulla sua testa».
Bisognerebbe scrivere un libro, per raccontare la vocazione del prete coraggioso con la faccia da bambino. Gli zii, i cugini, il fratello: tutti sacerdoti. E poi i dubbi, l’incontro decisivo con un vescovo, gli anni del seminario, il matrimonio. L’intervista dura da più di un’ora, per don Kramar potrebbe andare avanti anche per tutta la notte, fino alla fine del coprifuoco. È un fiume in piena, vorrebbe far capire al mondo che la guerra è una terribile tragedia che non vedrà né vincitori né vinti. Prima di salutarlo, gli chiedo di lanciare un appello alla comunità internazionale e a quei soldati russi, spesso suoi coetanei, che stanno imbracciando il fucile e sganciando bombe: «Eccolo, il mio appello, proviene dal cuore: come dice il Vangelo, imparate a conoscere la verità e la verità vi farà liberi. E una volta conosciuta la verità, dovete avere il coraggio di fare un passo indietro. Solo così troverete la libertà». L’intervista termina così, ci salutiamo promettendoci di rimanere in contatto, anche se entrambi sappiamo che potrebbe essere una bugia: con una guerra in corso, promesse di questo tipo non se ne dovrebbero mai fare. La videocamera si spegne, come la luce del bunker dove don Mykhailo Kramar trascorrerà un’altra notte insonne. Un’altra notte di missili e di paura.
di Federico Piana