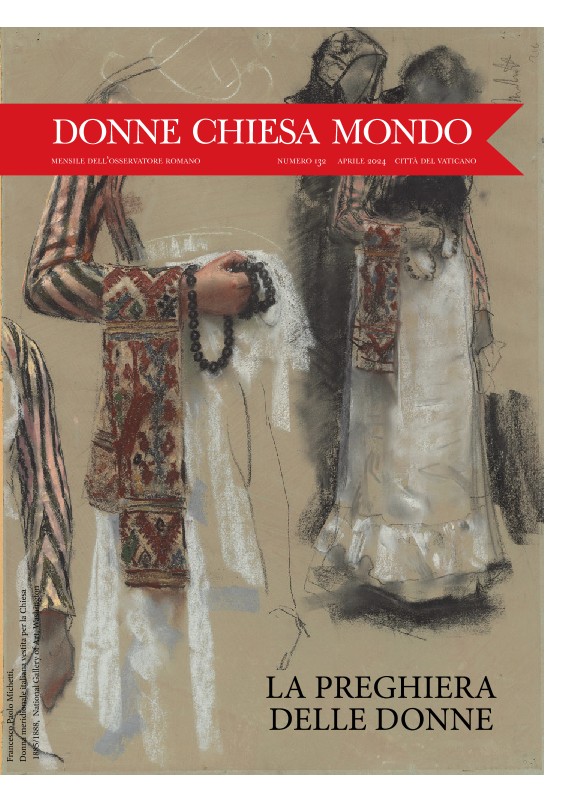«Quando riesci a far sì che gli altri ammirino i tuoi ideali e che desiderino ciò che tu stesso vuoi, non serve utilizzare il bastone e la carota per far muovere le persone verso la tua direzione. La seduzione è sempre più efficace della coercizione, e numerosi valori come democrazia, diritti umani, e opportunità dell’individuo sono profondamente seducenti». Con queste parole ad effetto il professor Joseph Samuel Nye Jr., politologo statunitense e professore alla Harvard University, ha descritto efficacemente il concetto di «soft power», da lui stesso coniato alla fine degli anni ‘80, ed entrato nel lessico internazionale a seguito di un articolo che pubblicò sulla rivista statunitense Foreign Policy nel 1990.
È evidente che il soft power scaturisce dal fascino per la cultura, la politica e gli ideali di un qualsivoglia Paese, strategia questa che dipende molto dalla buona reputazione che uno Stato possiede all’interno della comunità internazionale e dal flusso comunicativo che gli attori del sistema riescono ad innescare tra loro in modo armonico ed unisono.
Tenendo bene a mente il lascito di un famoso sovrano prussiano, Federico il Grande — «la diplomazia senza il potere è come un’orchestra senza spartito» — il professor Nye ha di fatto confutato il concetto di «hard power», ossia l’affermazione di un potere politico, economico e militare atto al predominio geopolitico da parte di uno Stato. Secondo l’accademico statunitense, la forza attrattiva del soft power è capace di suscitare delle affinità e sinergie su altri attori statali, ottenendo in modo non invasivo il controllo nel teatro globale senza incorrere in situazioni di conflittualità e soprattutto negli ingenti costi che invece l’hard power comporta. Da questo punto di vista il cosiddetto soft power, se correttamente interpretato, potrebbe rappresentare l’antidoto per andare al di là dell’immobilismo che caratterizza spesso i summit internazionali o i vertici bilaterali.
Si tratta di uno scenario purtroppo ricorrente sul palcoscenico delle nazioni, ben descritto dall’economista, giornalista e scrittore venezuelano Moisés Naím, «un mondo in cui i protagonisti dispongono di potere sufficiente per bloccare le iniziative di tutti gli altri, ma nessuno ha il potere di imporre la propria linea d’azione, è un mondo in cui le decisioni non vengono prese».
Sulla grande stampa internazionale il modello di soft power che solitamente viene raccontato è quello cinese in riferimento al progetto visionario e di lungo periodo, lanciato nel 2013 dal presidente Xi Jinping: la Nuova Via della Seta, meglio nota con gli acronimi obor (One Belt One Road) e bri (Belt and Road Initiative), in cinese yidai yilu, un’iniziativa prevalentemente infrastrutturale, tesa a collegare, almeno inizialmente, più di 60 Paesi in Asia, Europa e Africa, beneficiando oltre 4 miliardi di persone. Da rilevare che nel maggio del 2017 è stata annunciata l’estensione del bri anche ai Paesi dell’America Latina, e nell’ottobre dello stesso anno, il suo inserimento nella Costituzione del Partito comunista cinese ne ha suggellato la caratteristica di un generatore simbolico della politica cinese dei prossimi anni.
Questo indirizzo geostrategico è stato visto, com’era prevedibile, con un certo sospetto da una parte significativa della comunità internazionale, soprattutto in riferimento al meccanismo di creazione di crescenti livelli di dipendenza dei Paesi coinvolti nel partenariato nei confronti di Pechino, quelli africani in primis, per via della loro incapacità a ripagare i debiti contratti per la realizzazione delle infrastrutture, la cosiddetta «trappola del debito». Queste accuse sono state comunque ridimensionate dalla China-Africa Research Initiative della John Hopkins University — diretta da Deborah Bräutigam, una delle massime esperte di presenza cinese in Africa — e dal Global Development Policy Center della Boston University.
Le ricerche condotte da questi centri universitari hanno prodotto «scarse prove» circa un modello che indichi chiaramente come le banche cinesi, agendo per conto del governo di Pechino, stiano volutamente finanziando progetti in perdita con il proposito di consolidare una strategia di dominio mondiale cinese, facendo deliberatamente ricorso all’arma del debito. In effetti, stando alle stesse fonti accademiche, su 17 Paesi oggetto di analisi, classificati dal Fondo monetario internazionale (Fmi) come vulnerabili, solo per tre di loro — vale a dire Gibuti, Repubblica Democratica del Congo e Zambia — i prestiti cinesi ammontano alla metà o più del debito pubblico.
Detto questo, parlando proprio del soft power in Africa, sarebbe davvero riduttivo ricondurlo solo e unicamente all’influenza operata dalla Cina. È uscito recentemente un saggio a firma del professor Oluwaseun Tella della University of Johannesburg’s Institute for the Future of Knowledge (Sud Africa), dal titolo più che emblematico: Africa’s Soft Power: Philosophies, Political Values, Foreign Policies and Cultural Exports. Ciò che colpisce maggiormente è lo sforzo dell’autore di africanizzare il concetto di soft power andando ben al di là dei tradizionali stereotipi negativi che vengono attribuiti all’Africa, come malattie, corruzione, guerre e carestie. L’attenzione di Tella si concentra su quattro Stati chiave del continente africano: Nigeria, Sud Africa, Kenya ed Egitto. Ecco che allora le filosofie africane di spicco di questi Stati — rispettivamente Omolúwàbí, Ubuntu, Harambee e Pharaonism — vengono presentate come modelli interpretativi di un pensiero collettivista, all’insegna appunto di un soft power tutto africano, in contrapposizione, ad esempio, alla nozione occidentale del primato dell’individualismo e di un ordine internazionale gerarchico ed esclusivo.
L’autore ha inoltre colto altre importanti fonti di soft power negli Stati africani oggetto della ricerca. Ad esempio, il soft power nigeriano include componenti variegate che vanno da Nollywood (industria cinematografica), a Afrobeats (industria musicale); dalle grandi imprese alla promozione della democrazia e mantenimento della pace attraverso un ruolo significativo della Nigeria nelle organizzazioni internazionali come la Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Ecowas) e dell’Unione africana (Ua). In concreto, Nollywood e Afrobeats hanno promosso la cultura nigeriana e sfidato i sentimenti anti-nigeriani globali. Al contempo, il governo di Abuja ha realizzato la sua politica estera di promozione della democrazia in Stati come Sierra Leone, São Tomé e Príncipe e Togo, e di pacificazione e mantenimento della pace in Liberia e Sierra Leone, fornendo l’80 per cento delle truppe e il 90 per cento dei finanziamenti nei processi di peacekeeping. Questi guadagni di soft power sono, tuttavia, limitati dalla corruzione politica, dal deficit di democrazia, dalla crisi dell’immagine del Paese e dal terrorismo di matrice Boko Haram.
Significativa è anche il soft power sudafricano che ha come fonti, oltre la propria forte vocazione imprenditoriale, il disarmo nucleare che funge da apripista per organizzazioni come il New Partnership for African Development (Nepad) e l’African Peer Review Mechanism (Aprm); per non parlare della sua capacità promozionale e recettiva di eventi sportivi e scambi educativi. A tutto questo occorre aggiungere gli sforzi profusi nel sostegno alla diplomazia di pace in Paesi come il Burundi e la Repubblica Democratica del Congo (Rdc). I vantaggi concreti di queste fonti di soft power made in South Africa includono l’hosting della prima (e unica) Coppa del Mondo fifa in Africa, l’attrazione delle università sudafricane per gli studenti africani, le idee dell’ex presidente Thabo Mbeki che sono radicate nelle principali istituzioni africane come nepad e la reputazione del Paese come unico membro africano dei brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa) e del G20. La soft power del Sud Africa è, tuttavia, minata dalle tre grandi sfide della povertà, della disuguaglianza e della disoccupazione; così come la corruzione.
Naturalmente le stesse osservazioni, con declinazioni diverse, sono raccontate da Tella in riferimento al Kenya (il patrimonio culturale espansivo, evidente nelle accademie, nell’industria della moda, nel successo nell’atletica e nelle sue attrazioni turistiche che hanno un valore indicibile) e in Egitto (emblematica la presenza dei lavoratori egiziani qualificati, in particolare nella regione mena — Medio Oriente e Nord Africa — importante fonte di simbolica cooperazione e diplomazia popolare).
Detto questo è importante ricordare che proprio in Africa si evidenzia la peculiarità di un soft power davvero singolare, perché capace di coniugare la diplomazia con le istanze della Casa Comune. Stiamo parlando della Santa Sede che attraverso le sue nunziature promuove il Vangelo della Pace con il valore aggiunto dell’empatia umana di Papa Francesco. Tutto questo, tessendo missioni davvero significative in Paesi come la Repubblica Centrafricana, o ricercando la pace in Sud Sudan, oltre ad incoraggiare transizioni complesse in Paesi particolarmente fragili. Un soft power, quello della Santa Sede, che fa delle periferie il centro del mondo.
di Giulio Albanese