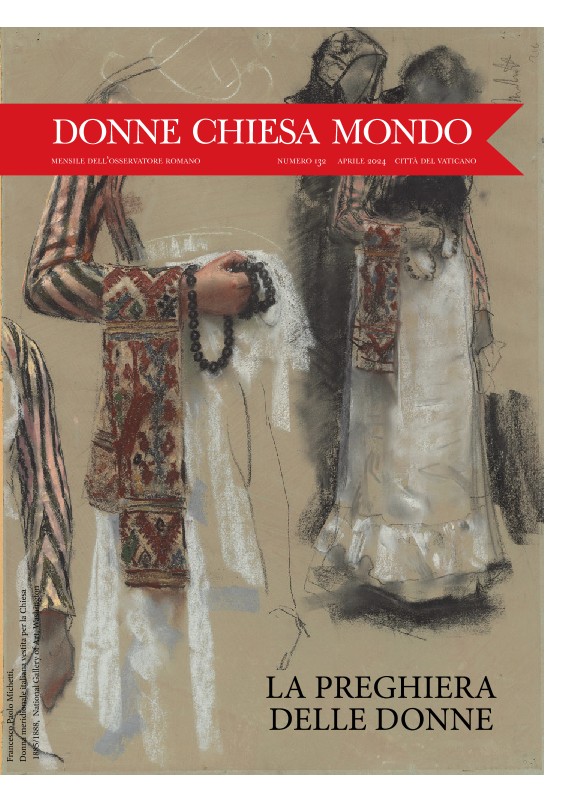Prendersi cura dei malati, soccorrere gli afflitti, portare regali e far giocare i bambini, donare aiuti materiali agli anziani e agli indigenti: è stato un Natale all’insegna della solidarietà e della condivisione quello vissuto — grazie alla presenza di volontari e operatori umanitari cristiani — nei campi profughi di Cox’s Bazar, alla periferia orientale del Bangladesh, dove sono assiepati oltre un milione di rifugiati di etnia rohingya. Fuggiti tre anni fa dal Myanmar, vivono in campi sovraffollati e insediamenti improvvisati, con scarso accesso a servizi igienici adeguati e acqua pulita. Le precarie condizioni di una vita che dipende in toto dagli aiuti delle organizzazioni internazionali generano facilmente malattie, mentre i primi casi di infezione da coronavirus hanno destato ulteriore preoccupazione.
I rohingya sono musulmani ma lo spirito autentico del Natale, quello intriso di prossimità e fraternità, lo hanno avvertito e apprezzato: sono diverse le associazioni cattoliche e le organizzazioni di ispirazione cristiana che si sono mobilitate per l’assistenza a questi profughi di lungo corso che vivono in un ambiguo stato di sospensione. Non sanno, infatti, quale sarà il loro futuro, se e come potranno tornare in terra birmana, e un senso di incertezza e di lunga precarietà pervade la loro esistenza.
«In tempo di pandemia di covid-19, come volontari, rafforziamo l’impegno di restare accanto ai rifugiati rohingya, offrendo sostegno umanitario e promozione umana, cura della sofferenza, istruzione e formazione professionale. Sono qui da ormai tre anni, mentre le luci dell’attenzione internazionale sembrano spegnersi. In occasione del Natale abbiamo cercato di far sentire loro la nostra profonda empatia, vicinanza e solidarietà», dichiara il gesuita padre Pradeep Perez, membro del team del Jesuit refugee service, oggi presente in Bangladesh a fianco dei rifugiati rohingya. Il confratello padre Jeyaraj Veluswamy, impegnato a livello sociale e pastorale tra i profughi a Cox’s Bazar, ricorda a sua volta: «Vivono in un limbo, nei trentaquattro campi istituiti dall’Alto commissariato Onu per i rifugiati e dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni. Il 25 agosto scorso è stato il terzo anniversario dell’esodo di massa dei profughi dal Myanmar al Bangladesh, iniziato nel 2017. Oggi si ritrovano anche a subire l’impatto della pandemia di covid-19. C’è grande paura tra le famiglie rohingya ed è difficile prendere precauzioni per proteggersi dal virus».
Mentre la tensione è palpabile, la solennità del Natale ha portato un germe di nuova speranza. Il 25 dicembre è un giorno festivo in Bangladesh, anche se i cristiani sono solo lo 0,3 per cento circa su una popolazione di 170 milioni di persone, all’85 per cento musulmane. In Bangladesh è inverno, ma la stagione è fresca e secca e la temperatura è mite e non si registrano le piogge che in altre stagioni inondano il territorio. È, dunque, un tempo favorevole per avviare attività sociali, programmi di formazione e di istruzione. Sono tutte attività fondamentali per far sì che la vita nei campi risulti dignitosa e tollerabile. Perché, come riferiscono gli operatori umanitari, numerosi giovani rohingya, spinti dalla disperazione, ricorrono ai trafficanti di esseri umani per farsi condurre in altre nazioni come Malaysia e Indonesia, pur di fuggire dalla situazione in cui si trovano: «I rohingya sono indifesi e vulnerabili. Per i trafficanti la loro condizione è un affare molto redditizio», spiega il cattolico bengalese George Mithu Gomes, che lavora a Cox’s Bazar con l’ong World Renew. Secondo quanto riportato dalla polizia malaysiana, nei mesi scorsi una banda di trafficanti stava cercando di traghettare cinquecento rohingya sulle coste malaysiane. E l’ong Fortify Rights stima che negli ultimi quattro anni circa 168.000 uomini e donne rohingya sono usciti clandestinamente dallo stato di Rakhine in Myanmar e dai campi di Cox’s Bazar.
Di recente, poi, oltre 1600 rifugiati sono stati trasferiti dalle autorità bengalesi sull’isola di Bhasan Char, nel golfo del Bengala, nell’ambito di un controverso progetto di ricollocamento di centomila rohingya. Il Bangladesh ha investito 400 milioni di dollari per costruire rifugi su una diga alta tre metri sull’isola, spesso spazzata da cicloni e inondazioni. A molti osservatori il trasferimento dei profughi è parsa una vera deportazione, anche se il governo parla di «soluzione su base volontaria».
I rohingya — rimarca Immanuel Chayan, addetto alle comunicazoni di Caritas Bangladesh — «sono un popolo la cui vita è segnata da una serie di situazioni di emergenza: lo sradicamento violento e traumatico dalla loro patria in Myanmar, le emergenze sanitarie come dissenteria e vaiolo nei campi e le ripetute emergenze climatiche che devono affrontare quando i cicloni colpiscono il Bangladesh. A ciò si aggiunge la pandemia». Grazie a una capillare opera di sensibilizzazione della Chiesa bangladese e da una diffusa campagna di appoggio della rete internazionale della Caritas, l’organizzazione si è dedicata a formare personale e volontari attivando programmi di assistenza per i profughi rohingya, istituendo gruppi di ascolto e promuovendo seminari e incontri per diffondere consapevolezza su come affrontare la pandemia. «Dobbiamo lavorare a tutti i livelli — conclude — per alleviare la sofferenza di questi fratelli rohingya. Quello del Natale è stato un tempo favorevole per testimoniare loro l’attenzione e l’amore che Gesù Cristo, il Dio con noi, ci insegna e ci dona».
di Paolo Affatato