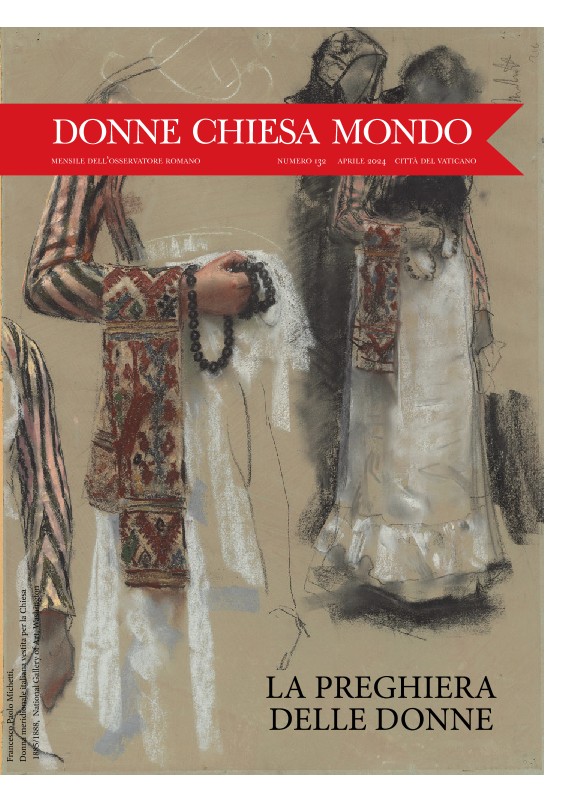In «Chi sbaglia paga» di Sergio Abis
«Subito mi ha colpito la bellezza dei luoghi, vicini ai centri abitati eppure lontani, immersi nel verde e nel silenzio di campi lavorati. Ed è proprio qui, in un posto dove la natura splende, che ho visto e toccato con mano il lavoro di don Ettore, un sacerdote che accompagna i ragazzi suoi ospiti verso la comprensione delle regole».
Così scrive Gherardo Colombo aprendo Chi sbaglia paga (Milano, Chiare Lettere 2020, pagine 220, euro 16,90) in cui Sergio Abis racconta con attenzione e partecipazione l’attività della comunità La Collina. Fondata in Sardegna, nella campagna attorno a Cagliari da don Ettore Cannavera nel 1994, ospita detenuti a cui il magistrato di sorveglianza ha concesso una misura alternativa al carcere. In questa prigione priva di sbarre ma ricca di ulivi, la vita è soprattutto esempio, rigore e ascolto, educazione e legalità, rispetto, bellezza e cultura. «Nella comunità di Serdiana — scrive ancora Colombo — c’è la vita insieme, c’è il lavoro ma, soprattutto, si vedono e sono tangibili i risultati di quel lavoro. Ed è tutto il contrario di ciò che succede in carcere».
Le premesse da fare sono molte. La prima è che il carcere alternativo non significa libertà: che si viva in una comunità, ai domiciliari, in affidamento ai servizi sociali in un luogo protetto, si deve comunque scontare la pena, dovendo seguire le prescrizioni del magistrato di sorveglianza che impone tempi e modi per l’espiazione. Se dunque il carcere alternativo è un carcere a tutti gli effetti, si tratta però di un modello completamente diverso dalla prigione classica non solo nei modi ma, soprattutto e prima ancora, nelle finalità, che sostanzialmente si riducono a voler rieducare davvero. Nei fatti, non a (vuote) parole.
Il punto di partenza per la rivoluzione ideata da don Cannavera è un dato: 7 detenuti su 10 usciti dal carcere delinquono di nuovo. «Ci volevano duecentomila anni e l’appellativo di sapiens — scrive il sacerdote — per inventare una cosa così stupida? Per immaginare un’istituzione che anziché cercare di rieducare i colpevoli di reati e riconciliarli con la società, li immette in un sistema che, nella migliore delle ipotesi, li lascia come sono, ma in realtà li peggiora, ributtandoli a spasso pronti a delinquere?».
Al contrario di altre sofferenze (perché «in prigione si soffre, anche se non tutti allo stesso modo»), quella inflitta dal carcere può apparire meritata come una dura lezione. I numeri, però, sconfessano questa lettura: «Se fosse una lezione — scrive Sergio Abis, che la prigione l’ha vissuta in prima persona — ci dovrebbe essere il relativo imparare, mentre l’ossessivo balletto del continuo ritorno in carcere, il dramma della recidiva dimostra il fallimento della scuola, della lezione e degli insegnanti».
Alla prova dei fatti il carcere risulta in sostanza una forma di assistenzialismo foraggiato (seppur malamente) dallo Stato. «Il recluso non ha impegni lavorativi, non ha orari, può alzarsi quando gli pare e dormire quanto vuole. Non ha obblighi richiesti da un disciplinare rieducativo, salvo la partecipazione ad attività spesso inutili, percepite come mero passatempo. Si dedica all’ascolto di pessime trasmissioni televisive, gioca a calcio le poche volte che sia consentito, si impegna nel body building, in interminabili partite a carte. Di frequente si gioca d’azzardo, si litiga e si dà inizio a risse, ferimenti e faide infinite (…). In galera si fa la fame, se non si hanno i soldi per la spesa; ci si cambia poco, e non si hanno i soldi per i vestiti e il detergente per lavarli; si prendono le botte, ci si ammala e si viene curati con approssimazione; si vive in celle affollate litigando con il vicino di branda se non ama particolarmente la doccia e puzza di selvatico».
Ovviamente tutto questo vale per coloro che non hanno mezzi propri, privi di una famiglia o di una rete che possa fornire tutto ciò di cui in carcere si ha bisogno. È un’altra delle facce dolorose del sistema penitenziario, quella dell’enorme disparità di condizioni tra i detenuti. «Non tutti soffrono la fame, vengono mal curati e prendono le botte. Ci sono detenuti e detenuti, ci sono i forti e i deboli, e questi, i poveri cristi, stanno ovviamente peggio. E sono la maggioranza».
Confermando la marginalizzazione dei detenuti, l’ambiente carcerario si traduce insomma nella spinta a osservare regole che sono l’esatto opposto di un sereno e proficuo vivere comune, deresponsabilizzando il singolo al massimo grado. Nella comunità di don Cannavera è l’esatto contrario.
A La Collina si va a letto presto perché la sveglia è alle 6.30. La prima lezione impartita agli ospiti è che per mangiare bisogna lavorare, non vivacchiare sulla branda dinnanzi alla televisione (in comunità ce n’è una sola per tutti, ed è concessa per pochi minuti al giorno nella sala comune). I ragazzi che seguono il percorso rieducativo devono praticare un mestiere, percepire uno stipendio e imparare a gestire il loro denaro (una quota mensile dello stipendio, infatti, copre i consumi e le spese del vitto). La parola d’ordine, insomma, è responsabilizzazione, ottenuta attraverso l’educazione alla gestione del lavoro, del tempo e del denaro.
Quel che si cerca di fare è qualcosa di estremamente radicale. Si tratta, infatti, di ricostruire personalità abituate all’assenza delle regole comunemente accettate dalla collettività. «I ragazzi incarcerati per i reati commessi, anche gravissimi, non sono cattivi. Non esistono i cattivi — scrive Abis — esistono le circostanze che rendono possibile diventarlo: la mancanza di educazione o peggio un’educazione alla devianza (…). In galera c’è finito il disagio delle periferie, delle famiglie problematiche, dei genitori che trasmettono ai figli i propri problemi. Ci sono i figli di madri prostitute e drogate; di padri violenti e alcolisti; di spacciatori; di carcerati condannati a pene talmente lunghe che non avranno mai la possibilità di incidere sull’educazione dei figli, se non in negativo con la propria assenza. Ragazzi abituati alle regole della strada: come potrebbero essere diversi da ciò che sono?».
Davanti a questa situazione, la risposta — secondo don Cannavera e la sua comunità — non può essere la costrizione: «Bisogna persuaderli, invece, dimostrando nei fatti e con l’esempio — prosegue Abis — che una vita come quella di tutti può essere sì, difficile e faticosa, ma mai come la disgrazia di un’esistenza passata in galera, la morte vivente».
Proprio perché l’esempio è tutto, don Cannavera si è “inventato” la figura dell’operatore di condivisione, l’educatore posto a cardine dell’attività di risocializzazione prevista nei percorsi di recupero della sua comunità. Perché non si tratta tanto e solo di impartire istruzioni, suggerire, imporre ed eventualmente sanzionare, quanto piuttosto di comportarsi per primi secondo il disciplinare previsto: mostrare come si fa. È questo il compito dell’operatore di condivisione: condividere con l’ospite il percorso di recupero. Insegnando, dunque, con l’esempio concreto.
Così, seguendo un modello di vita mai conosciuto prima, il detenuto impara man mano a sentirsi persona circondata da altre persone che insieme a lui cooperano per il suo recupero, in modo da permettergli di rientrare davvero nella società civile. «È — nota ancora Gherardo Colombo — l’unica cosa che conta: la relazione con l’altro e il rispetto delle regole. Si osservano le regole quando si capisce che esiste anche l’altro, in un circolo virtuoso».
Nel libro il progetto di don Cannavera viene presentato attraverso le numerosissime lettere che il sacerdote ha ricevuto negli anni dai detenuti. Parole a volte sgangherate in una prosa in cui tanto dicono le omissioni, le grafie, le palesi falsità, la materialità stessa del supporto utilizzato — buste, francobolli, fogli strappati da quaderni o agende, o locandine utilizzate sul retro. «Tutto è racconto — scrive Abis — tutto è narrazione del proprio stato, del rapporto con la costrizione e della costrizione stessa, della galera, se solo si è capaci di leggerlo. Di ascoltare».
I mittenti non chiedono pietà, quel che chiedono è il riconoscimento della loro dignità, il minimo sindacale per venir considerati esseri umani e cioè: cibo, abiti, il necessario per l’igiene personale, sigarette e, soprattutto, la possibilità di essere ascoltati, di poter comunicare.
«Prima ancora che disumano, perché lo è, oggi il carcere è fondamentalmente stupido. Non serve a niente — scrive don Cannavera — e costa un enorme ammontare di denaro: davvero non si può far di meglio?». Forse si può.
di Silvia Gusmano