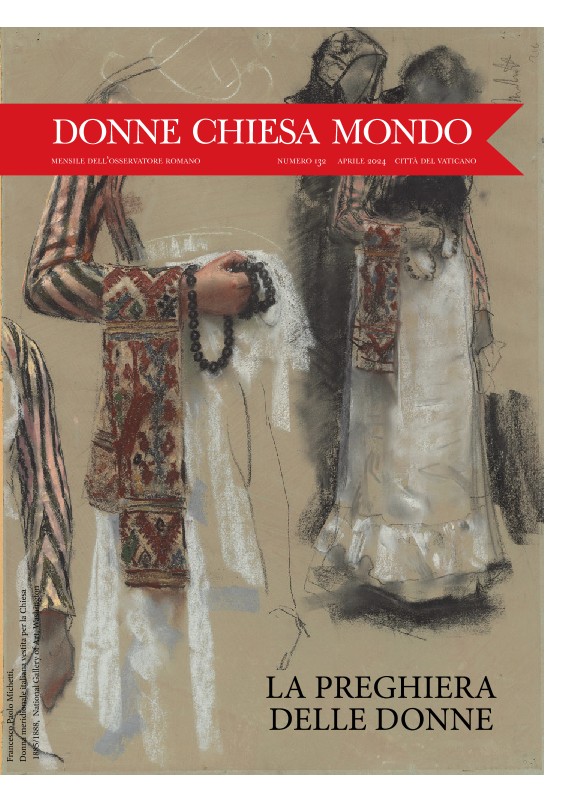In Asia centrale la pandemia non ferma l’evangelizzazione. Le Chiese nelle nazioni dell’ex Unione sovietica, abituate nella loro vita a vivere con umiltà e mitezza il loro stato di “minoranze”, in un tessuto sociale spesso a maggioranza islamica o buddista, sono piccole comunità che vivono il paradigma della loro intrinseca fragilità secondo il versetto di san Paolo «Quando sono debole, è allora che sono forte». L’essere inermi e lo scarso peso economico, politico, sociale, religioso non fanno altro che rimandare alla necessità quotidiana di una grazia che viene dall’alto, dono di Cristo istante per istante, e che fa superare le tentazioni dell’autoreferenzialità e dell’autosufficienza compiaciuta.
È vero che in Uzbekistan il lockdown ha avuto l’effetto di bloccare la procedura di costruzione e registrazione di una nuova parrocchia nella città di Angren, centro dove vive un gruppo di 25 cattolici. La piccola comunità locale — tremila battezzati e cinque parrocchie in tutto il paese — aveva iniziato a raccogliere i documenti necessari per l’apertura ufficiale di un nuova chiesa e di una nuova unità pastorale, ma tutto si è fermato a causa della pandemia, data la chiusura degli uffici amministrativi.
Ma «la cifra di questa attesa è la pazienza, accompagnata dalla preghiera» riferisce a «L’Osservatore Romano» l’amministratore apostolico dell’Uzbekistan, il francescano Jerzy Maculewicz. Lungi dall’arrendersi o dal chiudersi a guscio, un fervente dialogo interreligioso caratterizza la vita dei cattolici nel paese dell’Asia centrale, che promuovono costanti e continui contatti con leader e fedeli di religione islamica, che costituiscono il 90 per cento della popolazione di trenta milioni di abitanti. Soprattutto i sacerdoti più giovani, inoltre, hanno messo in campo i mezzi tecnologici per rimanere in contatto con i fedeli durante il tempo di isolamento, trasmettendo liturgie, momenti di preghiera e incontri biblici su piattaforme online.
Quell’attesa che è sempre vissuta con lo spirito della speranza, una “speranza certa” perché fondata su Dio stesso, caratterizza la Chiesa in Kazakhstan, vasta nazione dove si contano quattro diocesi, per un totale di 70 parrocchie e 91 sacerdoti, tra i quali 61 diocesani e 30 religiosi, su una popolazione di 17 milioni di abitanti, in maggioranza musulmani e al 26 per cento cristiani (tra i quali l’uno per cento cattolici). Negli ultimi giorni si è diffusa negli ambienti ecclesiali una notizia che ha destato una certa preoccupazione: sacerdoti e religiosi missionari, così come tutti gli stranieri presenti sul territorio nazionale, potrebbero riscontrare problemi di permanenza nel paese centroasiatico a causa delle nuove disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, legate al diffondersi del covid-19. Don Guido Trezzani, missionario italiano in Kazakhstan e fondatore del Villaggio dell’Arca a Talgar, nei pressi di Almaty, dove si accolgono bambini orfani, disabili e disagiati, ricorda che «chiunque abbia il visto in scadenza dovrà tornare nel proprio paese di origine e chiederne il rinnovo; ma, al momento sembra che nessuna ambasciata kazaka nel mondo stia concedendo il documento», date le nuove disposizioni legate all’emergenza coronavirus che si fa sentire nelle tre città di Nur-Sultan, Almaty e Karaganda. Le nuove misure di contenimento potrebbero rallentare anche l’inaugurazione di un centro diurno dedicato ai bambini con sindrome di Down, realizzato da Caritas Kazakhstan nella città di Almaty e finanziato dalle autorità locali. Il missionario, però, resta fiducioso e ritiene che «l’apertura sarà solo posticipata», in quanto l’opera è stata fortemente voluta dalla comunità cattolica locale ma anche notevolmente apprezzata dalle autorità e rappresenta un fecondo esempio di partnership tra istituzioni religiose e civili, insieme impegnate per il bene comune del paese.
Fa suo l’invito evangelico a «non temere» padre Giorgio Marengo, missionario della Consolata, di recente nominato da Papa Francesco prefetto apostolico di Ulaanbaatar: «Al di là del blocco delle attività pastorali e sociali — in un paese dove i casi di coronavirus sono comunque decisamente limitati — la missione non è un mestiere, ma un’opera di Dio, una dimensione dello spirito che in qualche modo trasfigura ogni missionario», osserva. Il protagonista di ogni opera missionaria e di ogni annuncio del Vangelo è lo Spirito santo e il blocco forzato imposto dalla pandemia — quando preti, religiosi e laici si trovano costretti all’inattività — può servire a «far riscoprire l’essere al posto del fare, la dimensione interiore piuttosto che quella esteriore», spiega il prefetto apostolico notando che «sono sorte iniziative personali di fedeli e giovani in sostegno alla fede», spesso attraverso i social network. Marengo ricorda l’esperienza di san Paolo che, da prigioniero dice: «Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me», riconoscendo la fioritura della fede in Mongolia, dove è rinata a partire dal 1992 e dove oggi vivono circa 1.300 battezzati, come “dono di Dio” e restituendola al Signore.
Con lo stesso spirito i vescovi dei paesi dell’Asia centrale hanno vissuto i propri esercizi spirituali, nel tempo dell’isolamento e della crisi sanitaria mondiale, in forma personale, ognuno nella propria sede, ma uniti in comunione di preghiera. Racconta il gesuita Anthony Corcoran, amministratore apostolico del Kyrgyzstan: «Abbiamo dovuto annullare l’appuntamento assembleare, ma abbiamo riflettuto e pregato intensamente qui a Bishkek, unendoci spiritualmente a tutti coloro che sono bloccati nelle proprie case o in un letto d’ospedale. Abbiamo seguito gli esercizi spirituali secondo la modalità di sant’Ignazio di Loyola anche attraverso l’uso dell’applicazione Skype, in modo che chiunque potesse unirsi alla preghiera. Vogliamo dire che il coronavirus non avrà l’ultima parola, sarà Gesù Cristo ad averla».
Ne è profondamente convinto anche padre Andrzej Madej, che svolge servizio pastorale in Turkmenistan dal 1997, quando san Giovanni Paolo II istituì la missio sui iuris nel paese, dove oggi esiste una piccola Chiesa costituita da circa 250 fedeli. In una nazione con cinque milioni di abitanti al 90 per cento musulmani, la piccola comunità dei battezzati continua il suo percorso di crescita: quattro persone stanno vivendo un percorso di preparazione ai sacramenti della riconciliazione e della comunione.
La comunità si riunisce, in tempi normali, nella cappella della Trasfigurazione del Signore, nella capitale Ashgabat, guidata da due sacerdoti oblati di Maria Immacolata. «Durante il periodo di dominazione dell’Unione sovietica — racconta il superiore della missio sui iuris — i cattolici sono giunti in terra turkmena da paesi come Polonia, Russia, Ucraina e consideravano la fede il loro valore più grande. Hanno pagato un grande prezzo per proteggerla dall’imposizione dell’ateismo. Oggi però si avverte la difficoltà di trasmetterla ai loro figli. Il paradosso è che è più difficile trasmettere la fede in una situazione di libertà piuttosto che nella repressione. Nonostante ciò, la nostra comunità, seppur lentamente, continua a crescere: se prima battezzavamo solo adulti, da poco il sacramento del battesimo viene ricevuto anche dai bambini», ha precisato.
Il cammino, spiega il religioso, è basato sulla Parola di Dio. «I nostri fedeli sono molto legati alla lettura del Vangelo. Prima dell’emergenza covid-19, gruppi biblici si incontravano per leggere la Parola di Dio sia in cappella che nelle case. Celebriamo ogni giorno l’Eucaristia in lingua russa e la domenica anche in lingua inglese». Negli ultimi tempi, si è fatta strada la necessità di apprendere il turkmeno e «se Dio vorrà, un terzo sacerdote, sempre degli oblati di Maria Immacolata — auspica padre Madej — potrà unirsi a noi e, durante il suo primo anno di permanenza, si dedicherà a studiare la lingua». Anche questo è un segno di “inculturazione” e di immersione in una realtà, perché il seme evangelico piantato possa fiorire e dare frutto.
di Paolo Affatato