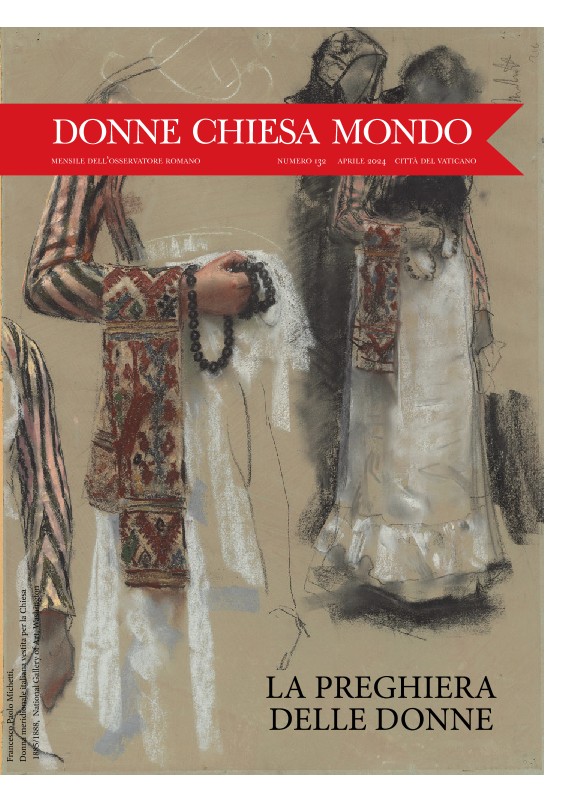Dal nord al sud della penisola la fiduciosa ripartenza delle parrocchie
Com’è cambiato il senso religioso durante la quarantena? Come sarà la Chiesa del dopo covid-19? Continuiamo il nostro viaggio, partendo da Roma verso le realtà ecclesiali di mezza Italia, senza la pretesa di una rappresentazione esaustiva, ma con una serie di fotografie che ci avvicinino alla realtà.
Cominciamo dalla zona più colpita dal virus e dove il mantenimento del legame di comunità è stato oggettivamente più difficile: la Lombardia. Prima ancora che a Codogno, tutto inizia a Castiglione d’Adda, dove è parroco don Gabriele Bernardelli. «Sì, è cominciato tutto qui il 21 febbraio. Siamo stati catapultati nel giro di poche ore in un’atmosfera surreale, strade deserte, tutto chiuso, e così anche le chiese. Quasi subito ci siamo attrezzati a rimanere in contatto come comunità attraverso i social. Poi sono cominciati i decessi. È stata l’esperienza più straziante, come prete e come uomo. Qui, sai, ci conosciamo un po’ tutti e accompagnare da solo al cimitero queste povere vittime è stato terribile. Una scena che mi si è ripetuta settantacinque volte. Confesso che avevo un p0’ paura a parlare di Dio davanti a tanto dolore, invece mi sono accorto che la gente non cercava le “colpe’” ma il conforto di Dio. E lo cercava attraverso me. Ma le parole erano poco più che sibili attraverso le mascherine. Che nascondono anche l’espressione delle emozioni. È nata così quella che poi ho battezzato come “la pastorale degli occhi”. Passavamo lunghi minuti fermi solo a guardarci in silenzio. Ma quante belle parole attraverso quegli sguardi reciproci. Tanta preghiera, ma anche tanta solidarietà in una comunità così duramente colpita. La messa della mattina del Papa ha portato tanto conforto, non gliene saremo mai grati abbastanza. Ora il problema è ripartire. Ma non è un problema tecnico, on line o presenza. È un problema di contenuti. Dobbiamo essere capaci di saper rispondere alle tante ed impellenti domande che ci sono state poste in queste settimane. Domande sul male, sulla morte, su cosa più conta nella vita, sul senso».
Don Franco Gallivanone guida a Milano una parrocchia tra le più grandi dell’arcidiocesi in cui risiedono anche molti musulmani. «Domenica scorsa alla ripresa delle messe, c’era un’atmosfera ambivalente: da un lato la contentezza del ritrovarsi, ma dall’altro anche una certa fatica a parlarsi, anche solo a salutarsi. Ho parlato con molti miei parrocchiani, in tanti è emersa una forte tensione all’essenziale. Ciò che è veramente essenziale nella vita, ma anche ciò che è essenziale nella fede. In tanti hanno riscoperto la centralità della Parola. Parola letta, meditata, ma anche abitata e vissuta. E nella fascia più matura anche una più profonda consapevolezza del ruolo del laico nella dimensione del sacerdozio battesimale. Il digiuno sacramentale ha fatto di necessità virtù. E poi oltre la paura e la malattia, la dimensione sociale della crisi. Non parlo solo di chi ha perso il lavoro ma anche di chi soltanto era impossibilitato ad andare a lavorare: ci siamo accorti di come il lavoro identifichi molto la persona. Senza il lavoro subentra spesso uno smarrimento dell’identità. Il centro però dei nostri contatti, che non sono mai venuti meno nei tre mesi, ha riguardato il tema del dolore. È il tema che ci ha fatto maggiormente crescere come comunità: nell’impossibilità di svolgere i funerali abbiamo dovuto ricostruire insieme con tutti i parrocchiani la lista dei deceduti, una partecipazione corale al dolore di ogni famiglia. Io penso che la pastorale in questi mesi se ha forse perso in quantità ha certo guadagnato in qualità. E ha sviluppato una creatività inusitata. Per esempio ci siamo inventati alla sera i rosari itineranti lungo i santuari del mondo: un modo per pregare ma anche per vincere la costrizione a casa. Questa idea del miglioramento nella qualità ha riguardato anche noi preti, ho fatto diversi incontri di decanato in cui è emersa la percezione diffusa di una riqualificazione del ruolo del sacerdote».
Benedetta Cerasoli è una giovane medico geriatra che partecipa ad una comunità spirituale condotta a Milano da padri gesuiti. Prestava servizio al Pio Albergo Trivulzio all’esplodere della pandemia, ma è stata tra i primi ad ammalarsi e ha lasciato l’istituto quando c’era maggior bisogno di lei. «Ci siamo adoperate tra medici a non lasciare da solo nessuno — spiega — e a garantire qualche informazione con l’esterno. Non riesco a togliermi dalla testa una frase di una mia collega, l’ultimo giorno “Sarai utile anche da casa, perché qui la cosa più importante che c’è da fare ormai è pregare”. Abbiamo sempre mantenuto i nostri contatti come comunità, ma devo dire che questo periodo di silenzio, solitudine e preghiera mi è stato comunque molto utile. È vero che l’Eucaristia è il centro della vita di noi cristiani, ma in questo tempo ho imparato a incontrare il Signore, attraverso la Parola, in un’intimità che non avevo sperimentato in passato. Temevo di non saper vivere il triduo pasquale come gli anni passati, e invece mai mi sono sentita così unita all’Uomo della croce del Venerdì santo. Penso che dovremo ricominciare dal senso di comunità, il cui bisogno in questo tempo è cresciuto molto».
Ci spostiamo nel centro del cratere, a Bergamo. Don Giulio Albani, 50 anni, è parroco a Mozzo, appena fuori città. «Non ci sono altri numeri, oltre quelli già noti, per spiegare che quella che si è abbattuta qui è stata una tragedia immane: migliaia di morti. Io all’inizio ho cercato di non perdere la bussola ponendomi una sola domanda: cosa vuole il Signore da noi in questo cataclisma? E la risposta che ho sentito è stata: “Ascolta!”. C’era, ed in effetti ancora c’è, tanto bisogno di ascolto. Ascolto del dolore, della paura, della sofferenza. Ancora oggi registro un compulsivo bisogno di parlare, di raccontare e raccontarsi. Fiumi di parole da una gente che è nota in genere per la sua discrezione e riservatezza. E la prima e più importante forma di carità è proprio l’ascolto. È quello che più mi sono sforzato di fare in questo tempo, in cui pur con tante difficoltà siamo sempre rimasti in contatto tra noi. Non solo il conforto ai malati, ma anche tanto supporto ai sopravvissuti con i tanti sensi di colpa che affiorano in questi casi. Nella mia parrocchia risiedono tanti medici ed infermieri, e Dio sa di quanto sostegno abbiano avuto bisogno in questo tempo: tornavano a fine turno distrutti nel corpo e nello spirito per quello che avevano visto e vissuto in ospedale. Ora ci stiamo preparando lentamente a tornare alla vita, per la festa del Corpus Domini e per il nostro patrono san Giovanni Battista, abbiamo costruito fuori della chiesa una tenda: è il segno di un popolo che attraversa il deserto per rincontrare il suo Dio».
All’esterno della parrocchia di don Giulio incontriamo suor Marina Motta, insegnante e teologa, superiora in Italia delle suore del Bambino Gesù. «È presto per dire come saremo, più facile dire come vorremmo essere. Oltre l’ascolto che giustamente reclama don Giulio, credo debba esserci la nostra pervicace volontà di essere testimoni del Cristo Risorto. Dove la morte semina paura non può esserci altra risposta che Colui che vince la morte. Penso che dobbiamo saper declinare in parole semplici e buone semplicemente questo. Che altro non è poi che l’essenza della nostra fede. Dobbiamo dare spazio e favorire tutto ciò che è Vita, contro le paure e le angosce».
Ritorna sempre tra tutti gli interlocutori che incontriamo il tema dell’essenzialità della vita e del kerigma. Rimaniamo ancora a Bergamo. Don Massimo Maffioletti è il brillante parroco della Beata Vergine Immacolata. «Cerco di vedere le cose in positivo. Molte persone non hanno sprecato questo tempo. La Parola ci ha attraversato mediante il silenzio e la solitudine forzati. Ho cercato di aiutare questa penetrazione della Parola attraverso la distribuzione alle famiglie di un sussidio per la preghiera domestica. Non ho voluto celebrare on line. Le messe del Papa erano bellissime, i mie parrocchiani le seguivano e vi trovavano grande conforto. Piuttosto ho usato il web per cercare di comprendere, di capire, tutti insieme, le tante domande di senso che sono affiorate in questo tempo drammatico. Ci credevamo “post-mortali” e ci siamo trovati sbattuta in faccia l’ineluttabilità della morte fisica, e questo proprio durante il periodo pasquale. Non ci sono state solo perdite, c’è stato anche un grande guadagno sapienziale. Ho incontrato, nei limiti concessi, tanta gente nuova, presa nell’intimo da queste domande. Anche perché chi aveva già una qualche fragilità proprio in questo periodo se l’è vista esplodere. Per noi preti è stato un periodo di grande discernimento, chi affidava al proprio ruolo soprattutto una funzione sacramentale ha dovuto ripensarsi. Credo che dobbiamo ripartire da qui, dal cammino nel deserto, non dalle nostre sicurezze».
Uno che il suo ruolo se lo è visto giocoforza stravolto è don Claudio Del Monte. Uscito temporaneamente dal suo ruolo di parroco per vestire i panni del cappellano nell’ospedale covid Humanitas Gavazzeni. «Il cappellano dell’ospedale era troppo anziano per affrontare questa emergenza così mi sono offerto al vescovo di svolgere il suo ruolo, visto che avevo meno impegni nella mia parrocchia. È stata un’esperienza, superfluo dirlo, che mi ha cambiato la vita. I medici e lo staff sanitario sono stati molto collaborativi, potevo entrare ovunque, anche in terapia intensiva. Non potevo dare la comunione, né gli oli sacri, né ascoltare confessioni, ma avevo una croce sulla mia tuta sterile dalla quale capivano che ero un sacerdote, e questo, vedevo dagli occhi, già dava conforto».
Era però possibile impartire l’assoluzione. «Facevo da tramite con i parenti che rimanevano fuori — aggiunge don Claudio — e con i parroci che mi chiedevano di assistere i loro parrocchiani ricoverati. Uscivo che ero esausto perché stare ore con tuta, doppi guanti, scafandro e mascherina non è proprio agevole, ma soprattutto psicologicamente perché ogni giorno accompagnavo a morire tante persone. E poi cercavo di sostenere i tanti medici ed operatori sanitari che avevano crolli emotivi per la situazione di tragedia che vivevano. Quando non ero presente, ci pensavano gli infermieri ad impartire l’ultima benedizione, sulla base di un’autorizzazione che aveva dato loro il vescovo. C’è una cosa importante che voglio dire proprio a “L’Osservatore Romano”. La mia esperienza è stata possibile perché al Gavazzeni sono stati disponibili ad accogliermi fin dall’inizio. Ma in molte altre situazioni ospedaliere le risposte erano “non ci servite”, “intralciate il lavoro”, “è troppo pericoloso”. Ora, la Cei ha intavolato negoziazioni sulla ripresa delle messe: posso proporre, da soldato semplice in trincea, che ci si preoccupi anche di garantire l’accesso ai cappellani negli ospedali, fatte salve le condizioni di agibilità? Dio non voglia, ma se in autunno dovesse ritornare l’epidemia…».
Da dove ripartire ora? «Io credo che almeno per noi — continua il sacerdote — si possa ripartire da questa mia esperienza. Voglio dire, il mio intervento in ospedale in quei giorni non è stato solo personale, c’era tutta la comunità alle mie spalle. Per esempio i volontari che sostenevano le famiglie dei ricoverati con cui entravo in contatto. Questo significa che possiamo ripartire da questo straordinario afflato di solidarietà e carità che è il vero cemento delle comunità».
Ma come sono andate le cose nel centro-sud assai meno colpito dalla malattia, ma forse più segnato nelle condizioni economico-sociali? Voliamo a Napoli, dove incontriamo don Francesco Piccirillo, parroco e responsabile della catechesi per la diocesi, il quale non ha dubbi: «Dobbiamo ripartire dalla speranza. Che è la nostra nota caratteristica. Come può darsi un cristiano senza speranza? Anche quando sembra improponibile dobbiamo ravvivare la speranza, abitare con speranza il nostro tempo. Mi piace ricordare in questo frangente la definizione di speranza che dava il poeta e politico boemo Václav Havel: “La speranza non è ottimismo ma la certezza che una data cosa ha un senso indipendentemente da come andrà a finire”. Vincere la paura. Anche se i numeri possono sembrarci scoraggianti, il cristiano deve saper vivere da straniero nella sua stessa terra, dando sempre ragione della propria fede. In realtà vedo anche molte relazioni che si sono riallacciate: questo dramma sta imponendo quella profezia della “Chiesa in uscita” che spesso stentava a decollare. Certo, questi “ritorni” pongono domande diverse e nuove: dovremo ripensare a fondo la nostra pastorale».
Qualcuno già ci prova. Don Francesco Piciocco è il vivace viceparroco di San Michele Arcangelo ad Andria, in Puglia. «La nuova medialità — afferma — non è solo tecnica, ma richiede anche un linguaggio diverso, e contenuti diretti, essenziali. Con i nostri ragazzini abbiamo prodotto dei materiali on line nella forma dei cartoons, abbiamo celebrato un triduo pasquale interattivo, che implicava preparare il pane a casa il giovedì, lavarsi reciprocamente i piedi, porre la Croce al centro della casa il venerdì. Certo con gli anziani si fa molta più fatica, per loro religione significa tradizione, e ora mancano dalla chiesa per paura. Dobbiamo riuscire a sedimentare la marea di contatti che abbiamo avuto sui social. Tutti sono stati toccati nel profondo. Anche io. È stata un’esperienza unica nella vita quando mi sono trovato a celebrare un funerale al cimitero, completamente da solo. C’è un grande ritorno alla sobrietà nel vivere. E anche nei fatti religiosi: abbiamo saltato cresime e prime comunioni che faremo in autunno, ma i genitori hanno già detto che non saranno feste pompose con pranzi e regali, come qui si usa, ma solo segni condivisi della grazia di Dio. Comunque ci aspetta un lavoro immane: è finito il tempo per noi preti che si andava in automatico: ci vorrà tanta energia e anche creatività».
Don Benito Giorgetta, parroco di San Timoteo a Termoli, dice schietto: «Non è più tempo per quella che io chiamo “l’abulimia del fatto religioso”. La sobrietà spirituale che tutti abbiamo vissuto in questo periodo può essere il veicolo per una fede più consapevole e matura. Alla fine, come diceva l’apostolo, tutto concorre al bene per chi teme Dio. Lo dico pensando soprattutto al senso di limitatezza e quindi di creaturalità che il covid-19 ha indotto in tanti di noi. A chi tra qualche parrocchiano insisteva sul “bisogno” di Eucaristia ho spiegato che non venire a messa in questo tempo era in effetti un atto d’amore, e tutti hanno capito e condiviso. La messa quotidiana del Papa è stata un balsamo, ci è perfino dispiaciuto quando hanno smesso di trasmetterla. Domenica scorsa ho esordito alla prima messa dicendo: “Bentornati a casa! Perché questa è la casa del Signore, e noi siamo suo corpo mistico, quindi è casa nostra”».
In Calabria l’aspetto della pietà popolare e della devozione, molto legata alle tradizioni locali, è molto vivo «e non va mortificato o snobbato — dichiara padre Francesco Lanzillotta, della diocesi di Crotone — piuttosto questa fase è stata utile perché questo senso della ritualità si purificasse e ne venissero accantonati quegli elementi di folklore e tradizione che spesso ne occultano il significato autentico. Anche in ragione di questo carattere particolare i contatti on line possono funzionare per le catechesi ma non altrettanto per le messe e le celebrazioni. Per noi sacerdoti e consacrati è stata una formidabile occasione per vivere più intensamente la fraternità, e mettere a fattor comune il senso delle rispettive vocazioni. Questo è un dono su cui di certo non torneremo indietro anche dopo il covid-19».
Riprendiamo la strada del nord, verso la Toscana, e proviamo a riannodare le fila di tutte queste fotografie attraverso lo sguardo d’orizzonte di un pastore saggio, l’arcivescovo di Siena - Colle di Val d’Elsa - Montalcino, Augusto Paolo Lojudice. «Credo che la parola più giusta — osserva il presule — l’abbia pronunciata Papa Francesco domenica scorsa quando ha detto che c’è una cosa sola peggiore di questa crisi: sprecare le occasioni di ripensamento e conversione che pur ci ha dato. Sprecarle significa: incedere nell’autoreferenzialità, nella presunzione assoluta delle proprie convinzioni o alternativamente nel vittimismo, o nel narcisismo. Scordando quelle che credo siano le due lezioni principali di questo tempo: la nostra piccolezza, e l’impossibilità del vivere e salvarsi da soli. Io penso al tempo stesso che sia ancora presto per capire come cambierà la Chiesa dopo la pandemia, ma è anche abbastanza certo che cambierà. Perché il sommovimento delle anime è stato profondo. Mi limito a tre osservazioni. La prima: questa crisi forza il cambiamento. Su tanti piani, pur ben individuati ormai 55 anni fa, il nostro rullino di marcia andava a rilento. La sospensione del tempo, il silenzio, l’isolamento con la conseguente responsabilizzazione individuale di ogni cristiano che questo evento ha comportato hanno fatto saltare tanti meccanismi di difesa individuali e collettivi. Se, e anch’io lo credo, la cifra di questo tempo, come dicono tutti i suoi intervistati, è nella parola “essenziale”, non c’è più spazio per giri di parole. C’è un mondo interpellato da questa vicenda, e che ora interpella noi».
di Roberto Cetera