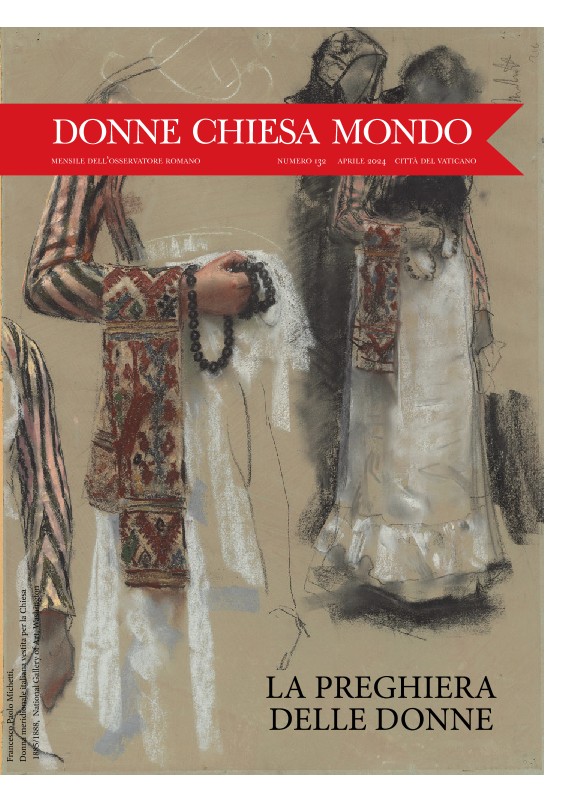Alcuni ricorderanno che vi è stata nel passato una stagione in cui l’Africa era spesso in prima pagina sui giornali. Sicuramente più di oggi. Erano gli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, in cui le grandi testate internazionali riportavano in apertura, ad esempio, le cronache della prima indipendenza del continente, quella del Ghana con i proclami panafricanisti di Kwame N’Krumah; i resoconti sulla guerra civile in Congo, con il tentativo, soffocato in un bagno inverecondo di sangue, del giovane leader Patrice Lumumba di coinvolgere le Nazioni Unite e la conseguente morte del suo segretario generale, Dag Hammarskjöld. Per non parlare della guerra civile algerina e dei suoi effetti sul clima politico francese d’allora, col crollo della iv Repubblica, il ritorno del generale Charles De Gaulle al potere e l’avvento della v Repubblica. E cosa dire della nazionalizzazione del Canale di Suez da parte del panarabista Gamal Abdel Nasser, metafora delle istanze di liberazione, non solo dell’Africa, ma dell’allora Terzo mondo? D’altronde, era evidente che il cosiddetto processo di decolonizzazione africano, avviato alla fine della seconda guerra mondiale, sarebbe stato irrefrenabile, almeno dal punto di vista statuale.
Tutto questo, peraltro, mentre nel Vecchio continente germinava l’ideale di un’Europa unita che allora era costituita dal puzzle geopolitico proprio di quelle potenze colonialiste, le più colpite dalle nuove dinamiche terzomondiali.
Ma l’apogeo di questo processo di decolonizzazione avvenne sessanta anni fa, nel 1960, con l’indipendenza di possedimenti francesi, britannici, belgi e italiani, 17 Stati in tutto, ammessi senza indugi alle Nazioni Unite con la sola eccezione della Mauritania, che scontò il contenzioso aperto dal progetto del Grande Marocco. Stando alle cronache e ai resoconti del tempo, l’Africa veniva da un decennio di crescita e sviluppo economico e l’ottimismo era di rigore, soprattutto nei circoli intellettuali che anelavano al riscatto. E fu proprio sotto il soffio impetuoso del “vento del cambiamento” (Wind of change), come disse l’allora premier britannico Harold Macmillan intervenendo al parlamento di Città del Capo in un Sud Africa — in quel frangente ancora sotto il giogo ignobile dell’apartheid — che vastissime regioni del continente — ricche di inestimabili risorse naturali e abitate da popolazioni in rapida crescita — si avvicinassero a nuove possibilità di sviluppo.
L’impulso fondamentale veniva dalla domanda di libertà dei popoli colonizzati e anzitutto delle nuove classi dirigenti di idee nazionaliste che si erano formate alla scuola del pensiero occidentale; tutti personaggi che si trovavano a loro agio, formalmente, con gli istituti politici e amministrativi introdotti dalle potenze europee, spesso in extremis e mai veramente collaudati. E dire che proprio coloro che più di altri avevano sognato la fine del colonialismo, credevano fermamente nel panafricanesimo.
È sufficiente leggere Africa Must Unite, pubblicato da N’Krumah nel 1963: «Abbiamo bisogno di una base politica comune per l’integrazione delle nostre politiche di programmazione economica, di difesa delle relazioni estere e diplomatiche. Questa base di azione politica non richiede la violazione dell’essenza della sovranità dei singoli Stati africani. Questi Stati continueranno ad esercitare una autorità indipendente, ad eccezione di settori definiti e riservati all’azione comune, nell’interesse della sicurezza e dell’ordinato sviluppo dell’intero continente».
Allorché si presentò la storica opportunità della Conferenza di Addis Abeba nel 1963, i capi di Stato e di governo africani, dopo una lunga discussione, nel corso della quale emersero idee contrapposte, sancirono, come base della nuova unità, il principio del «rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale dello Stato» (in altre parole nessuno poteva interferire negli affari interni di un Paese, anche in caso di colpi di Stato o dittature), nonché quello dell’«intangibilità delle frontiere» ereditate dal colonialismo, cioè lo status quo!
Nacque così, segnata da una sorta di peccato originale, l’Organizzazione dell’Unità africana (Oua). Riguardo alla non ingerenza, la nascita dell’Unione africana (2002) ha certamente rappresentato un superamento, almeno in linea di principio, di questo assioma, mentre sulla questione dei confini l’orientamento è sempre incentrato sul mantenimento della geografia coloniale, nonostante vi siano già due precedenti: la secessione dell’Eritrea dall’Etiopia (1993) e successivamente quella del Sud Sudan dal Sudan (2011).
Una cosa è certa: sono trascorsi sessant’anni di Storia dalla fine del potere coloniale in Africa: decenni indubbiamente complessi, forse anche più di quanto ci si attendesse. Molte cose sono cambiate tra strategie di sviluppo e risultati concreti; traiettorie nazionali e processi di integrazione regionale; sviluppo, crescita e innovazione. Anche se poi, dopo la fine della guerra fredda e delle nuove fasi del capitalismo internazionale, la luce mediatica, ed anche analitica, su vasti segmenti del continente si sono spente, relegando intere regioni ad un ruolo nuovamente marginale e subalterno.
Il fatto che ancora oggi si parli di guerre dimenticate a quelle latitudini, dalla Somalia alle regioni orientali dell’ex Zaire, passando per il Sud Sudan, la dice lunga. Una storia dunque fatta anche di pesanti ingerenze esterne, conflitti e colpi di Stato. E sulla progressiva nascita dei processi di vera e propria ricolonizzazione in Africa, fino ai giorni nostri, è illuminante il pensiero di uno dei più grandi africanisti italiani, Gianpaolo Calchi Novati, il quale fu tra i primi a denunciare gli effetti sul continente della cosiddetta “biopolitica” con i suoi dispositivi più avanzati di dominio e spoliazione delle risorse naturali, desertificazione e contaminazione dei processi democratici e partecipativi.
A ciò occorre aggiungere, per dovere di cronaca, l’attuale pandemia del covid-19 che rappresenta per l’Africa un fattore altamente destabilizzante, non solo perché ha evidenziato la debolezza del sistema sanitario continentale, ma soprattutto per i suoi drammatici effetti sociali ed economici. Il crollo del turismo e delle esportazioni conseguenti alla chiusura delle frontiere, la volatilità sulle piazze finanziarie internazionali del prezzo delle commodity (materie prime), petrolio in primis, hanno messo in ginocchio molti Paesi. Il rischio, sempre in agguato, è che possano affievolirsi le prerogative della sovranità, proprio laddove è più evidente l’esclusione sociale.
In questo scenario, sebbene oggi, come negli anni Sessanta, il panafricanismo sia ancora un progetto in fieri, appare sempre più evidente che occorre riaffermare una solidarietà nei confronti dell’Africa a tutto campo: ad intra e ad extra.Per dirla con le parole di Léopolod Sedar Senghor: «La vera cultura è mettere radici e sradicarsi. Mettere radici nel più profondo della terra natia. Nella sua eredità spirituale. Ma è anche sradicarsi e cioè aprirsi alla pioggia e al sole, ai fecondi apporti delle civiltà straniere…». Una cooperazione che nel mondo “villaggio globale”, soprattutto in tempi di crisi, vale per tutti.
di Giulio Albanese