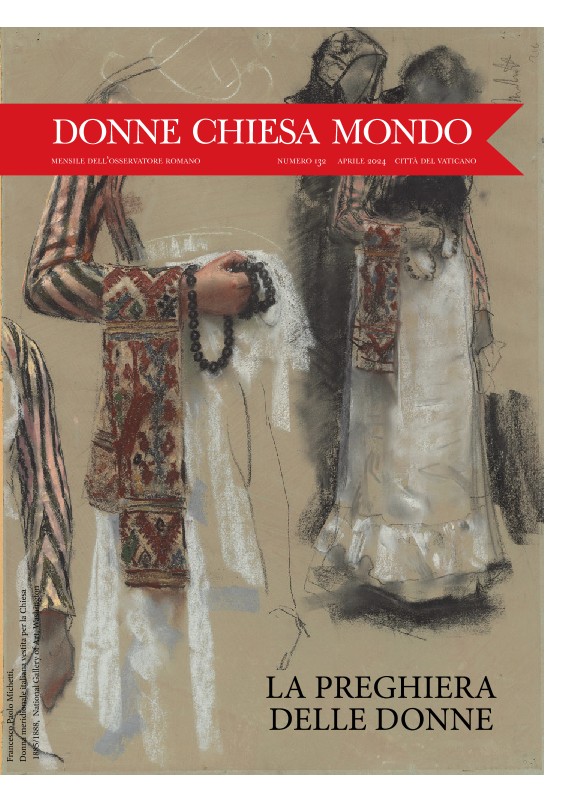122 partecipanti, 23 nazionalità, 18 congregazioni religiose, decine di ore di lezioni on line e due corsi di auto aiuto: sono i numeri dell’iniziativa promossa dalla Pontificia Università Antonianum all’interno del progetto di Humanitarian Care per sostenere persone, religiose e non, vittime e protagoniste della lotta al covid-19. Hanno partecipato suore medici, infermiere, comunque coinvolte in un lavoro di corsia, che le ha viste lavorare attivamente con le mascherine e con i presidi protettivi dei reparti covid. Il senso, la sofferenza, il post lockdown, l’incertezza nel futuro, l’impatto sulle relazioni sociali, un sostegno più focalizzato a singole congregazioni, e il tentativo di narrare una storia diversa di speranza sono i temi che hanno caratterizzato le lezioni e gli incontri che si chiuderanno nella prima decina di giugno. Pubblichiamo ampli stralci dal testo della lezione finale.
In questa fase dell’emergenza covid-19, centrale si dimostra il passaggio dalla crisi sanitaria alla crisi economico sociale. È in questo nuovo contesto che vediamo imporsi, prepotentemente, il tema della leadership. Essa diventa ora di primaria importanza sia sul livello domestico, famigliare, sia sul piano comunitario, oltre che su quello civile e politico. Si tratta, certamente, di una leadership da inventare, in vista della ricostruzione di un mondo, che gradualmente cerca di uscire dalla crisi pandemica. Una leadership di questo genere, è evidente, non può che essere una leadership improntata alla cura.
E intendiamo per cura non soltanto l’attitudine finalizzata alla guarigione, bensì quella premura capace di ritessere relazioni ferite dal distanziamento, dettato spesso dalla paura, talvolta dal rispetto per l’incolumità altrui, oppure, ma più raramente, dalla responsabilità sociale in vista del bene comune. La stessa pandemia, d’altronde, è nata da una mancanza di cura, cioè di premura nel coltivare la differenza ambientale e sociale. È, infatti, il degrado della biodiversità, esito di una globalizzazione uniformizzante, ad avere provocato l’attuale crisi sanitaria: l’invasione degli ecosistemi faunistici, da parte di una urbanizzazione industriale, ha prodotto quell’intensificazione dei contatti tra esseri umani e animali selvaggi, che ha favorito i fenomeni di spillover, causa della pandemia. La biodiversità ambientale non si dimostra però indipendente da quella sociale, in quanto la fine degli ecosistemi influisce sulla vita e la cultura della comunità locali, alterandone l’equilibrio socio-economico.
In senso generale, la stessa crisi dei processi democratici, alteranti gli equilibri politici, economici e ambientali, registra il fatto che non si è curato a sufficienza lo sviluppo della differenziazione sociale, che favorisce lo sviluppo della persona, intesa come singolarità relazionale in cammino verso la realizzazione della propria originalità.
Se lo sviluppo della singolarità della persona, a garanzia della differenziazione sociale e ambientale, deve essere la preoccupazione principale di questa fase di ricostruzione, la cura richiesta in questo frangente deve allora abbandonare ogni ricorso al potere, al dominio, al dirigismo, per avvalersi invece di uno stile di accompagnamento. La cura non può essere che un accompagnamento, che si fa accanto all’altro, praticando una etica dell’ospitalità. Proprio guardando a una catastrofe, che aveva colpito direttamente la natura e solo secondariamente la società civile, cioè una tempesta che aveva distrutto una foresta della Bretagna, André Fossion, scopre una conferma alla sua idea di evangelizzazione come accompagnamento. La foresta, infatti, già a pochi mesi dal trauma della distruzione cominciava a riprendersi e a produrre i primi germogli, tanto che l’équipe deputata a ideare un progetto di riforestazione aveva ritenuto di dover rinunciare a ogni pianificazione, per sostenere invece il percorso creativo, intrapreso spontaneamente dalla natura stessa.
Anche Gilles Clément, ideatore del terzo giardino, delinea la figura di un giardiniere che asseconda l’intraprendenza della natura, in modo da far fiorire un giardino che sia un misto tra arte umana e impeto, fantasia del genio naturale. L’ideatore del terzo paesaggio, ritiene che, dopo il primo giardino, quello incontaminato della creazione, e il secondo, quello prodotto dall’imprenditoria umana, se ne debba concepire un terzo, che sia l’intersezione tra i primi due. Anche Pistoletto con il terzo paradiso, allestito nel bosco di san Francesco ad Assisi, mira a rappresentare il medesimo concetto di intreccio tra spontaneità naturale e artefatto umano.
Nella costruzione del nuovo paesaggio, della nuova città, della nuova società, della nuova economia, delle nuove comunità e delle nuove relazioni, occorre quindi ospitare la natura, assegnare alla natura il posto che gli spetta. È necessario, anzi, prendere lezioni da essa, farsi ospitare, tornando a vivere l’ospitalità sperimentata all’alba dei tempi, quando millenni di storia naturale hanno costruito la casa comune, la dimora ideata su misura, per noi inquilini maldestri. Se siamo per natura ospiti, perché così siamo nati, allora la leadership richiede una cura nello stile dell’ospitalità; richiede un accompagnamento, secondo i canoni dell’ospitalità, offerta e ricevuta.
Osserviamo però ancora che a questa stagione pandemica, dove il grido della terra sembra aver sovrastato il grido dei poveri, siamo giunti, dopo aver attraversato la stagione migratoria, in cui abbiamo tentato, spesso senza successo, di esercitare l’ospitalità. Il mancato esito positivo è imputabile non solo all’incapacità di offrire ospitalità mediante adeguate politiche di accoglienza, ma anche al fatto di essersi limitati a offrire un’ospitalità assistenzialistica, senza cogliere l’opportunità di un ospite che, bussando alla nostra porta, ci offriva l’occasione di cambiare sguardo, di ripensare la nostra residenza, in breve di un ospite che avrebbe potuto guarire la nostra autoreferenzialità, dislocandoci! Un’identità dislocata avrebbe potuto permetterci di generare una nuova società civile, nuove relazioni, nuova economia... avrebbe potuto, forse, evitare anche questo secondo grido, quello della natura?
Ora, dopo la pandemia, anzi in parte ancora avviluppati in essa, sarà possibile recuperare uno stile ospitale, per ridefinire le nostre relazioni e la nostra leadership? Ripartendo dall’ospitalità, con nuova consapevolezza, più drammatica, quella della necessità e urgenza della cura, sarà possibile introdurci con maggiore maturità e determinazione nella via del dislocamento? Gilles Clément direbbe di lasciarci dislocare dalla natura incolta, che produce cose sorprendenti, inimmaginabili, nuove possibilità, nuove strategie.
La sua proposta non differisce, in verità, dalla visione del giardino delle erbe incolte, patrimonio della tradizione francescana. Sull’ideale minoritico del rifiuto della proprietà e del dominio sulle cose, Tommaso da Celano, rielabora il concetto tradizionale di giardino sigillato della cultura monastica. Francesco proporrebbe un giardino senza palizzate, aperto a tutti e soprattutto libero da una coltivazione pianificata, cioè uno spazio riservato alle erbe incolte, posto sul liminare dell’orto conventuale. Esso diventa specchio nel quale contemplare la bellezza, intesa come differenza, come complessità e perfino come disordine, bellezza come fonte di sorpresa per la novità di specie, che l’essere umano non sarebbe mai capace di coltivare e, infine, bellezza come movimento, perché arricchita da continue trasformazioni, con essenze che corrono da una parte all’altra dello spazio, disegnando sempre nuovi tracciati. Tanto per Francesco, quanto soprattutto per Clément, si tratta di una proposta sociale, politica, prototipo di una società plurale, creativa, armonica nella differenza delle singolarità.
Per Francesco si tratta inoltre di una visione teologica, in quanto la contemplazione delle orme di Dio nella creazione conduce ad ammirare il suo abbassamento, l’umiltà della sua presenza, che raggiugere ogni singola entità, fino alla più infima. Trascurare anche la minima traccia di Dio nelle cose create, nell’acqua, nell’aria, nei «coloriti fiori et erba», equivale per Francesco a impoverire l’immagine di Dio, a deturpare la sua bellezza, la sua bontà, la sua verità. Per il poeta del Cantico, infatti, Dio è il tutto, presente in tutte le cose: Deus meus et omnia. La cura di ogni singolarità, a cominciare degli esseri vegetali e animali, è per lui, dunque, vera operazione teologica.
La contemplazione di Dio nello stesso verme, perché Cristo stesso si è definito verme e non uomo, permette al Santo di cogliere l’abbassamento di Dio, il suo amore umile, che si fa uno con la nostra fragilità. È solo nell’estasi, generata dalla contemplazione di un Dio che si fa carico della propria fragilità, che Francesco si sente prossimo del fragile, del lebbroso o del verme che sia; prossimo perfino degli uccelli dell’aria, ritenuti nel medioevo simbolo del male, perché indicanti la presenza di carestie e, di conseguenza, di pestilenze. La fragilità della natura e la fragilità dei poveri sono per lui l’epifania di un Dio che si rende fragile per accompagnare la fragilità dell’uomo. Creature e poveri, lebbrosi, sono per Francesco i maestri, gli accompagnatori e, se vogliamo, i leader di una realtà sociale e politica alternativa, quella della fraternità umana universale. Per lui, infatti, Cristo è il fratello che ci conduce alla scoperta del volto di Dio, come Padre.
Se Cristo è il mediatore, la via dell’essere umano verso il Padre, come si afferma nella Regola, nel Cantico, l’opera della mediazione viene affidata alle creature! Sono le creature ad accompagnare l’essere umano, incapace di nominare Dio, alla lode e alla riconciliazione con i fratelli. Sono le creature ad accompagnare l’essere umano alla morte, permettendogli di chiamarla sorella. Anche la creazione, dunque, è modello di accompagnamento e di cura. Lo è, direi, particolarmente, in questa pandemia, grido della natura, manipolata e perfino vilipesa. La natura, rappresentata da Piero della Francesca nell’affresco sulla risurrezione, è l’unica a cogliere la svolta della vittoria sulla morte, annunciata da un Cristo che come una colonna si erge a spartiacque tra vecchio e nuovo mondo. Nella parte sinistra del Cristo, infatti, la natura è sterile, invernale, dalla parte destra invece è feconda, florida, rigogliosa.
È utile notare come l’artista assegni proprio alla natura, al paesaggio, come direbbe Clément, il compito di attualizzare la parola, di annullare le distanze temporali tra l’episodio evangelico e il contesto sociale e politico in cui vive l’artista. Le colline da lui rappresentate sono, infatti, tipiche del paesaggio toscano. L’attualità evidenziata dalla scena naturale svolge poi la funzione di connotare temporalmente lo stesso spazio sociale e politico, in quanto la città dipinta sulla collina di destra, quella della creazione risorta, storicamente Gerusalemme, è possibile interpretarla anche come la Arezzo dell’artista.
La natura quindi attualizza e soprattutto coglie e incarna il messaggio della risurrezione, collocata nella sfera divina, che dà ad essa valenza teologica, mentre sotto la linea orizzontale, tracciata dal lato superiore del sepolcro, i soldati dormono, ignari e ciechi, di fronte all’evento che ha fatto trionfare la vita sulla morte. Cristo ha gli occhi spalancati e ci guarda, attendendo la nostra decisione. Egli, infatti, tiene ancora un piede nel sepolcro, mentre l’altro è posto sopra la pietra tombale, in segno di vittoria. Ci sveglieremo dalla nostra inerzia, dalla nostra incapacità di cogliere il nuovo, la novità per eccellenza? Apriremo gli occhi sul nuovo scenario, sollecitati da una natura che già scoppia di vita? Ci lasceremo accompagnare da una natura che già è passata dalla sterilità alla fecondità, dalla notte dell’inverno al giorno pieno della festa? Riuscirà a svegliarci questo canto di gioia delle creature? La realtà creata è pronta ad ospitarci, come già ospita la città aretina, patria dell’artista; perché ancora indugiamo nella tristezza della rassegnazione, nella nostalgia per il potere delle vecchie armi?
di Giuseppe Buffon