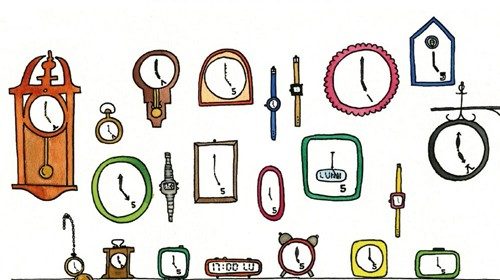
Luca Doninelli (1956) è uno scrittore coerente e prolifico, lo conobbi a metà degli anni Novanta, quando erano da poco usciti La revoca (Garzanti, 1992) e Le decorose memorie (Garzanti, 1994). Della sua scrittura ho sempre amato il fatto che non si limitasse a raccontare, ma che scuotesse. Ha pubblicato saggi, romanzi, reportage. Ha vinto premi (SuperGrinzane, Procida, Selezione Campiello). I suoi ultimi libri sono La dieta sono io (Milano, La nave di Teseo, 2019, pagine 157, euro 17) e L’imitazione di una foglia che cade (Sansepolcro, Aboca Edizioni, 2020, pagine 110, euro 14).
Scrivi racconti e romanzi che hanno l’impianto del racconto morale, ma non è la morale che ti interessa. Che cos’è che ti interessa invece?
Be’, intanto grazie del complimento: dici di me quello che potresti dire di Dostoevskij. Scherzi a parte, cosa m’interessa del romanzo? M’interessa, direi, il romanzo stesso, ossia la sua natura teologica, o metafisica, la sua capacità di presentarsi come un affresco ma di essere qualcosa di più: una ferita sulla superficie del mondo visibile, una coltellata dentro il corpo non visibile della realtà. È così dal Don Chisciotte a Joyce.
Mi sembra che un tema ricorrente nella tua opera sia quello del destino della persona, e del suo succedaneo, l’identità individuale. Nei racconti e nei romanzi, personaggi che si sentono obbligati all’eccezionalità, a una autonomia insostenibile, e, almeno qualche volta, alla fine prendono casa nella “normalità”, in un più umano essere come gli altri, sparire fra gli altri.
Non capisco perfettamente la prima distinzione. E quindi nemmeno la seconda. Accettare la realtà e conoscere sé stessi sono la stessa cosa. Se non è così, è solo finzione. Parlo naturalmente della vita, non della letteratura. Le fisionomie dei miei personaggi nascono dalle diverse situazioni narrative, che impongono anche diversi registri stilistici. Alcuni personaggi — soprattutto nei miei primi romanzi — cercano l’eccezionalità, è vero. Si vogliono estremi, direi per un’istanza estetica: vogliono guardarsi così, vedersi differenti. In ogni caso, io non credo nell’esistenza della normalità. Credo che si possa dire di sì oppure di no alle circostanze della vita, e io ho imparato col tempo il valore del “sì”, che non è uno sparire, ma accettare che perfino la futilità, la routine, il contrattempo abbiano qualcosa a che fare con Dio. Nessuno, che sia veramente qualcuno, sparisce fra gli altri. Spariscono le figure inconsistenti, i custodi del nulla: Verchovenskij de I demoni, Long John Silver ne L’isola del tesoro, il Gatto e la Volpe in Pinocchio. Non so se saprei costruire un personaggio così.
Leggendoti sembra che tu abbia sempre un interlocutore polemico, vale nei saggi come nelle opere narrative. Un’autrice in cui si sente con altrettanta forza è Flannery O’Connor. È vero? Con chi contendi?
Contendo con me stesso. Scrivere per me è come alzarmi in piena notte perché il telefono squilla. Di là c’è una voce autorevole che mi dice: «In piedi, vesti l’uniforme, prendi il fucile ed esci. Vai in fondo alla strada: lì avrai istruzioni». Be’, non si ha sempre voglia di alzarsi. Ma se non ti alzi perdi un pezzo, forse il più importante, di te stesso.
Quello che da sempre mi colpisce nella tua opera è l’intonazione della voce, all’apparenza è una voce trasparente, ma in realtà è al tempo stesso innamorata e piena d’ira, come se te la prendessi con i personaggi, come se li volessi stanare, scuotere. Ti ci ritrovi? La tua voce narrativa la senti cambiata nel tempo?
La voce è una. «Innamorata e piena d’ira»: bellissimo, magari! In ogni caso è un dono. E i doni vanno messi alla prova e non si possono mai dare per scontati. Bisogna sporcarli. Sbagliare è inevitabile. Quando restituiremo il nostro dono, Dio vorrà vederci i segni che vi abbiamo lasciato noi. Questo sarà il suo trofeo.
Nella narrativa per l'infanzia («Tre casi per l’investigatore Wickson Alieni» ha vinto nel 2019 lo Strega giovani) coltivi il comico. Per quale strada ci sei arrivato?
Tutti i libri sono occasioni uniche e preziose. Wickson Alieni è una delle mie cose che amo di più. Amo quel libro perché è vero che l’ho scritto io, ma le idee più belle sono opera dei bambini ai quali raccontavo, improvvisando, le storie di questo personaggio concepito in sogno. Bambini di quattro, cinque, sette anni hanno contribuito in modo fondamentale. Per esempio, Wickson è invisibile perché è «sempre un po’ più a destra»: bene, devo questa idea, pari pari come te l’ho detta, a un bambino di quattro anni. Una bambina di cinque anni, che faceva parte del gruppo, è diventata poi, da grande, l’illustratrice del libro.
Nel 2015 per parlare del presente scrivi la quasi distopia «Le cose semplici». È un libro che oggi risulta attualissimo. Perché hai sentito la necessità di forzare, di spostarti — tanto così — dal presente di allora?
Da tanto tempo volevo scrivere una storia d’amore. Ma ha ragione Manzoni: l’amore è la più straordinaria delle imprese, perché per trionfare deve superare l’arroganza del potere, la follia della guerra e tutte le pesti che sfigurano l’uomo, trasformando — come osserva René Girard — i buoni in malvagi, i farabutti in santi. L’amore, per essere raccontato (il racconto è di per sé un trionfo) deve attraversare l’inferno. L’inferno c’è sempre. Ed è sempre un virus. Il mio virus si chiama sfiducia. Ma comunque lo raffiguriamo, l’inferno è un dato di fatto, una circostanza inevitabile. Dante e Manzoni hanno detto le cose come stanno.
Da quando hai cominciato a scrivere, hai mantenuto una conversazione aperta con Testori; lo stimolo che ti dà questa conversazione ininterrotta cambia nel tempo?
A volte lo odio. Non è esistito sulla faccia della terra uno scrittore più lontano da me. Però il mio maestro è stato lui. È come il padre e la madre carnali. Buoni o cattivi, sono loro. Certo, l’odio irrazionale che provo per i rapporti di potere, un certo anarchismo, la mia difficoltà di adattamento in qualsiasi clima culturale sono regali di Giovanni. Lui però sapeva trarne vantaggio. Io invece ho bisogno di condizioni svantaggiose.
Milano è centrale nella tua formazione e nella tua opera. Come vivi a Milano, di questi tempi?
A parte il fatto che, in questi giorni, più che a Milano sto a casa mia, io amo Milano. E amare Milano vuol dire, almeno secondo me, cercare sempre di capirla, non darla per scontata, perché Milano è una città difficile, che a volte si dà un’immagine, questo è vero (capitale morale, capitale della moda e del design, città-stato, capitale del Sud Europa, Milano da bere eccetera) ma l’immagine è sempre soltanto un vestito che ricopre una natura scivolosa e pericolosa.
di Carola Susani









