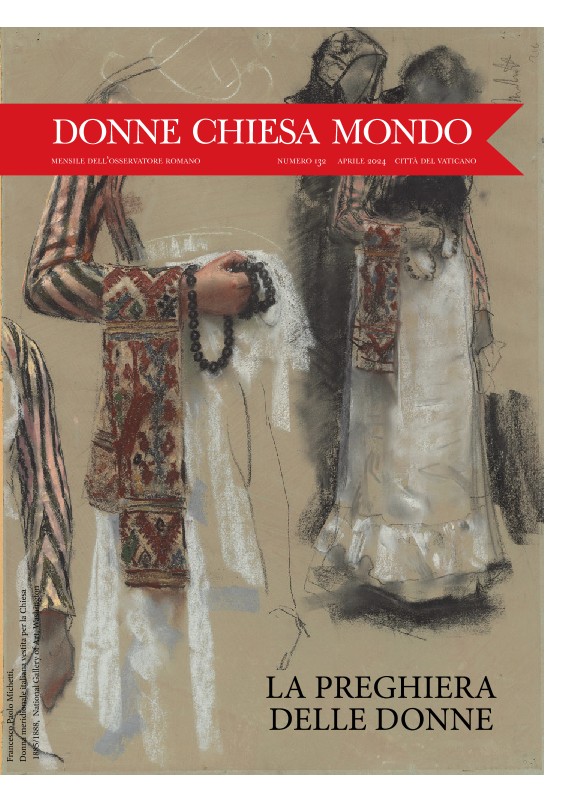LABORATORIO - DOPO LA PANDEMIA
Dalla produzione

Come la storia dell’umanità ci insegna, le crisi fungono spesso da setaccio. Separano il grano dalla pula, distinguendo cosa vale e cosa no. Il tempo che stiamo attraversando è in fondo anche questo: un momento di verità. Sono giorni drammatici, quelli del covid-19, ma anche benefici, in cui si aprono straordinarie possibilità per ridirsi, a livello personale come a livello collettivo, cosa desideriamo veramente, quale vita vogliamo vivere, cosa lasciar andare, su cosa, invece, investire. Domande potenti, che potrebbero avviare processi fino a oggi impensabili di rinnovamento. Del resto, aver avvertito collettivamente così vicina la morte e preso atto della nostra irrisolvibile fragilità e interdipendenza difficilmente può rimanere senza effetto. Potrebbe dunque essere questa l’ora per rientrare nuovamente in noi stessi, dopo aver vagato a lungo senza mete che meritano la nostra esistenza.
I re nudi di questo tempo sono numerosi. Tra questi, c’è il modello di sviluppo che negli ultimi decenni ha governato persone e sistemi. Guidato da un’idea illusoria di crescita come espansione senza limiti, questo grande progetto sociale si è fondato su meccanismi di estrazione di valore, assolutamente indifferenti alle sue devastanti conseguenze sui diversi ecosistemi umano, sociale, ambientale, economico. Un pensiero potente, planetario, che si è tradotto via via in relazioni, forme sociali e istituzioni. Tra queste, una certa idea di impresa che Luciano Gallino ha ben descritto come “irresponsabile” proprio perché, al di là degli obblighi di legge, essa “suppone di non dover rispondere ad alcuna autorità pubblica e privata, né all’opinione pubblica, in merito alle conseguenze in campo economico, sociale e ambientale delle sue attività”. L’attività mineraria è quella che rende al meglio l’idea di estrazione. Nel racconto di Lewis Mumford, essa possiede un “animus distruttivo”, che depreda e impoverisce tutto attorno a sé, con “la sua crudele routine di fatica, il suo alone di miseria e di degradazione del paesaggio”. La logica estrattiva, del resto, è radicale. Non risparmia nulla, né il creato, né l’uomo e il suo lavoro, manipolato nell’anima, deprivato del senso. Lo scambio è forse sembrato equo, ma in realtà non lo è mai stato: nell’illusione di poter essere libero di conquistare la propria privatissima autorealizzazione attraverso l’accumulazione di cose, l’uomo contemporaneo ha aderito, non senza prezzo, a sempre nuovi culti fondati in realtà sul puro sfruttamento, dal mito della flessibilità a quello della prestazione. Le nuove psicopatologie legate alla sfera del lavoro sono lì a confermarlo.
In uno scenario dominato da modelli estrattivi, non sono mancate però realtà che hanno seguito logiche opposte, contributive. Sono le imprese “generative” riconoscibili per la loro capacità di prendersi cura di persone, beni, contesti, legami, e generare “più valore” di quanto ne consumano. A partire da un’idea relazionale e contestuale del loro essere e agire, queste esperienze hanno preso sul serio l’interdipendenza e l’hanno trasformata da punto di debolezza a segreto del loro successo.
Nonostante la grande varietà dei settori e dei territori di appartenenza e delle molteplicità di forme sociali — dal profit al no profit — le imprese “generative” condividono un mind set straordinariamente simile che si traduce in pratiche e politiche a loro volta “generative” di valore per molti stakeholder.
Anzitutto la focalizzazione su uno scopo alto, di contribuzione al “miglioramento del mondo”, che orienta e sostiene il loro impegno. Concretamente, ciò significa promuovere processi di generazione di multiforme valore — economico, ma anche sociale, culturale, relazionale, fiduciario, di innovazione — invece di massimizzare, esclusivamente per sé, concentrandolo, il risultato finanziario. Gli incontri avuti in questi anni testimoniano la sorprendente vitalità di queste imprese che definiscono il profitto un parametro del proprio ben fare, più che il fine della loro esistenza.
Emerge, qui, una precisa idea di crescita che non corrisponde a un incremento puramente quantitativo, nelle dimensioni come nei risultati numerici, ma nella fioritura dei diversi capitali a disposizione dell’impresa, umano, ambientale, economico, sociale, di innovazione. Un imprenditore del settore della progettazione urbanistica sintetizza molto bene il punto: «Si può crescere come i fagioli o come le querce. Noi abbiamo scelto questo tipo di crescita più lenta, ma più solida». Essere solidi significa scegliere di durare nel tempo, piuttosto che cadere nelle trappola del breve termine.
Avere chiaro dove si va e dove si può andare genera anche un senso di fiducia che stabilizza un patto nuovo tra le persone che fanno l’impresa, la quale si rivela per quello che è: un bene in comune. Una prospettiva di lavoro fortemente condivisa dagli imprenditori generativi. La logica che li guida è quella di mobilitare e liberare energie diffuse verso il raggiungimento di obiettivi condivisi, piuttosto che “occupare spazi”. È un gioco win-win, circolare ed espansivo, che promuove la crescita di tutti, dentro e fuori l’organizzazione. Riconoscendone l’unicità e l’apporto originale all’impresa, quest’ultima riconosce e conferma gli altri “autori” della loro stessa esistenza, “autorizzandoli”, dunque, ad iniziare, a loro volta, cose nuove. È una relazione maieutica, che risveglia e libera la libertà di tutti, ampliandone il potere di agire dentro un quadro di reciproche appartenenze e responsabilità.
«La nostra impresa è anzitutto un’esperienza umana», conferma il fondatore di un’azienda del settore meccanico. «Come imprenditori ci dobbiamo occupare dei nostri uomini in quanto loro ci hanno dato fiducia in una delega sottoscritta tacitamente. È da qui che si sviluppa un grande senso di responsabilità di creare un ambiente dove ogni mattina ritrovi il profumo che vuoi sentire».
L’impresa diventa il contesto in cui si riveste di nuova dignità anche il lavoro, ogni lavoro, il quale ritorna a essere quello che è, ma che abbiamo dimenticato: luogo della piena realizzazione di ciascuno e di tutti, un “mettere al mondo” creativo e produttivo di altro — un prodotto, un servizio, un progetto — in una relazione d’alleanza con altri, colleghi, fornitori, clienti, soci, la comunità territoriale. Nell’impresa generativa, la riscoperta del valore del lavoro è inevitabilmente anche quella dell’uomo che lavora. In un movimento fecondo, alimentato da una spinta non prestativa e neppure utilitaristica, ma antropologica, riemerge una grande verità: che l’uomo esiste, cresce e fiorisce in quella aspirazione al fare di ogni cosa un capolavoro. «Per fare cose grandiose, non ci vuole un grande numero di persone. Ci vogliono persone di valore. Persone grandi!», racconta un artigiano del settore dell’arredamento che ha cercato di prendere sul serio due grandi nodi ancora scoperti, quello del senso del lavoro e quello dei luoghi in cui è possibile accompagnare, in una formazione integrale dell’umano, i lavoratori di domani.
In questa tensione a ricomporre obiettivi funzionali, spinta etica e desiderio estetico, nelle imprese generative la qualità si conferma sempre superiore alla quantità. È un “fare bene” capace di ispirare altri per la coerenza che il prodotto racconta tra mani, testa e cuore, bellezza ed efficienza. Come non “com-muoversi”, come non essere toccato dentro, nel godere di un oggetto “ben fatto”?
In una nuova armonia e coerenza con sé stessi e il mondo, ecco che tutto si scopre relazione e in relazione: produttore, prodotto, processo e territorio. Un unico ecosistema al quale tutti sono chiamati a sentirsi nuovamente parte e a contribuire in modo originale e unico.
La relazione di reciprocità con il contesto è un altro elemento che contraddistingue le realtà generative. «È una relazione di scambio. Tu ricevi le risorse umane del territorio, ma devi rilasciare altro, ricchezza, benessere e cultura d’impresa che può essere di esempio per altri», conferma un altro imprenditore. In questo senso, le imprese generative incarnano una verità sempre più evidente: non esiste vero sviluppo economico laddove non si investa con convinzione anche su una fioritura umana e sociale. Non si tratta di piani distinti. Le realtà generative testimoniamo come il successo dell’impresa dipenda proprio dalla capacità di intrecciare obiettivi economici, sociali e perfino culturali. Fondamentale è l’investimento su una nuova narrazione di futuro: sono tante e sorprendenti le azioni messe in atto per sensibilizzare, informare, educare attorno a una visione più elevata, equa e sostenibile, di economia e società, contribuendo così a orientare l’agire collettivo attraverso la promozione dei nuovi valori che sottendono cosa è valore: la salubrità dei prodotti, ad esempio, l’attenzione all’ambiente o l’inclusione sociale.
Le imprese generative non sono una maggioranza. Esse però costituiscono un’avanguardia a cui guardare in questo momento di transizione per lasciarci definitivamente alle spalle le contraddizioni del modello di sviluppo precedente, che oggi, anche alla luce dell’esperienza del covid-19, non possiamo più permetterci di replicare acriticamente.
Potrebbe dunque aprirsi la possibilità inaspettata di rimettere in asse la funzione e il senso, la libertà e l’appartenenza, la realizzazione personale e quella collettiva, portando a compimento un traghettamento capace di riavviare una nuova fase di crescita, una nuova prosperità: quello dalla “produzione” alla “generazione”.
L’impresa potrebbe essere uno dei luoghi di questa rigenerazione collettiva: spazio per un “di più di vita”, luogo in cui autorizzarsi a vicenda a un nuovo incominciare, grazie a una ritrovata dignità del lavoro ben fatto e di un nuovo senso, energia per il nostro domani.
Anche alla luce del covid-19 diventa difficile aspirare a qualcosa di meno.
di Patrizia Cappelletti
Ricercatrice presso il Dipartimento di Sociologia, Università Cattolica di Milano, coordinatrice dell’Archivio della generatività sociale