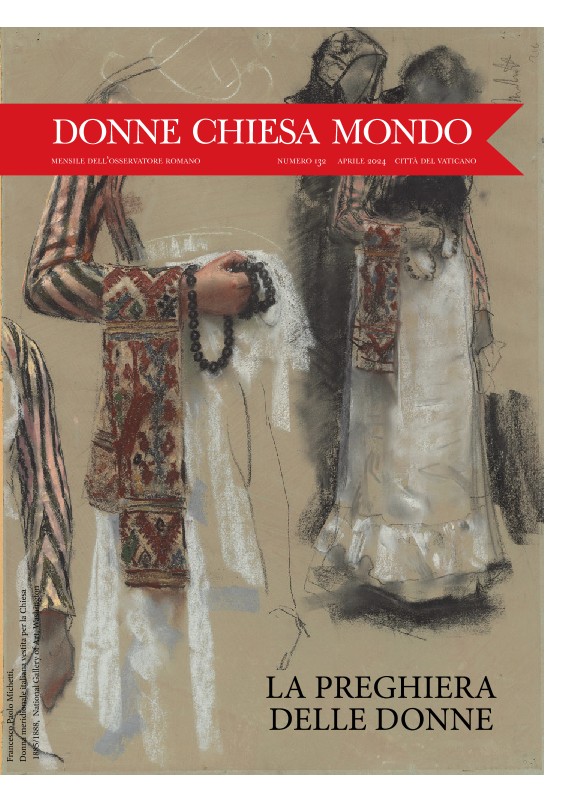In questo anno di celebrazioni e ricorrenze particolari per il mondo dell’arte (Raffaello, Tiepolo, Piranesi...), cade anche l’anniversario della fondazione di uno dei più importanti e celebrati musei del mondo: il Metropolitan di New York, istituito il 13 aprile del 1870. Oggi la collezione permanente del Met conta circa un milione e mezzo di opere; viene visitata da circa 7 milioni di persone l’anno (dati del 2019) e gestisce un sito web che totalizza fino a 30 milioni di accessi ogni dodici mesi.
È davvero sorprendente immaginare che un’istituzione così prestigiosa e imponente, per ampiezza delle collezioni, per estensione fisica, popolarità e dinamismo, sia nata a fine Ottocento per iniziativa di un piccolo gruppo di privati cittadini, facoltosi imprenditori ben decisi a dotare New York di un proprio museo, a imitazione delle città del vecchio continente. Fu per orgoglio e senso della sfida che quegli intraprendenti signori decisero di impegnarsi in una tale avventura, partendo praticamente dal nulla, senza neppure un nucleo adeguato di professionisti cui potersi affidare. (Il primo direttore del Metropolitan fu — dal 1879 al 1904 — Luigi Palma di Cesnola, un avventuriero piemontese che aveva combattuto, spesso con onore, in una quantità di scenari di battaglia, tra cui la prima guerra d’indipendenza italiana e la guerra di secessione statunitense e che, durante gli anni trascorsi a Cipro come console americano si era cimentato in quello che per molti era divenuto il “business” degli scavi archeologici).
Le finalità del progetto erano ben definite nell’atto di nascita dell’istituzione: «Istituire e mantenere nella città di New York un museo e una biblioteca d’Arte per incoraggiare e sviluppare lo studio delle Belle Arti, per insegnare l’applicazione di esse alle industrie, alle manifatture e ai mestieri, per giovare alla cultura generale e, finalmente, per istruzione e diletto del popolo». Due questioni erano poste al centro dell’ambiziosa avventura: il rapporto tra arte e industria — secondo un approccio chiaramente desunto dal modello del Victoria and Albert Museum di Londra (allora noto come South Kensington Museum) — e la missione educativa, volta a diffondere presso i cittadini sensibilità estetica e affezione verso il patrimonio. La prospettiva di concretezza e l’afflato etico che ispirano i fondatori del Met si riscontra nella visione che anima gli altri musei nati in America in questi anni: primi fra tutti il Museum of Fine Arts di Boston e l’Art Institute di Chicago.
Il collegamento con il mondo produttivo rispondeva certamente alla dimensione pratica cui erano avvezzi questi uomini di affari, ma soprattutto rispecchiava la necessità di adottare una tipologia museale con cui un Paese giovane, quale erano gli Stati Uniti, potesse cimentarsi: non l’idea dunque delle allora inarrivabili collezioni della vecchia Europa, piene di antichità e di capolavori degli antichi maestri dell’età rinascimentale e barocca, bensì una dimensione più a portata di mano, quelle arti decorative che al tempo stesso potevano ispirare e nobilitare l’industria manifatturiera.
Il fattore educativo accompagna sin dai primi passi l’azione del Metropolitan: già nel 1880 viene aperta una scuola d’arte rivolta agli operai di ogni settore produttivo; dal 1892, grazie al finanziamento di uno dei suoi più generosi mecenati, l’industriale dello zucchero Henry Osborne Havemeyer (1847-1907), il Museo avvia aperture domenicali che consentono a persone di ogni fascia sociale di accedere alle sue raccolte; laboratori educativi (study rooms) vengono attivati per favorire la conoscenza diretta dei manufatti. Tra i settori più sensibili a questo rapporto con il pubblico, si distinguerà prestissimo quello della Grafica (oggi uno dei più importanti al mondo). Il suo curatore, il giovane e determinato William M. Ivins Jr. (1881-1961), era un convinto sostenitore della missione educativa del museo e riteneva fondamentale che il suo particolare reparto vi si dedicasse con eccezionale energia. Se le altre opere potevano essere esposte e fruite liberamente dai visitatori, le preziose carte del dipartimento grafico erano destinate a rimanere chiuse nelle cartelle e nei raccoglitori predisposti a custodirle. Apposite sessioni educative vennero pertanto concepite per facilitare la comprensione delle tecniche, delle iconografie di stampe e disegni di rara bellezza: opere di Michelangelo, Durer, Rembrandt.
Un approccio di modernità straordinaria, che ancora stupisce per lungimiranza e dedizione al pubblico. In merito alla funzione del museo, Ivins affermava che essa deve essere «distintamente e inevitabilmente educativa»; il suo compito non è semplicemente quello di rendere le collezioni accessibili ma anche quello di aiutare le persone a fruirne, facilitando il dialogo e il confronto. L’arte deve essere compresa anche come ponte tra le generazioni, all’insegna di un valore di umanità che ci congiunge attraverso i secoli.
Con l’arrivo a New York del nuovo curatore del dipartimento di Arti Decorative, William R. Valentiner (1880-1958), la questione dell’esperienza di visita divenne centrale e strategica. Valentiner era il più talentuoso e fidato allievo del grande Wilhem von Bode (1845-1929), il direttore generale dei Musei di Berlino, straordinario conoscitore e storico dell’arte, esperto di pittura fiamminga e olandese. Bode aveva avviato, presso il Kaiser Friedrich Museum, dei veri e propri allestimenti «contestuali»: ambienti immersivi che abbinavano alle opere d’arte arredi e suppellettili appartenenti alla stessa epoca, secondo una logica di coerenza espositiva e soprattutto di capacità evocativa. Si trattava di veri e propri contesti di ricostruzione storico-culturale capaci di proiettare il visitatore verso un’esperienza totalizzante, di intenso coinvolgimento estetico ed emotivo. Seguendo il metodo di Bode, Valentiner avviò presso il Metropolitan la pratica delle cosiddette period rooms: una tipologia di allestimento che ebbe grande successo negli Stati Uniti e che presso il Met divenne quasi una sigla identitaria, non esente tuttavia da critiche e perplessità rispetto a talune scelte ricostruttive a volte troppo fantasiose e visionarie (tra queste, i celebri Cloisters). Il Museo si offriva come una sorta di macchina del tempo (un’espressione che ancora ricorre nella divulgazione del Met), in grado di proiettare il visitatore nel cubiculum di una villa pompeiana, in uno studiolo rinascimentale o in un salone rococò.
L’appassionante vicenda del Metropolitan — che si compone di vere e proprie avventure archeologiche, di scandali, di confronti pubblici sul senso del bello e sul valore della bellezza, di coraggiose iniziative volte a tutelare il patrimonio dell’umanità — si compone di un singolare intreccio tra uomini e arte. Lo stesso fenomeno di impressionante mecenatismo che ha reso possibile la costituzione di collezioni così straordinarie, fu motore trainante degli orientamenti di gusto e delle politiche di gestione del Met: per esempio nell’apertura verso gli artisti di metà e di fine Ottocento, come Courbet, Manet, Degas, Cezanne.
Con le sue contraddizioni e gli inevitabili errori (una storia fatta di uomini, abbiamo detto), è una bella pagina di civiltà quella che il Met, a 150 anni dalla sua fondazione, ci permette dunque di raccontare. Tra le ultime vicende di cui è stato protagonista vorremmo citare quella che lo ha visto in prima linea nel chiedere di salvare i Buddha di Bamiyan, presi a cannonate dagli integralisti, o la restituzione all’Italia del preziosissimo cratere di Eufronio, capolavoro della ceramografia attica a figure rosse (515 avanti Cristo), finito nelle collezioni del Metropolitan attraverso i canali illeciti del mercato antiquario. Un grande museo deve saper correggere i propri errori e impegnare la propria autorevolezza nel sostenere battaglie utili a migliorare il mondo.
In linea con un movimento sempre più popolare che sostiene il valore della “non neutralità” dei musei (cioè dell’importanza che le grandi istituzioni culturali prendano posizione di fronte alle grandi questioni etiche del nostro tempo), nel 2019 il Met ha ospitato — nell’ambito di una campagna promossa dall’associazione umanitaria International Rescue Committee — una singolare iniziativa dedicata alla difesa dei diritti dei rifugiati. Il titolo della mostra era Come sarebbero le pareti del Met se non ci fossero i rifugiati?. Opere di Chagall, Beckmann, Ernst, Piet Mondrian, Rothko e di altri grandi artisti sono state “oscurate”, coperte da tele e accompagnate dalla scritta «realizzato da un rifugiato». Viene da dire... “come sarebbe il nostro mondo senza i Musei?”.
di Irene Baldriga